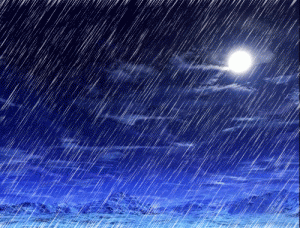Riccardo Bellofiore: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere
Riccardo Bellofiore è un economista dell’Università di Bergamo
Come hanno detto i relatori che mi hanno preceduto, la situazione in cui viviamo è una situazione invernale, gelida. Penso che alcuni di voi, certamente i più anziani come me, abbiano visto il film Frankenstein Junior e quindi si ricorderanno la scena in cui il giovane Frankenstein e il gobbo Igor vanno a scavare in un cimitero per esumare il cadavere del mostro e Frankenstein jr dice “che lavoro schifoso” e Igor risponde “potrebbe andare peggio”. Frankenstein jr chiede “come?” e Igor risponde “potrebbe piovere”. Subito si sentono tuoni e inizia una pioggia violenta. Questa è la situazione in cui sono convinto da tempo che ci troviamo a vivere. E in effetti ho intitolato “Potrebbe piovere” uno scritto ormai di due dicembre fa firmato con Joseph Halevi.
Cercherò di rispondere alle sollecitazioni avanzate da Raparelli e Casarini, oltre che dai relatori che mi hanno preceduto. Non è facile da farsi in così breve tempo. Cercherò sostanzialmente di svolgere tre argomenti, dandovi soltanto una sorta di schema di un ragionamento possibile. Primo: cercherò di chiedermi in che tipo di crisi del capitalismo globale ci troviamo, e su questo sarò veramente telegrafico. Dopo, cercherò di discutere dell’euro, dell’euro così come si è costruito nella realtà, non come spesso ce lo raccontiamo, e del tipo di crisi dell’euro e dell’Europa che viviamo adesso. In terzo luogo, cercherò di entrare nel terreno di discussione, complicato, delle possibili politiche economiche, e di qui svolgerò alcune considerazioni politiche. Sarò estremamente schematico. Chi fosse interessato trova lo sviluppo del ragionamento in due libretti che ho pubblicato recentemente [n.d.r. La crisi capitalistica, la barbarie che avanza e La crisi globale, l’Europa, l’euro, la sinistra, editi entrambi da Asterios, Trieste, nel 2012].
Mi capiterà di incrociare argomenti che non sono solo a questo tavolo ma che sono anche abituali nelle discussioni della sinistra … Non sono abituato a fare nomi, ma a fare cognomi, quindi spero che nessuno se la prenda. E inizierò dicendo che sostanzialmente a sinistra due mi sembra che siano le interpretazioni della crisi più diffuse. La prima è quella marxista ‘ortodossa’: vivremmo l’ennesima manifestazione della caduta tendenziale del saggio di profitto nella forma classica consegnataci dalla tradizione. In Italia chi ha sostenuto questa tesi con più rigore è Vladimiro Giacchè: uno degli interpreti più interessanti sia di questo filone che della crisi attuale più in generale. L’altra interpretazione che vi ricordo è un’interpretazione che sta all’incrocio delle problematiche keynesiane e conflittualiste/neoricardiane – una lettura a mio avviso più keynesiana e neoricardiana che marxista, in realtà. Mi riferisco la all’idea che noi vivremmo la crisi di ‘un mondo di bassi salari’. E’ a ben vedere un’interpretazione sottoconsumista. L’interprete migliore di questa linea in Italia è probabilmente Emiliano Brancaccio.
Sia l’una che l’altra lettura della crisi sostanzialmente interpretano gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, fino alla crisi dal 2007 in poi, come la crisi di un capitalismo ‘stagnazionista’, intrappolato nella stagnazione da decenni. Credo che questo sia riduttivo, e in verità probabilmente falso. Ci sono state grandi ondate di cambiamento su scala globale, viviamo la crisi di un capitalismo dagli aspetti fortemente dinamici. Questo non nega che nel mondo ci siano state aree del capitalismo sviluppato, in parte l’Europa, e senz’altro il Giappone, che hanno avuto decenni di stagnazione, in particolare dagli inizi degli anni ‘90. Il mio atteggiamento è piuttosto di capire le contraddizioni di questo capitalismo, del capitalismo che è stato chiamato troppo genericamente un capitalismo ‘neoliberista’, e dagli economisti borghesi come il capitalismo della Grande Moderazione. Voglio capire le contraddizioni specifiche di questo capitalismo, le ragioni della sua crisi, non del capitalismo in generale. Peraltro penso che su questo Christian Marazzi possa essere d’accordo con me, cioè che si debba tenere conto del fatto che il capitalismo che abbiamo alle spalle (almeno dagli anni ’80 in poi) è stato trainato dalla finanza, e che sia stato un capitalismo con capacità di creazione di consenso, di creazione di ricchezza, di creazione di rendita. Semmai, rispetto all’interpretazione di Christian Marazzi quale lui l’ha disegnata con grande intelligenza prima della crisi recente, penso che lui, come molti, abbia forse sovrastimato la sostenibilità nel tempo di questo capitalismo, penso in particolare al suo libro edito da Bollati Boringhieri qualche anno fa, Il denaro va.
Appunto: che tipo di capitalismo è stato? Anche se la ridurrò a poche frasi, devo prenderla da molto lontano, dalla fine dell’800. Il capitalismo attraversa delle ‘grandi crisi’, delle crisi ‘sistemiche’ (che non sono certo il ‘crollo’). A fine ‘800 ha vissuto quella che quando studiavo veniva detta la Grande Depressione (e oggi come la Lunga Depressione). Quella crisi, in effetti, si spiega benissimo con la caduta tendenziale del saggio di profitto, proprio secondo la teoria di Marx, cioè come dovuta all’aumento della composizione di capitale. Negli anni ’30 del ‘900 ha poi vissuto una crisi tipica da mancata ‘realizzazione’ del plusvalore, quella che riduttivamente viene descritta come una crisi da ‘sottoconsumo’, la crisi che John Kenneth Galbraith ha descritto in un libro meritatamente famoso come il Grande Crollo.
Negli anni ’70 del secolo scorso è molto più complicato ridurre ad uno le cause della crisi (lo è sempre, in verità, ma in questo caso ancora di più). E’ però mia convinzione che quella crisi – che ha origine un po’ prima, alla metà degli anni ’60 – abbia avuto come suo fattore centrale le lotte. Le lotte operaie, certo, di resistenza all’aumento dello sfruttamento: e che per qualche anno sono state in grado di far crescere il ‘salario relativo’. Ma accanto alle lotte del lavoro, le lotte delle donne, l’emergere prepotente di una questione della natura (quella che oggi viene detta, di nuovo riduttivamente, la questione ‘ambientale’). Le lotte contro l’autoritarismo, nella scuola e nell’università, le lotte nella ‘società civile’ (per proseguire con le espressioni riduttive!).
Il capitalismo successivo è stato una risposta a questa barriera posta dalle lotte, una risposta ad un attacco dal basso (non semplicemente un ‘complotto’ dall’alto), che si è mossa su due gambe. Una delle due gambe la chiamo ‘centralizzazione senza concentrazione’. Per capirci alla svelta, fatemi richiamare la lucida analisi di Luciano Gallino. Non è più vero che le imprese crescano dimensionalmente in modo lineare, nei vecchi termini di una integrazione verticale sempre maggiore. Non viviamo più – se non in casi certo significativi ma non universali – una situazione in cui i lavoratori sono occupati in sempre maggiore quantità sotto lo stesso padrone, nello stesso luogo, nelle medesime condizioni sindacali, sotto lo stesso contratto: maturando così le condizioni potenziali di una sempre maggiore forza, per una sempre maggiore omogeneità ‘materiale’. Quindi non c’è marxianamente ‘concentrazione’ del capitale. Ma c’è sempre maggiore ‘centralizzazione’ del capitale. Non è evidentemente un capitalismo che torna alla ‘vecchia’ piccola impresa. È semmai un capitalismo organizzato in ‘reti’, lungo filiere transnazionali.
L’altra gamba è quella che chiamo ‘sussunzione reale del lavoro alla finanza’. L’inclusione dentro le dinamiche della finanza in senso lato: il debito nei confronti delle banche, e prima ancora i mercati azionari. E’ una inclusione delle famiglie, prima delle classi medie (che coinvolgono largamente il mondo del lavoro), poi delle classi povere. C’è evidentemente una dimensione distributiva che dovrei tenere in conto, ma il punto chiave è che lo stesso mondo del lavoro salariato, e del lavoro dipendente dal capitale, è incluso in forma subordinata dentro il capitale. E’ qualche cosa di sconvolgente dal punto di vista dei rapporti di classe. Ed è qualcosa, non nascondiamocelo, che è stato in grado di creare consenso. Un consenso e un falso senso di ‘sicurezza’ (meglio, di risposta alla crescita di incertezza) che ha fatto leva su una serie di meccanismi che hanno portato ad un prolungato aumento dei prezzi delle ‘attività’ nei mercati finanziari, proprio quando i salari per i più erano invece bloccati (in senso relativo, senz’altro; in senso reale, spesso). E’ questa capital asset inflation una determinante chiave dello sviluppo del capitalismo anglosassone – in primis evidentemente gli Stati Uniti – che ha fornito gli sbocchi per i capitalismi cosiddetti ‘neomercantilisti’ (la Germania, parte del capitalismo europeo, parte della stessa Italia, il Giappone, i paesi dell’est asiatico e la Cina: anche se quest’ultima è un fenomeno parzialmente diverso).
Una forma del capitalismo che paradossalmente si è presentato con la parvenza di una sempre maggiore stabilità (la Grande Moderazione, appunto). E però era un capitalismo alla lunga ‘insostenibile’. E per ragioni che abbiamo indicato tempestivamente, ben prima della stessa crisi scoppiata nel 2007; e ancor prima della crisi del 2000-01 (nel mio caso, mi basta rimandare agli articoli sulla rivista del manifesto, e più in generale agli scritti della seconda metà degli anni ’90 del secolo scorso). Un capitalismo che per queste ragioni è saltato in aria. Non è saltato in aria, badate, con la bancarotta della Lehman Brothers nel settembre del 2008. E’ saltato in aria con la crisi dei subprime nel 2007, una crisi annunciata, almeno da quando erano iniziati a crollare negli Stati Uniti i prezzi delle case.
Possiamo ora passare a considerare l’Europa. La crisi europea – per una volta! – è una crisi non endogena, è una crisi ‘importata’. Non è dovuta in prima battuta all’euro. Non è neppure dovuta al debito pubblico. E’ dovuta semmai all’esplosione del debito privato, fuori e dentro l’Europa. L’hanno già detto qui, se ricordo bene, sia Raparelli che Casarini. Questo non significa che io non sia assolutamente d’accordo, e lo voglio dire subito, con la tesi che ha presentato qui Klaus Busch, secondo la quale non è stata una grande idea quella della moneta unica.
Qui però c’è preliminarmente da avvertire su un problema terminologico. Credo di nuovo che su questo Christian Marazzi e io ci intendiamo. L’euro è una ‘moneta unica’ in quanto è tanto moneta delle banche centrali aderenti all’euro quanto moneta effettivamente circolante. In Europa siamo ormai con un tasso di cambio irrevocabilmente fissato all’origine dell’euro. ‘Moneta comune’ è il termine che ha usato Klaus Busch. Ma ‘moneta comune’ lo uso nei miei scritti per intendere un’altra cosa (come fa una parte della letteratura), che configura una strada non presa dall’Europa negli anni ’90. Mi riferisco ad una proposta avanzata da Suzanne de Brunhoff e da altri, tra cui chi vi parla. E’ una cosa di cui ci ha parlato anche Christian Marazzi, e appunto ne scrissi anche io allora. L’idea era quella di avere una moneta comune, una moneta comune alle banche centrali europee, secondo un accordo di cambio fisso (magari per fasce non strette), e aggiustabili. Non, dunque, una moneta circolante. Ovviamente, l’idea riporta al progetto di Keynes nel 1944 a Bretton Woods. E, esattamente come quel progetto, richiederebbe di essere coordinato con altre politiche: politiche fiscali, politiche commerciali, politiche di aggiustamento simmetrico degli squilibri nelle bilance di partite correnti, ecc.. Questa via però non è stata presa. La via che è stata presa è un via che si sapeva che avrebbe condotto al disastro.
Da quando lo sapevamo? Beh, almeno dall’inizio degli anni ’90. Le contraddizioni per le quali l’euro avrebbe portato a divergenza reali sempre più marcate, si conoscevano bene. Le ragioni erano squadernate, per così dire, in letteratura: e neanche nella letteratura granché radicale o eterodossa in economia. Chiunque conoscesse la storia e la concretezza delle industrie, e della struttura reale più in generale, dei vari paesi europei, sapeva bene che una convergenza puramente nominale avrebbe condotto ad una divergenza reale. Non possiamo però fermarci a questa considerazione. Dobbiamo chiederci come mai l’euro lo si sia fatto comunque, alla fine degli anni ‘90, e come mai per dieci anni dopo la sua nascita sia apparso a quasi tutti un esperimento di successo.
La storia che normalmente ci viene raccontata, in particolate a sinistra, è che l’euro sarebbe figlio del Trattato di Maastricht del 1992, e che il Trattato di Maastricht con tutte le politiche contro il lavoro ecc., nascerebbe dal collasso del socialismo reale, e dal crollo dell’Unione Sovietica. Non voglio certo sottostimare quell’evento, ma – per dirla tutta – secondo me non c’entra niente. Il Trattato di Maastricht, quel progetto di unificazione monetariaeuropea, nasce prima della caduta del muro, prima della fine dell’URSS. Nasce nel 1988, e ha le sue radici ben prima. E’ un progetto essenzialmente francese, con una Germania, nano politico ma gigante economico, che però governa la moneta europea. La Francia è, o meglio si sente, si pretende, un gigante politico, in qualche maniera aveva anche le armi, la force de frappe, e voleva mettere le mani anche sul governo della moneta europea. Nella concezione originaria – che non si è realizzata, perché la Thatcher non c’è stata, e dopo l’uscita dal Sistema Monetario Europeo quel paese si è ben guardato dal rientrare nel progetto – la Gran Bretagna copriva il lato del mercato finanziario.
Questa idea non poteva che saltare in aria definitivamente tra il 1990-91, esattamente in conseguenza del crollo del muro, perché ne era saltato il presupposti geopolitico. Un fattore cruciale fu anche che la riunificazione delle due Germanie comportò un drastico aumento del tasso di interesse in quel paese, per finanziare la ricostruzione (Kohl si guardò bene dal farlo via aumento delle imposte), e ciò fece esplodere lo SME nel 1992-93. A quel punto, di una possibile moneta unica europea, sembrava proprio non se ne dovesse parlare più, e i tedeschi in realtà non la volevano. A loro interessava un’area del marco allargata ai ‘satelliti’: forse, e sottolineo il forse, allargata anche alla Francia. I tedeschi erano stati costretti al Trattato di Maastricht e avevano chiesto un prezzo elevato: “volete mettere le mani sul governo della moneta in Europa? In cambio mi date i famosi parametri, su tassi di interesse, inflazione, e soprattutto finanza pubblica”.
Una volta saltato il tutto in aria, quando è che rinasce, come e perché? Rinasce a metà anni ’90 perché – sottolineo: per ragioni di nuovo esterne all’Europa – cadono i tassi d’interesse, l’economia americana accelera, e noi siamo un po’ trascinati. I tedeschi, l’economia tedesca, sono però in difficoltà. Quello è il decennio, tutti se lo dimenticano, in cui la posizione esterna della Germania non è affatto in attivo, torna in attivo dopo, negli anni zero del nuovo millennio. Intanto si fanno le ristrutturazioni. In questo contesto la Germania è in qualche modo di nuovo costretta a un progetto di unificazione monetaria (anche perché sono gli altri a rispettare i, o convergere sui, parametri che ha voluto, mentre lei stessa non li rispetta del tutto!)- E chiede di nuovo qualcosa in cambio. Il prezzo è il Patto cosiddetto ‘di stabilità e crescita’, siglato a Amsterdam e Dublino. A questo punto l’euro si fa davvero, tra il 1999 e il 2001-02. Come mai le contraddizioni non esplodono subito? L’ha detto bene Casarini, ed è stato poi ribadito da altri. L’euro è stato ciò che in Europa ha, in forma diversa, attivato un meccanismo simile al meccanismo dei subprime negli Stati Uniti. I tassi d’interesse si sono abbattuti un po’ dappertutto (perché sono caduti i premi di rischio). Sono gli anni in cui gli altri paesi europei crescevano più della Germania: come dovrebbe essere, purtroppo non nei modi che potremmo auspicare. Il tutto salta in aria non per le contraddizioni dell’euro, salta perché salta il capitalismo anglosassone.
A questo punto togliamoci di mente anche un’altra cosa: che in Europa non si sia fatto niente di fronte alla crisi. Leggende della sinistra. Nel 2007, in verità, alcuni raccontavano che questa era una crisi ‘americana’, che c’era il delinking (lo ‘sganciamento’), che i BRIC contavano molto di più, e così via. E’ vero che ancora per un po’ l’Europa cresce, e dentro l’Europa crescono di più i paesi manifatturieri, la Germania cresce, l’Italia cresce. Con Joseph Halevi, in quel periodo, replicavamo disegnando una ‘caricatura’, che però poi si è rivelata non lontana dal vero: “ma intanto sta cadendo l’economia degli Stati Uniti, che domandano meno merci alla Cina, a sua volta la Cina domanda meno mezzi di produzione, non solo al Giappone ma anche alla stessa Germania, quindi la subfornitura italiana anch’essa esporta di meno in Germania. Se voi tenete conto di tutte le interconnessioni, crolleranno anche i paesi europei, a partire da quelli più manifatturieri, Germania e Italia”. È successo proprio così meno di un anno dopo. Ma si è fatto qualcosa, eccome. Quello è stato il periodo in cui i tedeschi, la Germania, nonostante la sua retorica contro i disavanzi di bilancio, i disavanzi di bilancio li ha praticati, e con forza, e così anche la Francia. L’Italia anzi a suo modo, da questo punto di vista, è stata perversamente ‘virtuosa’, si è affidata solo agli stabilizzatori automatici, Germania e Francia hanno fatto politiche discrezionali e mirate. La Germania, per esempio, ha fatto politiche come quelle della ‘settimana corta’, la politica delle 20 ore di lavoro, per esempio alla Volkswagen ma non solo, finanziate dai lavoratori, ma anche dallo stato e dalle imprese, e così ha difeso l’occupazione. La Francia ha sovvenzionato l’auto, ma non con generiche rottamazioni, ma chiedendo alle imprese di rispettare certi standard.
Dopo il crollo di Lehmann Brothers e fino al marzo 2009 ci sono stati 6 mesi di autentico terrore a livello mondiale, nelle stesse classi dirigenti. Se questa fase si fosse prolungata sarebbe stato forse possibile un autentico cambiamento. Quello che è certo che dalla ricaduta in una crisi come quella degli anni ’30 del secolo scorso non ci hanno certo salvato le misure di Bush e Obama essenzialmente a favore della finanza, non ci hanno neanche salvato i maggiori disavanzi di bilancio di alcuni dei paesi europei, è stata semmai l’enorme politica ‘keynesiana’ di massiccio investimento infrastrutturale intrapreso dalla Cina, proprio tra fine 2008 e inizio 2009. Ci ha salvato dalla ricaduta nel Grande Crollo, non però da una Grande Recessione. Nella primavera del 2008, nel mondo e in Europa, si comincia a parlare di ‘germogli della ripresa’. In Europa viene allora a montare un attacco contro il debito pubblico, contro la spesa pubblica e il welfare, che è in realtà un approfondimento dell’attacco contro il mondo del lavoro e contro la sfera della riproduzione sociale. Questo investe immediatamente i lavoratori e le lavoratrici ma investe anche, altrettanto immediatamente e violentemente, le donne: perché l’attacco alla riproduzione sociale e l’attacco al welfare ricadono sulle donne più che su chiunque altro.
A proposito di questo lasciatemi soltanto dire, tra parentesi, che la retorica del movimento è un po’ arretrata rispetto a quella che è la sfida che abbiamo davanti. Credo sì che il capitalismo cerchi di uscire dalla crisi appropriandosi dei ‘beni comuni’, ma credo anche che sia un errore, un errore grave, definire il lavoro un bene comune. Qui il punto risale all’abc, alla teoria di Marx. I capitalisti hanno bisogno della forza lavoro, i capitalisti la vogliono per estrarre l’attività lavorativa che è la sorgente del valore e del plusvalore, ma la forza lavoro è ‘attaccata’ a degli esseri umani viventi. L’attività lavorativa non è un bene comune. Semmai tutto ciò ha più a che vedere con la scritta che c’era all’ingresso di Auschwitz “il lavoro rende liberi”, strana ironia, un lavoro da cui liberarsi, che non a una nostra attività di cui è necessaria una liberazione, una liberazione del lavoro (in cui continuo a credere). Non si può, non si deve fare confusione qui.
Il problema del capitale oggi, come in tutte le grandi crisi ‘sistemiche’, è quello di sfondare il più possibile sugli ambiti di elasticità del salario, delle condizioni lavorative, nell’attacco alla riproduzione sociale e al welfare, e dunque anche sulla contraddizione di genere. Lo faceva già prima, nella Grande Moderazione, figuriamoci cosa succede nella Grande Crisi che ne è seguita. Ci sarebbe qui da dire molto altro, ma lasciatemi ora passare molto velocemente alle condizioni della politica economica e dell’euro, perché il tempo stringe.
Sono molto d’accordo con i 5 punti sollevati da Klaus Busch. Penso, non so se qui ci sia una differenza con Christian Marazzi, che vadano presi tutti insieme. Se noi ne prendiamo uno solo, come dirò fra un attimo, nessuno basta. Penso che su ognuno di essi separatamente si possano avanzare obiezioni del tipo di quelle che ha fatto Christian Marazzi sulla proposta degli eurobond. Cercherò poi di tornare al tema del New Deal, che io piuttosto chiamerò del New Deal di classe, sollevato da Klaus Busch. Vorrei solo, prima di procedere oltre, chiarire bene che questa crisi è quella che l’economista giapponese della Nomura Richard Koo ci ricorda essere una balance sheet recession, una recessione che si esprime nella deflazione degli ‘stati patrimoniali’ di tutti gli agenti. Quando dal debito si cerca di uscire comprimendo la spesa, e di questo sono fatte le stesse politiche di austerità, tutto ciò non è una soluzione, anzi peggiora le cose, perché alla caduta della spesa segue che cadono i redditi, dopo cade ancora la spesa, dunque il reddito. In realtà vorresti uscire dal debito rispetto al reddito, ma in realtà il reddito ti cade, talora persino anche più velocemente. A quel punto tu devi svendere, semmai avessi delle ‘attività’. Ma quando tutti cercano di svendere le attività, il loro prezzo crolla.
Non è un paradosso astratto (tutti vogliono risparmiare sul reddito, ma succede il contrario), non è un esempio di scuola: è ciò che sta succedendo davvero. Si chiama ‘deflazione da debiti’, una espressione introdotta negli anni ’30 del secolo scorso da Irving Fisher. Se ne può uscire con un default, con un fallimento? Oppure con una ‘insolvenza’ sul debito pubblico”? Lasciatemi dire che qualunque sia la risposta alla seconda domanda, la risposta alla prima dovrebbe essere in Europa un netto ‘no’. Poi tornerò sul problema, ma non c’è alcuna ragione in Europa, perché nessuna delle crisi in sequenza che abbiamo visto, Grecia, Irlanda, Portogallo, debba dare luogo – per così dire, meccanicamente – ad un fallimento. La Grecia non è l’Argentina. Il problema della Grecia è un debito pubblico eccessivo nella sua moneta, perché la moneta della Grecia è l’euro (tralascio il paradosso, che capiamo visto quello che ho appena detto sulla balance sheet recession, che le supposte cure per ridurre il debito pubblico sul PIL lo hanno fatto in realtà esplodere). Sono le politiche della Banca Centrale Europea, e la cultura economica delle istituzioni europee, e il disegno istituzionale perverso della moneta unica, che trattano la Grecia come se fosse l’Argentina. Ma in questo, ribadisco, non c’è alcuna necessità, e non si può concedergliela in alcun modo.
Come si esce dalla crisi del debito? Se non vuoi la deflazione da debito, se il default lo vuoi evitare, e comunque in Europa non sarebbe necessario, se ne può uscire soltanto con lo sviluppo economico, da destra con politiche di crescita, oppure con le politiche di inflazione. E prima o poi se ne uscirà così, più facilmente da destra. Già subito dopo lo scoppio della crisi nell’estate del 2007 Martin Feldstein, ex consigliere di Bush e di Reagan, ha scritto “abbiamo bisogni sociali insoddisfatti: armi e sicurezza, per questo bisogna ritornare alla leva della spesa pubblica, anche in disavanzo. L’ex economista capo del Fondo Monetario Internazionale, Kenneth Rogoff, ha anche lui tempestivamente sostenuto da anni che serve un’inflazione almeno (almeno) dell’8%. Allora il problema che abbiamo di fronte è in realtà: quale motore dell’economia, quale crescita (meglio, quale sviluppo)? E se ci capiterà, come ci capiterà, un’inflazione con i redditi e i salari fissi, prima o poi. Queste politiche, ribadiscono, possono esserci da destra.
A questo punto arriviamo alle politiche economiche praticabili o sostenibili dalla sinistra. Le banche centrali devono agire come prestatori di ultima istanza? Evidentemente, sì. Ma questo non è affatto sufficiente a risolvere il tipo di crisi in cui ci troviamo. La crisi di un capitalismo dove c’era un motore della crescita di ultima istanza, che era il consumo a debito, gestito politicamente da quello che altrove ho chiamato un ‘keynesismo privatizzato’, e questo motore della crescita si è a un certo punto volatilizzato. Cosa mettiamo al suo posto? La Banca Centrale lender of last resort potrebbe impedire lo sfondamento verso il basso dei valori finanziari. La BCE non è però un prestatore di ultima istanza, in questo senso non è una vera banca centrale. Un attimo! Ma negli ultimi anni la BCE non ha fatto proprio questo? L’ha fatto in vie deviate, in vie indirette. Togliamoci però dalla testa che in Europa le istituzioni non siano cambiate, non stiano cambiando, e con un sistema istituzionale orrendamente fallato come quello dell’euro potevano e possono cambiare solo nel mezzo e in forza di una drammatica crisi Certo, sono cambiate troppo poco e soprattutto troppo tardi. I mutamenti accettati un anno dopo avrebbero risolto i problemi un anno prima, forse. Comunque, non c’è da aspettarsi troppo da quel lato, dal versante della politica monetaria.
Passiamo al lato della politica fiscale. I disavanzi dello Stato salvano? Beh, dipende, i disavanzi di bilancio salvano se sono voluti, se sono pianificati, non se sono il risultato automatico della crisi. Perché la cosa paradossale è che le politiche di austerità non ti fanno uscire dai disavanzi, ti ci fanno scivolare sempre più come nelle sabbie mobili. Gli eurobonds? Gli eurobonds da soli ricadono sotto la critica di Christian Marazzi, ma potrebbero essere legate a disavanzi buoni, pianificati, in vista della produzione di valori d’uso sociali un po’ diversi da quelli che ha in mente Feldstein, e con una Banca Centrale prestatore di ultima istanza. Ci sono poi le richieste di reddito, il basic income. Anche qui c’è molta confusione: spesso si parla di reddito di cittadinanza, o di reddito universale, o di reddito minimo, o di salario sociale, come se fossero la stessa cosa. Parlo qui invece di basic income nella forma, rigorosa, di allocazione universale di un reddito a chiunque. Credo che il basic income così inteso sia un modo, e un modo nient’affatto irragionevole, di organizzare un welfare universalistico.
Qualcuno forse si stupirà, ma sono stato uno dei primi che ha sollevato un’idea del genere nel 1993, in una rivista che trattava altre questioni, Bozze di Raniero La Valle, e feci qualche anni prima pubblicare in Italia uno scritto di Van Parijs con cui avevo dialogato e discusso a metà degli anni Ottanta a Leuven-la-Neuve. Non ne parlava nessuno da noi. Ora il problema però è il come questa idea viene presentata in Italia (e come pare averla assorbita, confusamente, una parte stessa del sindacato). Mi rifaccio qui alle critiche che Giovanna Vertova, del tutto a ragione, avanzò qualche anno fa, prima della crisi, sul manifesto, e a cui ci riagganciammo Halevi ed io. Una cosa è una proposta di basic income sulla base della convinzione (del tutto illusoria) che vivremmo in una fase di espansione quasi automatica della produttività sociale, per l’emergere di un ‘comune’ che esprimerebbe una spontanea cooperazione che si estenderebbe alla vita stessa in quanto tale: a quel punto, si può fantasticare che il basic income ti consentirebbe di scegliere tra lavoro e non lavoro, e retribuirebbe questa produttività del ‘comune’. Questa, insisto, mi sembra una illusione, molto pericolosa. C’è poi una seconda difficoltà, per così dire, sul piano pratico: il basic income viene prima proclamato ideologicamente come ‘incondizionato’, poi realisticamente lo si degrada a sussidio per i precari, come un passo in quella direzione. Nient’affatto. Si crea una dinamica, espressa in massimo grado nell’esperienza storica di Speenhamland (di cui parla Polanyi nella Grande Trasformazione: ma qualcosa del genere è già in Marx): quella dinamica per cui l’erogazione benintenzionata di un ‘sussidio’ che consente alle imprese di pagare retribuzioni più basse, nel tempo si trascina dietro al ribasso l’intera struttura dei salari, e finisce così col ritrasformare i lavoratori in mendicanti – tanto più quanto più la crisi morde, il sussidio stesso viene quindi abbassato, e ricadiamo in pieno nella critica precedente.
Un’altra cosa tutta diversa sarebbe il basic income come lo proposi nel pezzo su Bozze. Come parte di una ridefinizione del welfare in un progetto di sinistra dove la spesa pubblica e i disavanzi ‘buoni’ sono la condizione di quel pieno impiego con valori d’uso sociali che solo rende sostenibile quel progetto. Pieno impiego significa, sia chiaro, riduzione dell’orario di lavoro, ma lavoro per tutti. Il vecchio, ma ancora attuale, ‘lavorare meno, lavorare tutte e tutti’. E in quel progetto bene starebbe un obbligo di lavoro sociale per tutte e tutti nell’arco vitale.
Così arrivo alle ultime considerazioni. Sono abbastanza pessimista, tendo a stare dal lato di Klaus Busch. Cerco però di agire praticamente perché questo pessimismo sia smentito dalla realtà che cerco, con altre/i, di costruire. Credo che sia una precondizione essenziale perché le cose cambino in meglio è che ci sia una lotta dura e senza ambiguità contro qualsiasi politica di ‘austerità’, una lotta dura per reggere sul salario, una lotta dura per ottenere reddito. Queste sono però lotte difensive, anche se essenziali. La questione che però abbiamo di fronte è ben più seria, e ci si arriva partendo da Marx, come anche partendo da Hyman Minsky. Il nostro problema è quello di mettere in questione sia la composizione della produzione che la natura della produttività. A noi fanno una testa così sul rapporto debito pubblico/prodotto interno lordo e sul costo del lavoro per unità del prodotto. Quello che sta al denominatore, in entrambi i rapporti, ha a che vedere con cosa, come e quanto si produce. Non esiste sinistra, almeno nel mio senso della parola, se non si ha la pretesa, se non si ha l’ambizione, di intervenire sul denominatore, sulla produttività e sulla produzione. E non esiste uscita da sinistra, da questa crisi, che non sia legata alle lotte su questo terreno.
Sono, lo confesso, abbastanza colpito dal fatto che trovo molto più radicali i ragionamenti che leggo negli ultimi due capitoli finali del libro di Hyman Minsky Keynes e l’instabilità del capitalismo, del 1975 (edito da noi da Boringhieri), di qualsiasi cosa mi capiti di leggere, dovunque, di qualsiasi sinistra. In questo libro Minsky – nominando, tra l’altro ed esplicitamente il ‘socialismo’ – propone di una socializzazione dell’investimento molto più radicale di quella di Keynes, a cui affianca una socializzazione dell’occupazione, una socializzazione della banca e della finanza. Minsky non ha remore a criticare il keynesismo realizzato, un sistema che, sostiene, ha finito con il distruggere la natura, come l’equilibrio sociale, producendo una nuova crisi da cui se ne esce soltanto ponendo la questione di cosa e come si produce: usa praticamente la stessa terminologia che ho impiegato io. Alla sua espressione per cui lo Stato dovrebbe essere occupatore di ultima istanza, preferisco l’idea che è tipica di un certo sindacato italiano (ma anche di pensatori liberalsocialisti come Ernesto Rossi e Paolo Sylos Labini) di un Piano del Lavoro. Se lo Stato deve intervenire definendo, oltre il livello, anche la composizione della produzione, deve anche suscitare direttamente occupazione in quei settori (se questo stimolo pubblico si traduca necessariamente in nazionalizzazione è un’altra questione).
Come mai questo Minsky tira fuori queste idee? Perché è nato politicamente nel bel mezzo del New Deal, il New Deal di Roosevelt. Perché il New Deal era keynesiano, perché sosteneva i disavanzi dello Stato? No, questa è un’altra leggendo della sinistra italiana. Roosevelt era contro i disavanzi dello Stato. Roosevelt ha bloccato il New Deal nel 1937, perché s’è spaventato del debito pubblico che cresceva. Però, tra il 1933 e il 1937 è intervenuto con investimenti infrastrutturali – alcuni con l’ottica del dopo ci piaceranno, altri no – provvedendo direttamente occupazione. E perché ha potuto e ha dovuto farlo? Perché era incalzato da lotte dal basso: da un lato rispondeva alla crisi, ma dall’altro lato era tallonato da lotte della classe lavoratrice, e da un’intellettualità – non solo economica, anche giuridica, quella che sta dietro il Wagner Act; e da una intellettualità più in generale – che era in grado di pensare in avanti, che era dotata da quello che Musil chiamava il ‘senso della possibilità’. Non è il senso di un sognatore, che nega che esistano i vincoli, ma sa che si possono e si debbono ridefinire i vincoli.
Chiudo su questo con due, anzi tre osservazioni. La prima è che c’è un punto su cui non sono d’accordo con Minsky. I keynesiani, anche quelli più avanzati e progressisti come lui, pensano che in questo modo si crei un nuovo ‘equilibrio’, un capitalismo ‘buono’ (tra i 47 possibili di cui scherzava Minsky). No, tutto ciò, semmai avesse una traduzione nella realtà effettuale, creerebbe una situazione di ‘squilibrio’ che certo il capitalismo può subire, e che non tollerebbe per molto (così come Kalecki nel 1943 ammonì che un capitalismo di piena occupazione sarebbe stato possibile, ma non su base permanente). Questo mi porta alla seconda osservazione, che qualcuno riterrà un po’ contraddittoria. Si ottengono, delle riforme decenti soltanto se non si accettano i vincoli così come sono e quindi solo se si ha un atteggiamento ‘rivoluzionario’. Questo in genere non piace né ai riformisti, né ai rivoluzionari. Su questo, sul tema del cosa, come e quanto produrre, credo che si possa e debba trasversalmente discutere, in Italia e altrove, nella sinistra in generale: la separazione tra chi ha a tema le problematiche strutturali e chi si limita alle questioni distributive attraversa tutte le formazioni politiche e sindacali, e non è leggibile lungo l’asse moderati/radicali. La terza osservazione è che ci troviamo ormai di fronte il dispiegarsi di un capitalismo autoritario. Uno dei pochi maestri che ho avuto, Claudio Napoleoni, alla fine della sua vita, in una fase di cui non condivido tante cose, ha detto però una cosa giustissima. Il capitale è tendenzialmente autoritario, perché include dentro di sé la forza lavoro, facendone la rotella di un meccanismo, pretendendo che i lavoratori e le lavoratrici non abbiano voce, non siano soggetti ma solo ‘cose’. Al capitale, sosteneva, la democrazia viene ‘dall’esterno’.
Quali sono le prospettive della crisi? La crisi sarà lunga, la crisi sarà devastante. Se ne uscirà, se se ne uscirà, con il conflitto dal basso e con un intervento dall’alto, che richiederà un diverso intervento attivo da parte dello Stato. Ma questo può avvenire da destra. Il conflitto sociale già oggi si sta generalizzando come insorgenza reazionaria, che attraversa le classi popolari. Potrà fare da contraltare un intervento dello Stato, da destra, ripeto, di carattere autoritario, reazionario. Non sarà il vecchio fascismo. Monti è uno strano esperimento di transizione, che durerà quello che durerà. Per la prima volta un liberista vero, a tutto tondo. Non credo che il liberismo sia mai esistito davvero, ma lui è un professore, che nutre l’illusione che bastino un po’ di liberalizzazioni per fare partire la crescita: ma se verrà, verrà da fuori, e non se ne vede il come, per ora. Monti è parte di un movimento che, mantenendo formalmente il suffragio universale, sta creando le condizioni del ritorno di una democrazia censitaria. E sta dando i colpi definitivi allo smantellamento delle garanzie sul lavoro e del welfare.
Category: Osservatorio Europa