Simone Pieranni: Sfide e quesiti intorno al modello cinese
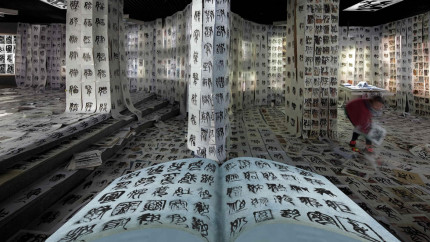
Diffondiamo da Il Manifesto del 4 febbraio 2022
*
Il presidente Xi Jinping e la commissione disciplinare del Partito comunista hanno sottolineato di recente la necessità di stroncare «l’espansione disordinata di capitale», con riferimento al mondo delle piattaforme cinesi divenute sempre più potenti e indipendenti nelle proprie strategie commerciali. Quella di Xi è una «rettificazione», che va – in teoria – di pari passo con il rilancio dell’espressione «prosperità comune» con la quale il Partito si pone come «riequilibratore» degli scompensi creati dalla turbolenta crescita cinese. Tra questi rientrano anche questioni legate al mondo del lavoro: tanto nel settore tecnologico, con il «sistema 996», quanto nella cosiddetta «fabbrica del mondo», laddove l’automazione rischia di covare nuove conflittualità che lo stretto controllo del Partito prova a sopire. In questo senso il recupero da parte del Partito di parole d’ordine confuciane che insistono sul «mantenimento della stabilità» costituisce uno degli elementi salienti dell’attuale società cinese.
ANALOGAMENTE, un’altra peculiarità della Cina nuova – e che risale ormai al 2013 – è il lancio della «One Belt One Road», la nuova via della Seta, con l’obiettivo di raggiungere in modo sempre più rapido ed efficiente nuovi mercati per il surplus manifatturiero cinese. Un progetto che – di pari passo con la crescita del processo di innovazione tecnologica – non poteva che finire per porsi in modo «concettuale» contro l’ordine mondiale propugnato, seppure in modo ambiguo e contrastante, dagli Usa. Due elementi, quello interno e quello esterno, che costituivano i punti di osservazione fondamentale nel libro di Giovanni Arrighi, Adam Smith a Pechino, pubblicato nel 2007 e riproposto ora da Mimesis (prefazione di Salvo Torre, postfazione di Andrea Fumagalli, pp. 532, euro 28). Arrighi, spiega Fumagalli, «sin dal primo periodo di ricerca dopo la laurea alla Bocconi si è sempre occupato di sviluppo e sottosviluppo e, insieme a Andre Gunder Frank, Immanuel Wallerstein e Terence Hopkins, è stato uno dei padri dell’approccio “sistemico” allo studio della storia e della struttura del capitalismo globale, dei movimenti sociali anticapitalistici, delle disuguaglianze mondiali di reddito e dei processi di modernizzazione. In tale quadro veniva evidenziata l’eterogeneità dei processi di sviluppo e la loro multipolarità».
Il punto di partenza di Arrighi sono gli anni ’80, durante i quali «gli Stati Uniti lanciarono un’aggressiva competizione sui mercati finanziari internazionali che prosciugò di colpo i canali di finanziamento del Terzo e del Secondo Mondo, provocando una forte contrazione della domanda per i loro prodotti su scala mondiale. Di colpo e con altrettanta rapidità di quanto aveva fatto, in senso contrario, negli anni ’70, il sistema dei prezzi del mercato internazionale virò in favore del Primo Mondo. Disorientato e disorganizzato dalle crescenti turbolenze dell’economia globale e stretto nella morsa di una nuova corsa agli armamenti, l’impero sovietico finì per disintegrarsi». Ma, specifica Arrighi, quello che avvenne non fu una «restaurazione», nonostante i tentativi americani di realizzare per la prima volta nella storia un «impero globale» (con la guerra in Iraq, ad esempio): «Alla diminuzione della potenza sovietica si era infatti accompagnato il crescere di quello che Bruce Cumings aveva battezzato l’“arcipelago capitalista” dell’Oriente asiatico». Ma le tigri asiatiche ruotavano bene o male intorno all’asse di Washington, finendo per dilaniarsi a seguito dei consigli americani, improntati alle terapie d’urto.
LE IMPLICAZIONI dell’ascesa della Cina – invece – «sono di estrema rilevanza. La Cina non è né uno Stato vassallo degli Usa, come il Giappone o Taiwan, né una semplice Città-Stato come Hong Kong o Singapore». Pechino si pone dunque fuori dal Washington consensus e proprio la scelta della dirigenza locale di riforme «graduali» indica la volontà di non accettare consigli economici che hanno già portato a fallimenti, ma di seguire una via nella quale mercato e controllo dello Stato (divenuto anche «morale» oltre che economico) costituiscono la complessità di un sistema che sembra porsi fuori da schemi interpretativi altrove funzionanti.
La tesi di fondo di Adam Smith a Pechino è perciò «che la sinergia fra il fallimento del “progetto per un nuovo secolo americano” e il successo cinese nel campo dello sviluppo economico sta rendendo l’intuizione di Smith di una società del mercato globale basata su una maggiore equità fra le diverse aree mondiali di civiltà più vicina alla realtà di quanto non lo sia mai stata nei quasi due secoli e mezzo trascorsi dalla pubblicazione della Ricchezza delle nazioni».
SECONDO ARRIGHI – dunque – la predizione di Smith sulla possibilità che si potesse creare un riequilibrio dei rapporti di forza tra Occidente e resto del mondo sulla base di una sorta di Commonwealth delle diverse culture «non era un’ipotesi peregrina – scrive Fumagalli -, a patto, tuttavia, che alcune condizioni venissero rispettate. Arrighi fa riferimento, in particolare, a due aspetti. In primo luogo, la capacità del governo cinese, in primo luogo del Partito comunista, di puntare su un efficace mix di “buona” concorrenza intercapitalistica, promozione della divisione sociale e non tecnica del lavoro, investimento nelle tecnologie capital-saving, valorizzazione di nuovi modelli di impresa (le cosiddette “imprese di municipalità e di villaggio”), governo “centralizzato” degli strumenti creditizi e monetari; un insieme di interventi che ha consentito alla Cina di attestarsi quasi sui livelli di ricchezza occidentali. In secondo luogo, la necessità di sviluppare una cooperazione internazionale in grado di garantire a Occidente come a Oriente uno sviluppo sostenibile (dal punto di vista ambientale e sociale), all’interno di un rispetto reciproco e multipolare. È necessario, cioè, rompere la dicotomia tra un’adesione troppo stretta da parte della Cina al modello di sviluppo occidentale ad alta intensità energetica, da un lato, e la pretesa statunitense di ridefinire un nuovo secolo americano all’insegna della sua egemonia politica, militare ed economica.
Il rischio per la Cina – avverte Arrighi – è di «portare il “miracolo economico” a una fine prematura a causa dell’insostenibile pressione su risorse scarse (comprese l’acqua potabile e l’aria pulita)» e l’ampliamento della frattura che si sta aprendo fra coloro che per la loro condizione hanno potuto godere dei benefici della rapida crescita economica e quelli che ne hanno dovuto solo sostenere i costi».
Sono esattamente le sfide sulle quali Arrighi, scomparso nel 2009, non si è potuto cimentare. Nonostante questo, come fa notare Sandro Mezzadra su Effimera «Quel che c’è di nuovo in Adam Smith a Pechino è l’enfasi posta sulla rilevanza, nel cruciale passaggio tra 700 e 800, del confronto dell’Occidente con l’Oriente, con l’India e soprattutto con la Cina. In quella congiuntura, secondo una tesi ripresa da storici come Kaoru Sugihara e Kenneth Pommeranz, si sarebbe delineata appunto in Oriente la possibilità di una “rivoluzione industriosa” diversa dalla “rivoluzione industriale”». Un percorso di sviluppo che, pur su basi di mercato, «non presenta alcuna tendenza intrinseca a imboccare la via ad alta intensità di capitale e di consumi energetici aperta dall’Inghilterra e pienamente sviluppata dagli Stati Uniti». Arrighi in sostanza, ritiene che in Cina «se il socialismo ha perso, il capitalismo non ha ancora vinto. Le conseguenze sul piano sociale del titanico sforzo di modernizzazione in atto restano ancora indeterminate e per quanto ne sappiamo non è detto che le tradizionali nozioni di socialismo e capitalismo siano gli strumenti più adatti per comprendere e interpretare questa realtà in continua evoluzione».
Si tratta di un «metodo» fondamentale – ed estremamente profondo – di analizzare la complessità cinese; Arrighi prevede l’uscita da schemi interpretativi, focalizzandosi sulla peculiarità della crescita cinese, evidenziando come le contraddizioni dello sviluppo si basino sulla capacità del Partito di gestire il conflitto di classe come motore della sua progressione storica. Se dunque Arrighi ci fornisce una lettura indispensabile per rapportarsi al «miracolo cinese», su alcuni aspetti la Storia è progredita in modo rapidissimo e costantemente cangiante.
IN QUESTO SENSO l’attuale politica di «redistribuzione» dettata dalla «prosperità comune», la dura repressione in alcune zone del paese, la normalizzazione di Hong Kong, la minaccia su Taiwan e in generale la postura decisamente più assertiva, pongono nuovi interrogativi all’analisi arrighiana. Chi come David Harvey aveva invece interpretato la svolta cinese come «neoliberale», di recente nel suo Cronache anticapitaliste (Feltrinelli, 2021) pone l’atteggiamento del Partito comunista rispetto all’automazione e alla potenziale espulsione di forza lavoro come il banco di prova per capire quanto sia ancora socialista la dirigenza cinese. C’è infine un punto sul quale le previsioni di Arrighi erano forse ottimistiche, pur riscontrando una dinamicità delle lotte ambientali che dal 2010 avrebbero caratterizzato un campo sociale rilevante: il processo di crescita cinese è apparso meno peculiare in questo campo rispetto ad altri, ponendo oggi più che mai la sostenibilità come un fattore determinante nelle due direzioni su cui focalizza la propria attenzione Arrighi: il fronte interno con la necessaria stabilità richiesta rispetto ai costi sociali della transizione, la postura internazionale della Cina di cui andrà verificata la disponibilità a dialogare con il resto del pianeta.
Category: Economia, Osservatorio Cina, Osservatorio internazionale

