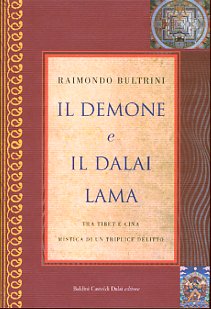Raimondo Bultrini: Il Demone e il Dalai Lama
Diffondiamo l’intervista fatta da Francesco Pullia il 17 Dicembre 2008 su Notizie Radicali per recensire Il demone e il Dalai Lama di Raimondo Bultrini, edito da Baldini Castaldi , 2008
Nelle quattrocento pagine dell’opera si amalgamano con intelligenza e notevole raffinatezza narrativa, saggistica, indagine giornalistica. Si parte da Dharamsala, nell’India settentrionale dell’Himachal Pradesh, dove dagli inizi degli anni sessanta si è insediata, al seguito del Dalai Lama, la più numerosa comunità di esuli tibetani scampati, con fughe rocambolesche tra le innevate altitudini himalayane, alla devastante colonizzazione cinese per addentrarsi gradualmente nella storia dell’antico Tibet e tra le pieghe del buddhismo sviluppatosi, dall’VIII secolo d.C., nel Paese delle Nevi. E’ un viaggio intrigante e affascinante alla ricerca della genesi di una controversia religiosa che, nel corso del tempo, ha finito per assumere, a causa delle ingerenze neppure poi tanto tacite della Cina, forti connotati politici. Lo spunto è dato dal triplice, feroce, assassinio, avvenuto il 4 febbraio 1997, alla vigilia del Losar, capodanno tibetano, nel villaggio di Mc Leod Ganj, nella sommità di Dharamsala, a pochi metri dalla Scuola di dialettica e dalla residenza del Dalai Lama. Un autorevole lama Lobsang Gyatso viene trucidato nella sua stanzetta, insieme a due giovani monaci traduttori Lobsang Ngawang e Ngawang Lodoe. La scena che si offre a Rajeev Kumar Singh, il sovrintendente di polizia incaricato di seguire il caso, e al suo collaboratore Amithaba è a dir poco raccapricciante. Sin dalle prime battute dell’indagine si evince che un delitto così efferato debba rispondere ad un preciso disegno criminale. Dall’intricato quadro che a poco a poco si delinea emerge che si tratta di una ritorsione compiuta da sicari di una setta dedita al culto di Dorje Shugden, sorta di demone venerato da fondamentalisti e duramente criticato, proprio per i suoi connotati negativi, dal Dalai Lama che ne ha fermamente sconsigliato i rituali. Superfluo aggiungere che la setta agguerrita e bene organizzata, con diverse propaggini in occidente, gode dei favori del governo cinese pronto, come si sa, a sfruttare qualsiasi occasione pur di colpire il Dalai Lama e seminare opportunisticamente confusione e dissidio tra gli stessi tibetani. Dal momento che nel testo vengono trattati temi molto delicati e interessanti abbiamo raggiunto Raimondo Bultrini per approfondirli. Ne è scaturita un’intervista particolarmente ampia che sicuramente potrà essere di giovamento non solo a quanti, affascinati dal buddhismo tibetano, vorrebbero saperne di più, al di là di tante approssimazioni, ma anche a coloro che seguono con partecipazione le vicende politiche del Tetto del Mondo e rivolgono costante attenzione alla via nonviolenta proposta da Tenzin Gyatso, S.S. il XIV Dalai Lama, insignito nel 1989 del premio Nobel per la pace.
D. Innanzitutto partiamo dal sottotitolo:“tra Tibet e Cina mistica di un triplice delitto”. Che tipo di mistica può celarsi dietro un atto criminoso?
Raimondo Bultrini. Il triplice delitto del 4 febbraio 1997 di fronte alla residenza del Dalai lama non è stato per la comunità tibetana un semplice atto criminoso. Anche paragonarlo a un assassinio politico o religioso – nel senso di guerra tra chiese o correnti clericali – può essere riduttivo. Ho usato il termine “mistica” per sottolineare il concetto religioso arcaico di ‘mistero’, che sia nel latino mysterium sia nel greco musteria indica una dimensione non tanto misteriosa quanto iniziatica, prerogativa di individui istruiti – ovvero iniziati – a certi culti della meditazione trascendentale (collegati nel cristianesimo a Dio o a entità divine in generale, mentre nel buddhismo tantrico i poteri della mente umana possono collegarsi a diversi tipi di essere, non necessariamente di natura divina). ‘Mistico’ equivale al segreto, imperscrutabile universo impossibile da descrivere attraverso analisi filosofiche, psicologiche o razionali. Col tempo i seguaci di un certo tipo di osservazione o auto-osservazione dei fenomeni inconsueti derivati dai poteri della mente hanno creato, a partire dal nostro medioevo, una tendenza definita del “libero spirito”, contraria alle regole stesse della società e della chiesa. Mentre in Occidente certi movimenti e i loro rappresentanti dovevano ancora finire sotto il maglio dell’Inquisizione, in Tibet erano sorte già nell’anno 1000 nuove scuole religiose contrapposte a quelle dei “mistici” ante literam, seguaci dei primi insegnamenti tantrici buddhisti del grande maestro indiano Padmasambhava. Certi esercizi e tecniche yoga finalizzati a separare – ad esempio – la mente naturale dalla mente razionale prevedevano la totale assenza del controllo psichico ordinario, l’uso di movimenti “scomposti”, di mantra acuti e potenti, e per questo venivano praticati in luoghi isolati. La scuola dei New Kadampa di Atisha e successivamente la Scuola dei Virtuosi (I Gelupa, o Cappelli gialli) sono sorte proprio per contrastare le tendenze tantriche (principalmente mistiche) della Scuola antica Nymapa fondata da Padmasambhava e associate spregiativamente allo sciamanesimo del Bön. Ma mentre i mistici che praticavano in caverne e luoghi remoti avevano come fondamento lo sviluppo individuale della bodhicitta, il seme della compassione e dell’altruismo universale, gran parte delle scuole organizzate gerarchicamente hanno finito per trasformarsi in una sorta di Stato nello Stato. Per secoli le tradizioni Sakyapa, Kajupa, Kadampa e Gelupa hanno lottato per la supremazia non solo religiosa ma anche politica, indicando al popolo etiche comportamentali, curriculum monastici, devozione ai rituali comunemente accettati e ai maestri in linea con i principi fondatori, spesso agendo come un qualsiasi governo laico e usando la spietata logica della “ragion di Stato” per dirimere controversie e epurare eventuali “eretici”. Nel caso del triplice omicidio preso in esame nel libro (con tutti i precedenti delitti “politici” commessi nei secoli) si vanno a mischiare e condensare numerosi aspetti della cultura e della tradizione mistica e filosofica tibetana, laddove il termine “mistica” è alternativo a quello di “logica” o “filosofia”. Mistica e logica sono due cose diverse e separate dallo stesso diaframma che divide il noto dall’ignoto, la mente che osserva e riflette dalla mente che si lascia attrarre dal riflesso e giudica costantemente. Quindi, anche se non credo di poter spiegare in poche righe come mai attribuisco il termine “mistico” a un triplice omicidio, invito ogni eventuale lettore a entrare nella “logica misterica” che pervade la storia di questo culto, che risale a tre secoli e mezzo fa, ma appartiene nella sua essenza all’archetipico conflitto tra Bene e Male, comune a diverse religioni e credenze. Va da sé comunque che l’uso dei concetti di filosofia e di mistica è fortemente condizionato in Occidente dal nostro passato storico. Per questo bisogna entrare nella storia “segreta” del Tibet per capire molte cose apparentemente inspiegabili, legate una all’altra da fili sottili che percorrono il tempo e lo spazio. Riflettendoci ora, avrei potuto usare il termine “karma di un triplice omicidio”. Ma saremmo stati daccapo: quanti conoscono l’esatta definizione di karma?
D. Il tuo libro non solo affronta un argomento decisamente difficile, complesso, finora poco approfondito, ma sembra soprattutto mettere in evidenza la gravissima contraddittorietà di posizioni fondamentaliste all’interno di una visione aperta e tollerante per antonomasia come quella buddhista. Nell’introduzione, in particolare, riferendoti espressamente a situazioni da te stesso verificate nello Sri Lanka o al confine tra Cambogia e Thailandia scrivi: “Lo spirito della discordia alimentato da interessi mondani è teoricamente agli antipodi dell’insegnamento trasmesso oltre due millenni fa del Buddha”. E, subito dopo, ti chiedi non senza una venatura di amarezza: “Perché predicare e dichiararsi seguaci dei principi di compassione e altruismo, se poi si fa uso delle armi e della violenza per affermare le proprie ragioni?”
Raimondo Bultrini. Si dice che “il fine giustifica i mezzi” quando si ritiene che l’obiettivo finale sarà migliore dello status quo (precedente all’utilizzo di metodi prevedibilmente violenti o illeciti). I buddhisti cingalesi dello Sri Lanka ritengono che il massacro delle popolazioni tamil sia necessario per estirpare il fenomeno terrorista del LTTE, terminato il quale regnerà – dicono – una pace duratura e stabile. Di certo i tamil non terroristi (generalmente di fede hindu) temono fortemente questa futura “pace” basata sul predominio dei cingalesi. Non solo e tanto perché si tratta di una diversa etnia che pratica una diversa fede religiosa. Ma perché i governanti e gli stessi leader buddhisti cingalesi hanno dimostrato di saper essere spietati e crudeli senza saper al contempo isolare la minoranza fondamentalista-terrorista e salvaguardare gli interessi del resto della popolazione pacifica. E’ quindi la mancanza di chiarezza che deriva dalla distorsione dei principi di compassione a essere responsabile delle degenerazioni ammantate in vesti dottrinarie. Nel libro cerco di indicare durante la storia del Tibet (e non solo quella connessa alle vicende del gyalpo Shugden) i momenti nei quali la vera bodhicitta, intesa come comprensione del ciclo originario di sofferenza e relativa liberazione comune a tutti gli esseri, è stata sostituita o “reinterpretata” da cosiddetti Maestri che avevano un’influenza politica o erano essi stessi governanti. Costoro usavano la fede nella dottrina (Kadampa, Gelupa o altre) , o la dottrina della fede, come un’arma di liberazione finale, senza considerare che nessuna liberazione individuale o di gruppo può prescindere dalla contemporanea liberazione di tutti gli altri esseri ancora intrappolati nel samsara. Considerando che potremmo essere stati tutti fratelli, madri o figli in qualche altra vita, come potremmo abbandonare i nostri simili dentro una casa in fiamme senza tentare di spegnere il fuoco che la divora? Certo non è facile: non tutti possono seguire la Via dei bodhisattva. Ma quando si sostiene di seguire la dottrina del Buddha, bisogna sapere che cosa il Maestro ha insegnato: “quando non sappiamo come aiutare gli altri – ha detto Sakyamuni – almeno non disturbiamoli.
D. Quando hai cominciato ad interessarti al buddhismo? Come è avvenuto l’incontro con un maestro come Namkhai Norbu cui si deve l’insegnamento anche in occidente dello Dzogchen? Con lui ti sei recato nel 1988 fino al mitico Monte Kailash e da quel viaggio hai ricavato una testimonianza molto interessante, “In Tibet”, pubblicata purtroppo in un’edizione limitata.
Raimondo Bultrini. In realtà ho iniziato a interessarmi al metodo migliore per aiutare la mia mente sofferente prima che al buddhismo. Ho approfondito Confucio e Lao Tsu, i mistici cristiani, perfino l’antropologo Castaneda e gli strani affascinanti insegnamenti attribuiti al suo bruco tolteco don Juan. Ovunque frammenti di verità placavano temporaneamente e parzialmente l’ansia e il dolore creati dalle contraddizioni tra la mia volontà di vivere serenamente senza danneggiare il prossimo e la realtà, creata dal mio egoismo e dalla mia ignoranza di una verità che potesse eventualmente sovrintendere tutte le altre. Dopo essere cresciuto appellandomi da cattolico all’aiuto di un’entità divina esterna, con la maturità avevo smesso di pregarla per il principale motivo che chiedere aiuto a un Dio creatore di cose belle ma anche terribili come guerre, malattie e disastri mi sembrava una contraddizione. Quando incontrai Chogyal Namkhai Norbu nel 1986 non sapevo nulla del buddhismo, men che meno di quello tibetano. Sostanzialmente scoprii grazie a lui che i praticanti tantrici si ponevano le mie stesse domande, e che la sofferenza mentale non era solo la causa ma anche l’effetto della nostra ignoranza. Nessuno delle migliaia di libri letti fin dalla mia infanzia poteva nemmeno lontanamente compararsi a una lezione di quel maestro. Ci volle un po’ per capire che lo Dzogchen, o Grande Perfezione, era basato sull’esperienza e non sulla conoscenza intellettuale, e che la stessa associazione dello Dzogchen alle tradizionali scuole del buddhismo tibetano era in un certo senso impropria, trattandosi di una Via di autoliberazione priva di comandamenti e regole dottrinarie. Gli insegnamenti erano per lo più testimonianze di altri praticanti e maestri, o “Testamenti”, come quelli del celebre – e in Occidente semisconosciuto – Garab Dorje. La necessità del maestro come guida non viene intesa nello Dzogchen come pre-condizione per sviluppare una pura devozione, ma come simbolo vivente della natura pura e incontaminata della propria mente. Il maestro possiede quella saggezza che nello Dzogchen viene associata al simbolo dello specchio: la mente allo stato primordiale, puro e incontaminato, riflette senza venire condizionata dal riflesso. Una montagna, un Buddha o un cane hanno la stessa natura del Vuoto da cui origina ogni fenomeno. Attaccarsi al riflesso – che pure esiste, è apparentemente materiale, concreto e non va sottovalutato – significa attaccarsi anche alla sofferenza che deriva dal perdere ciò che si ha, o si crede di avere.
D. Quando hai preso davvero coscienza della drammaticità della condizione tibetana?
Raimondo Bultrini. E’ successo durante un viaggio del 1988 raccontato in parte nel libretto In Tibet che hai citato. Laddove attraversavo montagne incantevoli disseminate di piccoli villaggi e gruppi di tende di nomadi tibetani, avvertivo la pace di quei luoghi e il potere emanato dal rispetto che quella gente aveva dell’ambiente attorno. Laddove invece c’erano insediamenti cinesi, l’obbrobrio degli edifici, le attività di escavazione, di costruzione e il generale atteggiamento dei coloni verso la popolazione indigena erano manifestamente fastidiosi, a cominciare dagli altoparlanti che trasmettevano mattina e sera annunci politici e “parole d’ordine” del partito. I cinesi dicevano di portare il benessere e di estirpare i residui di feudalesimo dell’antica società tibetana. Ma a parte alcuni tibetani che hanno sposato la causa degli invasori, il resto della popolazione disprezzava i metodi cinesi in tutte le loro forme. Ho sentito testimonianze di crudeltà inaudite, come quando durante la rivoluzione culturale le teste dei dissidenti venivano allineate sulla strada per essere schiacciate dalle ruote dei camion e risparmiare così proiettili. Violenze analoghe sono accadute anche dopo le rivolte di Lhasa del marzo scorso. Ma per parlare di cose meno cruente, un giorno, mentre mi trovavo in un tempio di Khamdogar in Chamdo, a due giorni di cavallo dalla strada più vicina, sono arrivati dei tibetani al servizio dei cinesi e hanno interrotto la cerimonia religiosa per controllare i miei permessi. Nonostante fossero regolari, volevano allontanarmi, e solo dopo una lunga discussione alla quale ha partecipato quasi l’intero villaggio se ne sono andati.
D. Proprio Namkhai Norbu, come hai scritto, sostiene che Dorje Shugden sia un “gyalpo”…
Raimondo Bultrini. Infatti Norbu lo chiama Gyalpo Shugden, e il Dalai lama usa l’espressione Gyalchen, o grande gyalpo. E’ una delle classi di esseri che, come gli uomini, può avere secondo i tibetani valenze buone o cattive, dipende dai singoli individui e dal loro karma, frutto delle loro azioni precedenti. Dicono gli antichi saggi che un attimo di rabbia distrugge i meriti accumulati dopo eoni ed eoni passati a compiere azioni positive. Vale per gli uomini e per gli esseri non umani. Uno dei Gyalpo più famosi è Pe har, il “Protettore” divino del quale è considerato emanazione l’Oracolo di Stato del Tibet Nechung. Pe har – secondo la tradizione mistica tibetana – era un essere feroce e potente che fu sottomesso all’ubbidienza verso il dharma buddhista da Padmasambhava. Invece di ucciderlo come avrebbe potuto grazie ai poteri di maestro dei tantra, Padmasambhava trasformò le sue enormi potenzialità mettendole al servizio della religione. Ma evidentemente la classe di gyalpo cui appartiene Shugden è meno domabile. O quantomeno la sua influenza ha condizionato un numero abbastanza consistente di devoti incapaci di liberarsi dalla dipendenza da questo culto.
D. Al di là degli aspetti religiosi, dietro il culto di Shugden si sono storicamente celati interessi politici. Dietro la scusa di privilegiare l’insegnamento dei gelupa e la cosiddetta via graduale all’illuminazione c’era, in realtà, la volontà di conservare un sistema sociale di cui una figura come il Tredicesimo Dalai Lama avvertiva fortemente l’esigenza di una radicale riforma. Sia il Quinto che il Tredicesimo Dalai Lama, come d’altronde l’attuale, il Quattordicesimo, hanno avversato privilegi e concezioni del potere verticistiche e feudali.
Raimondo Bultrini. Ritengo che Shugden, come i vari Dalai lama che si sono succeduti sul trono del Tibet, abbiano agito ognuno secondo le proprie tendenze in momenti storici particolari. Forse è eccessivo paragonare il V o il XIII Dalai lama a esponenti democratici e riformisti come li intendiamo oggi in Occidente. Perché l’attuale Dalai lama potesse rendersi conto dei progressi di certi sistemi politici e sociali laici c’è voluto l’esilio, sebbene fosse già consapevole da ragazzo delle enormi discriminazioni patite in Tibet da molti suoi sudditi oppressi da una certa aristocrazia feudale. Ma guarda caso uno degli ostacoli più pesanti alla sua missione di riformatore fin dai tempi del suo governo al Potala veniva proprio dalla Corte di tradizionalisti gelupa devoti al culto di Shugden. E lo stesso accadde sotto il XIII, mentre per il periodo del V Dalai lama abbiamo troppo poche referenze storiche per capire se davvero la sua personale apertura ecumenica alle altre tradizioni buddhiste corrispondesse anche a una maggiore giustizia sociale e apertura religiosa. Di certo i rapporti con il capo della scuola kagyupa, non erano idilliaci e furono ristabiliti solo poco prima della morte del Karmapa.
D. Ad un certo punto fai riferimento a un misterioso “libro giallo” scritto negli anni Settanta da Zemey Rinpoche e forse ispirato da Trijang, devoto del terribile spirito ma anche uno dei tutori dell’odierno Dalai Lama. Di che si tratta con precisione?
Raimondo Bultrini. Il libro giallo elenca con dettagli – solo in parte dimostrabili storicamente – la sorte di alcuni importanti lama e alti dignitari tibetani che, dopo un passato di devoti della tradizione Gelupa e del culto di Shugden, sarebbero caduti in disgrazia – secondo il libro – per aver iniziato a praticare anche gli insegnamenti di altre tradizioni, in particolare dell’antica scuola nymapa e dello Dzogchen. Un celebre maestro nymapa ancora vivente, Chadral Rinpoche, ha contestato uno per uno tutti gli esempi riferiti da Zemey. Ma al di là della validità di affermazioni indimostrabili (come si può attribuire un incidente, una malattia o una sconfitta politica a uno spirito maligno anziché ad altre cause molto più plausibili?) nel mio testo metto in evidenza un episodio accaduto a Dharamsala dopo la pubblicazione del Libro giallo e considerato dal Dalai lama all’origine della sua decisione di sconsigliare pubblicamente il culto di Shugden. In pratica monaci e monache che avevano letto le storie citate da Zemey nel libro si rifiutarono di partecipare a una cerimonia religiosa promossa dal leader tibetano in onore di Padmasambhava. Questo grande maestro dell’VIII secolo è infatti considerato pressappoco il nemico numero uno della dottrina religiosa gelupa, per via dei suoi insegnamenti decisamente non settari e mistici. Quei religiosi ebbero paura di subire le stesse conseguenze descritte da Zemey nel suo testo, al punto da rinunciare a una cerimonia tenuta dal loro leader spirituale e politico. Minacce esplicite furono fatte pervenire al Dalai Lama anche quando Sua Santità costruì una statua di Padmasambhava nel tempio principale di Dharamsala. La cosa interessante è che le autorità cinesi, come fecero i seguaci di Shugden discepoli del lama Gelupa Pabonka tra il 1920 e il 1940, ancora oggi distruggono in Tibet le statue di Padmasambhava e non altre immagini di Buddha o Bodhisattva. Sarebbe lungo qui spiegarne tutte le ragioni, e forse non basta nemmeno leggere il Libro giallo o il mio testo per comprenderle tutte. Ma di certo è un aspetto molto delicato e importante verso il quale cresce e crescerà in futuro l’interesse di tibetologi e appassionati della cultura tibetana.
D. Lobsang Gyatso, il lama assassinato nel 1997, aveva ingaggiato una vera e propria sfida dialettica con i fondamentalisti.
Raimondo Bultrini. Il direttore della Scuola di dialettica scriveva e parlava francamente di ciò che pensava. E non era contrario al culto solo perché lo diceva il Dalai Lama. Molti Gelupa come lui, anche quando Sua Santità praticava Shugden, erano istintivamente diffidenti verso questo genere di devozione che rasentava il fanatismo. Ho già accennato alle statue distrutte, ma ci sono numerosi episodi nella storia del Tibet che dimostrano le divisioni create sulla base della devozione esagerata verso un “Protettore” esclusivo della scuola Gelupa come Shugden.
D. Cosa ti ha spinto a dedicare quasi dieci anni a indagare e studiare intensamente, con meritoria costanza, nonostante la frenetica e per certi aspetti dispersiva attività giornalistica che conduci, una questione così intricata, oltre che intrigante?
Raimondo Bultrini. A parte le motivazioni giornalistiche (dovetti seguire il caso per scrivere un articolo su La Repubblica) volevo cercare di capire come mai il Dalai lama, che ne era stato un praticante, aveva deciso di eliminare questo culto dalle sue pratiche, sconsigliandolo a tutti i suoi discepoli. Inoltre avevo una specie di istinto che mi diceva: i tre delitti sono solo l’inizio, succederà qualcos’altro (ovvero, com’è realmente accaduto, manifestazioni di dissenso, violenze, cortei anti Dalai lama nel mondo). Il Dalai lama e Namkhai Norbu mi confermarono che dietro al caso Shugden si celava un universo molto più complesso e articolato, e in qualche modo lasciarono che fossi io da solo a scoprirlo, limitandosi a confermare la gravità delle divisioni che questo culto aveva creato nella società tibetana dentro e fuori il Paese. Devo dire che il finale del libro è emerso davvero al termine del mio lavoro. <b>Ho scoperto con mia stessa sorpresa mettendo insieme i vari tasselli del grande puzzle quale complesso meccanismo di relazioni si è instaurato nel tempo tra autorità cinesi e seguaci del gyalpo. Il finale disvela una verità molto più drammatica delle divisioni politiche tra autonomisti e indipendentisti per le sorti del Tibet e della sua straordinaria, in gran parte sconosciuta e potenzialmente utilissima cultura. Se la sua essenza sopravvivrà oltre questi conflitti settari, sono certo che sapremmo apprezzarla meglio col tempo, magari quando ci saremo liberati dagli schemi politico-religiosi che hanno caratterizzato la diffusione del buddhismo tantrico e, va da sé, senza l’infantile e un po’ melensa zavorra dei miti di Shangrilà e Shambala.
D. Hai provato, almeno all’inizio, timore, sgomento, un minimo di paura nell’affrontare un argomento così spinoso?
Raimondo Bultrini. Sì, ho avuto paura. E come nelle storie del Libro giallo, mi sono spesso domandato se certe vicende negative della mia vita fossero conseguenza del mio interesse per questo argomento considerato tabù anche da persone che stimavo altamente. Ma superare la paura, e sopra tutte la paura della morte, è uno dei passaggi necessari per apprezzare il significato degli insegnamenti tibetani. Non si tratta solo di capire la legge del karma, della causa e dell’effetto delle azioni, ma anche il metodo tantrico di superamento delle barriere che possono formare col tempo le tante gabbie in grado di avvolgere la nostra mente. La nostra vita è spesso come quella del prigioniero che rompe il muro della sua cella solo per ritrovarsi in un’altra, e poi un’altra ancora.
D. Nel tuo libro riesci a tratteggiare molto efficacemente una personalità travagliata, introversa, come quella di Dragpa Gyaltsen. Ce ne parli?
Raimondo Bultrini. Dragpa Gyaltsen era figlio di una famiglia tibetana dell’aristocrazia terriera con grandi possedimenti a non molta distanza dalla capitale Lhasa. Secondo l’autobiografia del suo grande contemporaneo, il V Dalai lama Lobsang Gyatso, fu la madre a cercare di promuovere Dragpa Gyaltsen come tulku, candidandolo inizialmente al posto di Dalai lama, salvo poi accettare il suo riconoscimento come erede di un altro tulku – reincarnato – che era stato capo della scuola Gelupa. I due bambini crebbero praticamente insieme nel grande monastero di Drepung dove risiedevano 7.000 monaci e due soli tulku, Dragpa e Lobsang. Fino alla sua misteriosa morte, Dragpa Gyaltsen visse in una dimora chiamata Residenza superiore, quasi a intendere che fosse più elevata non solo fisicamente della stessa Residenza del Dalai Lama, definita “inferiore”. Ma quando Lobsang Gyatso diventerà il Grande V – al quale l’imperatore mongolo Gushri Khan conferirà nel 1642 il massimo potere temporale e spirituale sul Tibet unificato di U e Tsang – la differenza tra i due tulku fu definitivamente evidente. Poco sappiamo di ciò che accadde tra loro, se non dagli accenni nell’autobiografia del V e dalle note riferite ai giorni nostri dal già citato Trijang Rinpoche, ex tutore dell’attuale Dalai lama (Trijang ha sostenuto che Dragpa fu ucciso con una sciarpa rituale dal Reggente del Dalai lama per evitare l’accrescersi della sua popolarità). Ciò che sappiamo è che Dragpa Gyaltsen venne progressivamente declassato man mano che cresceva il potere del suo quasi coetaneo, e che un sentimento di gelosia e invidia potrebbe aver preso lentamente possesso della mente di questo lama. C’è anche una tesi sostenuta da Trijang e dai suoi seguaci secondo la quale Dragpa Gyaltsen godeva di maggiore credito del Dalai Lama stesso tra i religiosi gelupa e tra molte tribù mongole perché rispecchiava meglio il punto di vista dell’ortodossia della scuola dei Cappelli gialli, mentre il Grande V praticava indistintamente anche altri insegnamenti e specialmente lo Dzogchen. Sappiamo solo – dai resoconti della sua morte – che qualcosa di misterioso e magico accadde durante la cremazione, e che il suo spirito – divenuto potente e vendicativo – prese a vagare per gli altipiani prima di diventare quello che molti considerano ancora oggi il feroce “Protettore” esclusivo dei Cappelli gialli: Shugden. A dar credito al Dalai Lama e ad altri, la sua morte avvenne dopo una sorta di “possessione” da parte di uno spirito demoniaco, e il Grande V dice esplicitamente che ciò avvenne perché Dragpa aveva rotto il “samaya”, la promessa di collaborazione spirituale reciproca tra maestro e discepolo, particolarmente sacra nel buddhismo tibetano. Ho cercato di chiarire questo punto più volte con l’attuale Dalai Lama, e ogni volta Sua Santità ha ripetuto che la “rottura” della promessa o del voto religioso significa l’infrangersi di un patto comune per la realizzazione spirituale reciproca e degli esseri in contatto con noi. In sostanza, Dragpa Gyaltsen non avrebbe agito da buddhista. Sembra un po’ lo stesso tipo di accusa rivolta da Sua Santità ai seguaci di Shugden, ovvero di non agire secondo la dottrina del Buddha ma di seguire un culto spiritista, per di più destinato ad accrescere i poteri mondani dei suoi seguaci, a discapito di quelli spirituali.
D. Torniamo ai nostri giorni. In un’intervista che ti ha rilasciato tre anni fa, il Dalai Lama ha affermato: “Neanche noi tibetani possiamo attribuire tutta la nostra attuale condizione di sofferenza ai cinesi. Guardare ai propri errori è l’inizio del processo di comprensione universale”. Oltre alle riforme mancate, alludeva alla corruzione di alcuni dignitari tibetani resisi ben disposti a favorire le mire cinesi e alla copertura offerta dal culto di Dorje Shugden?
Raimondo Bultrini. Alludeva certamente alle ingiustizie e agli errori commessi sotto varie forme nel corso della storia tibetana. Anche nelle interviste contenute nel libro il Dalai Lama parla di dignitari e membri del clero che hanno di fatto favorito la divisione tra i tibetani aprendo (o quantomeno allargando) la strada all’ingresso dei cinesi.
D. Alcuni Lama, intanto, si sono vergognosamente prestati ad accettare come autentico il Panchen Lama imposto da Pechino dopo che quello riconosciuto e accertato direttamente dal Dalai Lama è stato rapito e fatto letteralmente sparire, con tutta la sua famiglia, nel 1989. I giochi si fanno sempre più sporchi.
Raimondo Bultrini. La politica è in generale “sporca”, e i lama devoti al culto sembrano confermare nei fatti di avere a cuore più la politica e – come dice Sua Santità – il beneficio materiale che non quello spirituale. Per beneficio spirituale intendo anche quello che deriva dall’unità di un popolo devoto al dharma e alla messa in pratica della vera compassione buddhista.
D. Una storia come quella da te narrata non può non averti in qualche modo segnato. Cosa ha lasciato in te questo libro?
Raimondo Bultrini. Undici anni di studi, pause, riflessioni, paure, frustrazioni, pensieri di una invalicabile limitatezza intellettuale hanno accompagnato una delicata fase della mia vita rendendola particolarmente tormentata e a tratti cupa. Ma aver potuto valicare la cima di questa enorme montagna ripida e labirintica mi ha dato nuova fiducia, a prescindere dalla compiutezza del risultato e del messaggio che ho cercato di far emergere attraverso il libro, un messaggio rispettosamente dedicato all’essenza degli insegnamenti dei miei maestri. Non vuol dire che ora sono più ottimista, anzi, forse lo sono meno nel breve periodo: stiamo attraversando da tempo con consapevole ignoranza una delle fasi più tremende della storia umana e non siamo certo alla fine dell’incubo. Credo però di sapere adesso che ogni uomo ha la possibilità e potenzialità di guidare il cambiamento, sia personale che collettivo. E’ un po’ come il motto di Obama, Yes, we can. Con la differenza che sul piano spirituale non potremo mai dire che il fine giustifica i mezzi, perché i mezzi sono il fine, e lo strumento della compassione, l’azione della compassione, hanno come principale risultato lo sviluppo della compassione. Il mezzo è il patire insieme le avversità ognuno con la propria abilità e capacità di sopportazione e saggezza, il fine è la scoperta del metodo di liberazione comune per tutti gli esseri. Come marinai colpiti nell’Oceano da una burrasca, saremo costretti un giorno a raddrizzare la nave con tutte le nostre forze, collaborando con mozzi, velisti, capitani e ufficiali, ci siano simpatici o meno.
D. Anche nel suo ultimo intervento al Parlamento Europeo il Dalai Lama, premio Nobel per la pace nel 1989, ha perorato la causa dell’autonomia tibetana. Per la Cina, però, lui, sempre e soltanto lui, resta d’intralcio al raggiungimento dell’obiettivo della definitiva cancellazione del Tibet.
Raimondo Bultrini. La Cina non cerca la cancellazione del Tibet, ma la sua sottomissione alle regole del sistema materialista, il modello imposto da Pechino: coloni cinesi e tibetani fedeli al Partito che governano il Paese delle nevi sfruttando al massimo le risorse, riducendo i monasteri e i templi a luoghi turistici e le lezioni di religione a corsi di marxismo capitalista. Una popolazione devota solo alla disciplina di regime e ai soldi renderà la competizione tra cittadini un ottimo strumento per accrescere le entrate attraverso una squallida gara di servilismo. Una popolazione devota al dharma rifiuterà invece l’esclusiva competizione materiale basando le proprie aspettative su quello che il re del Bhutan ha chiamato il Tasso interno lordo di felicità, contrapposto al Prodotto interno lordo.
Category: Culture e Religioni, Libri e librerie, Osservatorio Tibet