Antonella Beccaria: Le origini del caporalato moderno e il libro di Pietro Alò
Venerdì 3 ottobre 2014 a Bologna alle ore 18 presso il Centro culturale e sociale Giorgio Costa, Via Azzo Gardino 44 verrà discusso il libro di Pietro Alò Il caporalato nella tarda modernità. Intervengono Piergiovanni Alleva e Vincenzo Grimaldi, modera Antonella Beccaria. In relazione a questo libro pubblichiamo questa ampia riflessione di Antonella Beccaria
Quello del sociologo e senatore Pietro Alò non è stato solo argomento di studio di una vita ma una dimensione che risaliva alla sua origine, figlio di una famiglia contadina pugliese. Il caporalato, per lui, è diventato tema della tesi di laurea in scienze politiche e poi oggetto di indagini nella commissione d’inchiesta a questo fenomeno dedicata dal 15 aprile 1994 all’8 maggio 1996, nel corso della dodicesima legislatura. Ma anche approfondimento di un libro uscito cinque anni dopo la sua morte avvenuta nel 2005 (la pubblicazione del volume è invece del 2010) e intitolato Il caporalato nella tarda modernità. La trasformazione del lavoro da diritto sociale a merce (Wip Edizioni)
Una trasformazione che l’incidere del tempo, delle tecnologie produttive e dell’evoluzione del mercato del lavoro non ha modificato in sé, se lo si intende come forma di sfruttamento che annienta chi ne è vittima. Semmai quel fenomeno è stato al passo altri cambiamenti, come la progressiva sostituzione degli italiani con i migranti o la gestione mafiosa – sia autoctona che straniera – della manodopera schiavizzata.
Sistema illecito di reclutamento per lavori agricoli stagionali sottopagati. La definizione del termine caporalato, contenuta nel dizionario della lingua italiana Sabatini Coletti, risale al 1978. E nel corso degli anni ha dovuto essere corretta perché, dai campi, il fenomeno si è esteso a molti altri settori. Ci sono gli scantinati degli italiani in cui in Campania si produce merce contraffatta e lo stesso avviene dei laboratori cinesi distribuiti nelle Chinatown di tutto il Paese, a Milano come a Bologna e a Prato. C’è l’industria del turismo che ogni estate accoglie in riviera villeggianti da tutto il mondo e ingaggia ragazzi non regolarizzati facendo della Romagna, della Versilia, della Liguria o delle coste calabresi un tutt’uno di sfruttamento, quando non di vera e propria prigionia nel caso degli stranieri che arrivano dai confini extra Schengen e a cui vengono sequestrati i documenti.
E e poi ci sono gli ultracinquantenni italiani, quelli espulsi dal mercato del lavoro e con scarse possibilità di rientrarvi, divenuti i nuovi obiettivi del caporalato. Vengono assorbiti in primis nella logistica e nei trasporti da cooperative «spurie» (forme di collocamento illegale a cui va tra il 30 e il 50 per cento dei compensi dei lavoratori), percepiscono un compenso che oscilla tra i 3,5 e i 4 euro all’ora e i loro turni di lavoro possono arrivare fino a 12 ore non scendendo in genere sotto le 10. Sono i nuovi poveri a rischio schiavitù che, secondo la Cgil, possono diventare un fenomeno destinato a consolidarsi se non si interviene per stroncarlo.
1920, una ribellione che viene da lontano
Il caporalato è un problema connaturato al mondo del lavoro e che ha fatto parlare di sé spesso solo quando sono scoppiate rivolte. Una delle prime della storia contemporanea italiana risale ai fatti del 1 luglio 1920 dopo una giornata di lavoro nella vigna che si trovava lungo che la strada che da Gioia del Colle conduce a Castellana, nel barese. La vigna era della famiglia Girardi, proprietaria della masseria di Marzagaglia, e quando era venuto il momento di essere pagati i «cafoni», così com’erano chiamati, si era presentati sull’aia dei tenutari, un’area di una settantina di metri di lunghezza per altrettanti di larghezza.
Nell’aria c’era nervosismo perché i soldi per la giornata di lavoro precedente non si erano visti. Il proprietario aveva accusato i braccianti di essere dei lavativi e di essere stati imposti, senza che ce ne fosse bisogno, dai disoccupati e dalle leghe. L’intenzione di Girardi, nonostante la vigna avesse davvero avuto bisogno degli interventi dei braccianti, era quella di non sganciare un centesimo e quando giunse la sera disse ai caporali di aprire il fuoco sui contadini. A sparare fu una quarantina di persone uscita d’improvviso da una masseria vicina, dove si era radunata in attesa di passare all’azione. La componevano piccoli proprietari terrieri e i loro massari e della loro presenza, oltre che delle loro intenzioni, si accorsero un operaio che lavorava non lontano da lì e suo figlio, ma non fecero in tempo ad avvertire i braccianti.
Quando furono investiti dalla pioggia di proiettili, i lavoratori cercarono di fuggire, ma furono inseguiti anche fuori dall’aia della masseria, quando cercarono di ripararsi nelle macchie della vegetazione e nei boschi circostanti. Alla fine sei furono le vittime: Pasquale Capotorto, il più anziano, che aveva 70 anni, Vito Falcone, Vincenzo Milano, Rocco Montenegro, Rocco Orfino e Vitantonio Resta, il più giovane, un sedicenne. I loro corpi rimasero a terra per ore, fino a quando in nottata non furono caricati su un furgone e portati alla camera mortuaria dell’ospedale Sant’Antonio del Colle. Una quarantina invece i feriti, di cui dieci erano in gravi condizioni.
Nel giro di un’ora, chi sopravvisse raggiunse la Camera del lavoro di Gioia del Colle e i capi del movimento contadino, come risposta a quanto era appena accaduto, indissero uno sciopero generale. Intanto si temevano le rappresaglie da parte dei lavoratori e nel giro di breve i carabinieri bloccarono l’ingresso della masseria di Marzagaglia mentre nella notte tra il 1 e il 2 luglio 1920 partirono squadre di braccianti per andare alla ricerca di chi aveva sparato. Nel frattempo sempre i lavoratori bloccarono l’accesso al paese e si armarono prelevando fucili e pistole anche nelle case degli agrari che non avevano partecipato al massacro, ma che consegnarono quanto veniva loro richiesto per timore di finire coinvolti nelle rappresaglie.
Il periodo era quello dei moti seguiti alla fine della prima guerra mondiale e il sud non aveva fatto eccezione raccogliendo echi e pratiche che arrivavano fin dal pianura padana. A Nardò, per esempio, nell’aprile precedente ai fatti di luglio i contadini avevano occupato le terre e nello stesso mese a Ruvo di Puglia una madre e il suo bambino furono uccisi dalla reazione delle forze dell’ordine. A Canosa di Puglia, a fine maggio, si registrarono tre morti e dodici feriti tra i braccianti che chiedevano di essere pagati mentre altre vittime si ebbero in giugno a Spinazzola, Bitonto e Terlizzi. E ancora in luglio, contemporaneamente alla strage di Marzagaglia, ulteriori morti si contarono a Parabita (una donna e tre uomini), a Castellaneta e a Lucera (in dieci persero la vita).
Tra la primavera e l’estate del 1920 sembrava insomma di essere giunti a una rivoluzione, quella a cui si aspirava in tanti settori: i lavoratori alzavano la testa e chiedevano il riconoscimento dei propri diritti.
Non erano solo i reduci che, rientrati dal fronte due anni prima, avevano trovato una società del tutto cambiata, nella quale non c’era più posto per loro perché il posto di lavoro era andato ad altri, le donne avevano iniziato a diventare elementi importanti nelle industrie del nord e nei campi del sud. No, era qualcosa di più trasversale, era una voce che chiedeva la fine dello sfruttamento, dello schiavismo degli agrari sui cafoni. E a fronte di questa voce che si levava, la repressione dei carabinieri era puntuale ovunque. Con l’eccezione tuttavia della masseria di Marzagaglia, dove a imbracciare le armi furono i proprietari terrieri e i loro affittuari.
Che le loro intenzioni non fossero quelle di ascoltare i braccianti era chiaro da tempo e lo avevano ribadito il 26 giugno precedente quando avevano scritto al prefetto un telegramma in cui lamentavano «prepotenti invasioni» delle loro terre. E a placare gli animi, a riportare la situazione alla sudditanza di sempre, non ci avessero pensato le autorità preposte, avrebbero fatto da soli. Come fecero.
I braccianti superstiti non si fecero annichilire dalla reazione armata alla Marzagaglia e a propria volta si misero a dare la caccia agli agrari che avevano partecipato. Alla fine tre furono le vittime tra i proprietari e tra i loro guardaspalle, Giuseppe Nico, Vito Fiorentino e Giuseppe Pinto. Ma fu una specie di sipario calato sulle rivolte dei lavoratori perché, al di là dei proclami e con il fascismo agrario nascente, nel giro di poco di tornò al consolidato schema padrone-schiavo. E alla fine anche la sentenza del processo che scaturì dalla strage di Marzagaglia sembrò andare nel senso della normalizzazione.
Se in fase istruttoria i nomi in mano ai magistrati erano trentatré per gli agrari e ottantantotto per i braccianti (di cui quindici sotto i vent’anni), il 7 gennaio 1922 a giudizio vennero rinviati diciotto proprietari e quarantasette contadini. Il processo iniziò nel maggio successivo e il 31 agosto tutti gli agrari furono assolti con formula piena. Tra i contadini, solo due furono condannati a piene lievi e accadde perché avevano confessato le proprie responsabilità nell’uccisione di Giuseppe Pinto. Il periodo dei moti del Venti contro lo schiavismo era ufficialmente concluso.
1980, le schiave bambine di Ceglie
Edizione del quotidiano L’Unità di domenica 25 luglio 1980, pagina 12 con le cronache dalla Puglia. I fatti qui raccontati seguono la strage di Ceglie Messapico, provincia di Brindisi, avvenuta nel maggio precedente e il titolo che apre il primo articolo parla di «morte bambine nell’esercito di chi non può dire di no». Qui si parla della storia di Pompea Argentiero, 16 anni, Lucia Altavilla, 17, e Donata Lombardi, 19. Erano a bordo di un pullmino dei caporali finito sotto un camion e il bilancio delle vittime avrebbe potuto essere ben più tragico dato che sul mezzo viaggiavano altre quindici giovani (rare erano le anziane), mentre la capienza era al massimo per nove persone. Nell’incidente rimase ferita anche Vita, la sorella diciottenne di Pompea, che si ruppe un braccio.
Vestivano tutte più o meno nello stesso modo, jeans, magliette e scarpe da ginnastica o espadrillas perché nei campi era necessario avere un abbigliamento comodo. Per andare al lavoro, le ragazze no prendevano il pullman della Regione, ma quello della «ditta», molto spesso un Ford Transit che le trasportava in aree più ricche, dove i campi si susseguivano e lì c’era da darsi da fare. Così, dalla piazza di Ceglie, ogni mattina, i mezzi della «ditta» si spostavano a Noicattaro, Conversano, Mola di Bari, Monopoli, Rutigliano, Polignano a Bari e si spingevano anche fino al Metaponto. E se in giro si intravedeva una pattuglia della polizia stradale, le ragazze erano costrette a rannicchiarsi sotto i sedili per evitare che il pullmino fosse fermato e controllato.
Per tutte il caporalato era l’unica via per lavorare. Nonostante la giovanissima età della maggior parte delle ragazze, per tutte la storia familiare era più o meno la stessa: un marito disoccupato o la necessità di provvedere ai ormai genitori anziani e non più in grado di andare in campagna. Uscivano quando il sole non si era ancora levato e rientravano che il tramonto era già passato da un pezzo. Federbraccianti e il collocamento ci avevano provato a sfiancare il fenomeno dello sfruttamento, ma i caporali riuscivamo comunque ad aggirare le liste speciali, quelle per l’immigrazione, corrompendo funzionari pubblici. Inoltre, per le donne di Ceglie che avevano provato a dire no al caporalato, un lavoro regolare, con contratti e contributi, non era ancora saltato fuori perché la legge diceva che le lavoratrici avrebbero dovuto essere pagate venticinquemila lire mentre in nero se ne pagavano al massimo dieci, ma spesso erano meno.
Intervistata dalla giornalista Cinzia Romano, una di quelle ragazze aveva detto parlando dei caporali:
«Ma allora non vuoi capire. A noi ci trovano anche il lavoro nei campi o nei magazzini, dipende dal periodo. Quando ho cercato di fare per conto mio sono riuscita a mettere insieme sì e no venti giornate. Così invece supero anche le cento. Prima ho lavorato nel campo di carciofi, poi ho piantato e raccolto le fragole, adesso ripulisco i grappoli d’uva in attesa della vendemmia. Forse riuscirò anche a farla. Certo, la paga è da fame. A me fa rabbia che uno senza far niente intaschi diecimila lire e a me ne metta in mano sette o otto. Ma non c’è niente da fare: prendere o lasciare».
L’incidente del luglio 1980 era l’ennesimo di una serie che riproponeva episodi troppo simili l’uno all’altro e la cui matrice comune era sempre la stessa, il racket della manodopera femminile. I sindacati ricostruirono i precedenti partendo dal 1974 partendo dallo scontro verificatosi sulla statale Adriatica nei pressi di Monopoli. Un pullmino dei caporali che trasportava le occupanti al lavoro uscì di strada e rimasero uccise Franca Di Bello, Giuseppa Muolo e Anna Carria. Altre sei giovani, di cui due minorenni rimasero ferite.
Se gli incidenti successivi furono di entità più lievi, si tornò a contare i morti nel luglio 1977 quando Livia Pugliese, di Martina Franca, perse la vita sempre nell’impatto tra il mezzo dei caporali e un camion. Dodici donne riportarono lesioni, compresa una ragazzina di 14 anni, Cosima Besani. E due mesi dopo, nel settembre dello stesso anno, un incidente del tutto analogo avvenne nei pressi di Grottaglie coinvolgendo il pullman di lavoratrici dirette a Rutigliano per raccogliere uva da tavola. Quest’ultimo incidente fece aumentare i controlli della stradale e i sindacati annunciarono una nuova stagione di lotta al caporalato senza però a riuscire incidere più di tanto nella situazione che si viveva in quelle zone.
Quando si diffuse la notizia del nuovo incidente, quello del maggio 1980, Ceglie Messapico divenne il centro di un’estesa mobilitazione di maestranze e lavoratori. Sul palco allestito nella piazza centrale parlarono la sorella di Pompea, Vita, che aveva il braccio spezzato appeso al collo, e sfilarono i dirigenti sindacali di Uisba, Federbraccianti e Federazione Unitaria. Si aggregarono al corteo dei lavoratori rappresentanze dei consigli comunali di Bernalda, in Basilicata, Villa Castelli, Carovigno e Crispiano. E poi c’erano esponenti del consiglio di fabbrica della Montedison di Brindisi, della Frascari di Mesagne e della Lega dei giovani disoccupati di Francavilla Fontana.
Le organizzazioni bracciantili tornarono a farsi sentire con l’assessorato regionale ai trasporti perché si arrivasse a far prendere posizione ai vertici del settore al centro di tanti incidenti in cui avevano perso la vita le lavoratrici pugliesi. E per un po’ sembrò che qualche effetto si riuscisse a ottenere quando entrarono in funzione tre corse pubbliche che da Ceglie arrivavano nelle località battute dai caporali.
Ma le rappresaglie dei caporali – anche contro queste si manifestò alla fine del luglio 1980 – c’erano già state e tra le più cruente c’era quella di qualche giorno prima. Era il 17 luglio e i caporali avevano cercato di investire alcuni sindacalisti di Villa Castelli che sfilavano nel corso di una delle manifestazioni che erano seguite all’incidente di maggio. Erano già stati ripetutamente minacciati di morte per la radicalità del loro impegno contro lo sfruttamento e il 21 luglio si raggiunse un nuovo picco di tensione e violenza quando un commando di otto caporali armati fece irruzioni nella sede della Cgil. Si pensò, dopo il 24 luglio e la grande manifestazione unitaria che ne era seguita, che qualcosa sarebbe finalmente cambiato. Ma così non fu e anzi il fenomeno, nel corso dei due decenni successivi, si estese perché arrivarono dall’estero nuovi disperati che avrebbero accettato qualsiasi condizione, pur di guadagnare qualcosa.
1989, Jerry Masslo, il rifugiato che lottò contro l’apartheid dei campi
Tra le tante iniziative a lui intitolate, oggi c’è un premio che lo ricorda, quello della Flai Cgil nazionale. Accade perché Jerry Essan Masslo, il trentenne sudafricano ucciso a Villa Literno (Caserta) il 25 agosto 1989 dopo essersi visto riconoscere dall’Alto commissariato dell’Onu lo status di rifugiato politico, andava con altri stranieri a nutrire la popolazione della «piazza degli schiavi», dove i braccianti immigrati si radunavano per essere portati nei campi. I campi erano quelli che, per loro coltivazione, ricevevano contributi dall’Azienda per gli interventi sul mercato agricolo e dalla Comunità europea, ma qui Jerry, come tanti altri stranieri, lavorava senza alcuna tutela fino a quindici ore al giorno e come per le generazioni che sarebbero seguite veniva pagato a cottimo, tra le ottocento e le mille lire a casse da venticinque chili di prodotto.
A Villa Literno, come in molte città del Meridione, a metà degli anni Ottanta avevano iniziato ad assieparsi stranieri per lo più provenienti dall’Africa, molti dei quali erano stati respinti da altre nazioni europee, come la Germania e la Francia, che avevano irrigidito le loro legislazioni in merito all’ingresso di cittadini immigrati. «Al dicembre 1988», scrive il giornalista Giulio Di Luzio nel libro A un passo dal sogno, «risultano seicentomila gli immigrati censiti dal Viminale in possesso di permesso di soggiorno, ma il dato ne trascura altrettanti irregolari. Ogni etnia prenderà un posto in uno spicchio ben definito del Paese, i nordafricani […] in Sicilia, le capoverdiane, gli etiopi e i somali a Roma, i senegalesi nelle zone industrializzate del nord, soprattutto nel bresciano». E per chi viene arruolato nelle fila del caporalato, quando l’interminabile giornata di lavoro giungeva alla conclusione, per dormire non c’era altro che un cartone al posto del materasso e assenti erano acqua, luce elettrica e servizi igienici.
Nel 1988 Jerry Masslo trascorse due mesi a Villa Literno e alla fine dell’estate tornò a Roma, in attesa di un visto mai arrivato che gli concedesse di migrare in Canada. Era ancora lì, ospite di una comunità, quando giunse la stagione estiva 1989 e Jerry tornò nella cittadina in provincia di Caserta. Qui, a fronte di condizioni di lavoro ancora peggiori rispetto all’anno precedente, iniziarono i fermenti tra i lavoratori, Jerry compreso, che era diventato uno dei leader della protesta e che aveva chiamato direttamente in causa i sindacati. Nelle sue intenzioni, proprio lui che veniva dal Sudafrica, c’era di combattere l’apartheid a cui gli stranieri erano sottoposti una volta giunti in Italia e pagati, in media, 50 lire l’ora.
La risposta dei caporali non si fece attendere e cominciò con una serie di atti di intolleranza nei confronti degli stranieri. «È aperta la caccia permanente al nero. Data la ferocia di tali bestie […] e poiché scorrazzano per il territorio in branchi, si consiglia di operare battute di caccia in gruppi di almeno tre uomini», si leggeva su un volantino che circolava in quel periodo. E la situazione, che divenne via via più tesa, attirò l’attenzione dei media, tanto che la cittadina di Villa Literno vide arrivare giornalisti delle principale testate giornalistiche, comprese quelle televisive. La colpa di Jerry Maslo, quella che fece pronunciare definitivamente la sua condanna a morte, fu di aver offerto la sua testimonianza ai telegiornali, quella che sarebbe stata ritrasmessa dalla rubrica Nonsolonero del Tg2 il 28 agosto, nel giorno dei suoi funerali che furono, come richiesto dalla Cgil, di Stato, alla presenza di Gianni De Michelis, vicepresidente del consiglio dei ministri, e di altre autorità pubbliche.
«Pensavo di trovare in Italia uno spazio di vita, una ventata di civiltà, un’accoglienza che mi permettesse di vivere in pace e di coltivare il sogno di un domani senza barriere né pregiudizi. Invece sono deluso. Avere la pelle nera in questo Paese è un limite alla convivenza civile. Il razzismo è anche qui: è fatto di prepotenze, di soprusi, di violenze quotidiane con chi non chiede altro che solidarietà e rispetto. Noi del terzo mondo stiamo contribuendo allo sviluppo del vostro paese, ma sembra che ciò non abbia alcun peso. Prima o poi qualcuno di noi verrà ammazzato ed allora ci si accorgerà che esistiamo».
Quando Jerry Masslo fu assassinato era la sera del 24 agosto 1989. La stagione stava volgendo al termine e il giovane sudafricano era rientrato nel capannone di via Gallinelle, dove avevano trovato all’alloggio anche altri ventotto stranieri. Qui entrò un gruppo composto da quattro persone a volto coperto e armate di spranghe, oltre che di armi da fuoco. Per prima cosa cercarono di farsi consegnare dagli immigrati presenti il poco denaro che avevano con loro. Alcuni obbedirono, ma altri si rifiutarono. Bol Yansen, un sudanese di 29 anni, ricevette un colpo alla testa con il calcio della pistola mentre Jerry Masslo fu colpito all’addome tra tre proiettili calibro 7.65 e morì quasi subito non riuscendo a sopravvivere abbastanza da essere sottoposto alle cure dei medici. Ferito invece un giovane del Kenya, Kirago Antony Yrugo.
Dopo i funerali dell’esule sudafricano – funerali a cui parteciparono migliaia di persone – l’eco della prima protesta degli immigrati contro il caporalato crebbe ancora di più e si denunciò in termini ancora più chiari che in precedenza i legami con la camorra. I fatti della provincia di Caserta vennero ricordati anche alla manifestazione romana contro il razzismo del 7 ottobre 1989. Nilde Jotti, ai tempi presidente della Camera, incontrò un gruppo degli immigrati che avevano lavorato con Jerry e l’estate successiva, quella del 1990, a Villa Literno fu inaugurato il «Villaggio della Solidarietà», struttura di accoglienza intitolata alla memoria di Jerry. Però la situazione degli stranieri in città non migliorò.
Altre «cittadelle» della disperazione sorsero in zona tanto che una di queste, arrivata a ospitare fino a duemilacinquecento persone, fu ribattezzata il «ghetto di Villa Literno», una comunità tutta al maschile e tutta di colore che viveva in modo staccato rispetto alla popolazione restante, con propri negozi, barbieri e macellerie. Il ghetto fu incendiato nell’autunno 1994 dai clan presenti in zona mentre si discutevano di interventi e finanziamenti pubblici per il risanamento dell’area. Avvenne il 19 marzo 1994, il giorno in cui Vincenzo Parisi, ai tempi della polizia, era giunto a Caserta per parlare proprio del ghetto. Ma si verificò un fatto che tolse attenzione all’incendio contro gli stranieri schiavizzati e radunati in quel luogo.
Quella mattina, infatti, a Casal di Principe, accanto a Villa Literno, fu assassinato nella sua chiesa il sacerdote antimafia don Peppe Diana e la situazione per i dannati africani del ghetto, «puniti» per aver cacciato uno spacciatore, rimase immutata e un secondo rogo, nell’estate 1994, contribuì a radere al suolo quel luogo. Ma c’è chi non ha mai creduto alla vendetta dei clan per il pusher allontanato dalla «cittadella» degli stranieri. Per qualcuno, quell’incendio, fu «di Stato», annunciato e senza che nessuno fermasse chi voleva appiccarlo. Lo affermò monsignor Raffaele Nogaro, vescovo di Caserta, come avrebbe in seguito ricordato Renato Franco Natale, un medico di base che nell’estate 1989 era segretario della federazione del Pci di Casal di Principe (entrerà poi a far parte dell’Associazione Jerry Essan Masslo divenendone presidente) e secondo lui quel duplice incendio fu una punizione per il clamore sollevato dagli stranieri nei precedenti cinque anni, a iniziare dalla rivolta a cui aveva partecipato Jerry Masslo.
Tuttavia, come accaduto molte volte in passato e come sarebbe accaduto ancora molte volte in futuro, una volta che la situazione degli stranieri non aveva più rappresentato un argomento di attualità, sembrava che quegli uomini e quelle donne si fossero dissolti nel nulla. Eppure, nel corso del tempo, sono sempre stati lì, ad attendere prima dell’alba il furgoncino dei caporali che avrebbero caricato, come avvenuto altrove, prima solo africani e poi i nuovi schiavi provenienti dall’Europa orientale. E che mai se ne sono andato – semmai sono cambiati – c’è un documentario che nel 2012 ha vinto proprio quel premio intitolato a Jerry Masslo, per il cui omicidio sono stati condannati in via definitiva Giovanni Florio, Giuseppe Caputo e Michele Lo Sapio, tre ragazzi che decisero di raccattare un po’ di denaro approfittando dello stato di alcuni degli oltre seimila stranieri assiepati a Villa Literno.
È stato realizzato con un semplice telefono cellulare da due fratelli, Adam e Jean Yameogo, nati in Burkina Faso e provenienti dalla Costa d’Avorio. Ed è stato il loro modo per reagire a una realtà schiavistica fatta di dormitorio ben più che fatiscenti, appuntamenti con i caporali, le ore nei campi nelle campagne della Capitanata, le angherie e il ritorno al campo-dormitorio perché tutto ricominci da capo. Il documentario, che dura 18 minuti e che è visibile all’indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=OqW-N_710fc, si intitola «Lo sfruttamento degli immigrati in Puglia. Caporalato e raccolta dei pomodori» ed è stato premiato – ha spiegato la giuria – perché “non solo racconta le terribili condizioni di vita e di lavoro degli immigrati africani nel foggiano, ma perché le rappresenta dall’interno, mostrando aspetti del loro lavoro che difficilmente avrebbero potuto essere ripresi da un occhio esterno”.
La tarda modernità del caporalato
Alcune dei punti raccontati finora si trovano anche nel libro di Pietro Alò. E nel volume tante altre se ne possono trovare, soprattutto nella parte dedicata alle “storie di vita”. Scorrendo le pagine del lavoro del sociologo, molteplici sono i riferimenti alla “vita vissuta”, raccolti in interviste che si intersecano all’analisi più teorica del fenomeno. Da qui ne discende che “il caporalato, in quanto raccolta, trasporto, organizzazione e collocazione produttiva di merce lavoro, si presenta quale modello produttivo e di tipo sociale, arcaico, secondo i canoni della precedente ‘fase espansiva della modernità’”. Una fase che ha saputo trarre profitto dalla globalizzazione essendo “fenomeni della tarda modernità [che] costituiscono due approdi-limite che sottopongono a inedite forzature le contraddizioni sociali.
Lo testimoniano anche fatti successivi alla morte di Pietro Alò, come ciò che avvenne il 18 settembre 2008 a Castelvolturno, quando si consumò una strage in cui vennero ammazzati un pregiudicato campano, Antonio Celiento, gestore di una sala giochi e sospettato di essere un informatore delle forze dell’ordine, e sei cittadini stranieri, i ghanesi Kwame Antwi Julius Francis, Affun Yeboa Eric e Christopher Adams, i togolesi El Hadji Ababa e Samuel Kwako e il liberiano Jeemes Alex. Quella mattanza era stata voluta da Giuseppe Setola, erede dell’ala scissionista del clan dei casalesi e capo dell’ala stragista dell’organizzazione, arrestato dai carabinieri il 14 gennaio 2009 quando compariva nell’elenco del trenta latitanti più pericolosi d’Italia. E senza andare a scomodare fenomeni di marca più nitidamente mafiosa, per comprendere la portata che il caporalato ha ancora oggi basta leggere un ultimo passaggio del libro di Alò: “Il fenomeno […] si configura come ‘anticipazione del neoliberismo’. D’altro canto, sotto questo preciso aspetto, il neoliberismo si configura come una modernizzazione barbara perché non produce modernità, ma ritorno allo schiavismo”.
Category: Lavoro e Sindacato, Libri e librerie
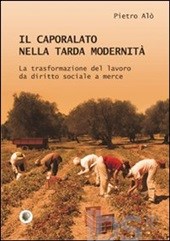


[…] Continua a leggere sul sito dell’Associazione il manifesto in rete (qui e qui) oppure su Inchiesta online […]