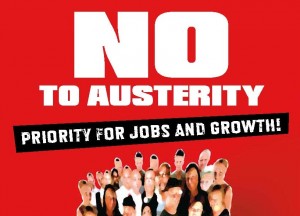Antonio Lettieri: La politica dell’austerità ha fallito. Cambiarla è possibile
L’austerità si rivela un concetto ingannevole. Applicato agli individui, allude a un’attitudine frugale, sobria: un tratto apprezzabile della personalità. Applicata all’economia, in Europa, ha finito col significare deflazione e attacco ai diritti e alle tutele sociali: in pratica, recessione, disoccupazione di massa, crescita della diseguaglianza, aumento della povertà.
Da dove deriva questo capovolgimento di senso?
1. L’austerità
La politica di austerità nell’eurozona ha un’origine perversa. Le autorità dell’eurozona, dopo la crisi iniziata col collasso della Lehman Brothers negli Stati Uniti, imposero ai paesi della periferia dell’eurozona – Irlanda, Portogallo, Grecia – di salvare le rispettive banche nazionali colpite dalla crisi derivante dalle speculazioni finanziarie e immobiliari. La ragione è che senza il loro salvataggio la crisi avrebbe travolto i loro creditori: vale a dire, le grandi banche inglesi, tedesche e francesi. La conseguenza fu l’esplosione del deficit di bilancio e del debito dei paesi della periferia. In altre parole, le banche dei paesi dominanti furono salvate a carico dei contribuenti e dei cittadini dei paesi più deboli.
Ma non basta. Infatti, le autorità dell’eurozona, dopo aver fatto crescere a dismisura il deficit e il debito dei paesi coinvolti nella crisi bancaria, gli imposero il rientro nei parametri del Fiscal Compact. In poche parole: una politica di aumento delle tasse e di riduzione della spesa pubblica, che condannava questi paesi alla recessione e a un enorme aumento della disoccupazione.
Diventata il paradigma dominante della Commissione europea e della Germania, l’austerità divenne il teorema imposto alle maggiori economie dell’eurozona – Spagna, Italia e Francia – che, in modi diversi, soffrivano l riflessi della crisi che aveva preso le mosse dagli Stati Uniti fra il 2007 e il 2009.
Vale la pena di ricordare, a questo proposito, che negli Stati Uniti, il presidente della FED, Ben Bernanke, reagì alla crisi finanziaria, riducendo i tassi e inondando il mercato di liquidità, mentre il neo-eletto presidente, Barack Obama, con una manovra fiscale da ottocento miliardi dollari, puntava a rilanciare l’economia.
Nell’eurozona, accadde il contrario: la BCE, guidata da Jean-Claude Trichet, incredibilmente aumentò i tassi d’interesse per combattere l’inflazione (inesistente), mentre la Commissione europea imponeva agli stati membri una politica di bilancio restrittiva.
Per riprendere il paragone, spesso evocato, con la crisi del 1929, possiamo dire che la politica dell’eurozona può essere confrontata a quella basata sulla liquidazione dei debiti rovinosamente attuata da Andrew Mellon, il ministro del Tesoro americano dell’inizio degli anni Trenta. Ma con una grande differenza. Allora, tre anni dall‘inizio della crisi, la presidenza fu conquistata da Franklin D. Roosevelt che adottò un’audace e rivoluzionaria politica economica diretta a rilanciare l’economia e l’occupazione, promuovendo al tempo stesso il New Deal, la più grande rivoluzione sociale del secolo XX in un paese capitalista.
Nell’eurozona la crisi non solo non è stata arrestata ma si è progressivamente aggravata. I dati sono eloquenti.
Nel 2010, la disoccupazione era allo stesso livello negli Stati Uniti e nell’eurozona: il 10 percento della popolazione attiva. Qual è la situazione cinque anni dopo? Negli USA è dimezzata, toccando il 5 per cento; nell’eurozona non solo non si è ridotta, ma ha continuato ad aumentare. In Italia, per fare un esempio, è raddoppiata, passando dal 6 per cento pre-crisi al 12 per cento. Ancora niente rispetto alla Spagna e alla Grecia, dove la disoccupazione ha raggiunto il raccapricciante livello del 22 e 25 per cento rispettivamente.
Il confronto si rivela impietoso non solo nei confronti degli Stati Uniti, ma anche nei confronti di paesi del’Unione europea, fuori dell’eurozona come il Regno Unito, la Svezia e la Polonia che hanno raggiunto tassi di crescita del reddito nazionale intorno al tre per cento; mentre nell’eurozona il dibattito è ancora ridicolmente centrato su possibili tassi di crescita dello zero virgola qualcosa.
La prova del fallimento della politica di austerità non potrebbe essere più clamorosa.
2. Le riforme strutturali
In effetti, anche le autorità dell’eurozona hanno dovuto, sia pure in ritardo, prenderne atto, riqualificando la loro politica in direzione delle “riforme strutturali”. Non che l’austerità sia stata abbandonata. Ma non è più l’obiettivo principale. E’ diventata piuttosto lo strumento, l’arma, per imporre le loro riforme strutturali.
Così,dopo quella dell’austerità, assistiamo a una nuova metamorfosi concettuale. Le riforme che, nella vecchia tradizione politica, erano il patrimonio della sinistra, assumono un significato rovesciato di smantellamento delle conquiste sociali che, nei settori del lavoro e dello stato sociale avevano caratterizzato la seconda parte del XX secolo.
Si tratta di un passaggio decisivo, spesso sottovalutato anche da chi non condivide la politica praticata nell’eurozona. Vi è una vasta schiera di economisti americani ed europei che criticano l’austerità, ma non si esprimono sulla politica di riforme strutturali, o le sostengono come strumento di modernizzazione (!) dell’economia dell’eurozona.
Il lungo ed elastico catalogo delle riforme serve a mascherare dietro quelle che sarebbero le più ovvie e auspicabili – una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni, il contrasto all’evasione fiscale, la lotta alla corruzione, che peraltro rimangono nel libro dei sogni – quelle che hanno una chiara impronta ideologica neoconservatrice e un impatto sociale dirompente.
In effetti, la caratteristica specifica delle riforme strutturali – peraltro le uniche realizzate o programmaticamente centrali – può essere sintetizzata in tre obiettivi fondamentali: la privatizzazione di ciò che rimane di pubblico e genera (o è suscettibile di generare) profitti; il drastico taglio della spesa sociale con la contemporanea privatizzazione di quote crescenti di welfare; la definitiva deregolazione del mercato del lavoro, accompagnata alla demolizione del potere contrattuale dei sindacati.
In una virtuale gerarchia del tasso d’incidenza sui rapporti sociali di potere, le riforme del lavoro rappresentano senza ombra di dubbio la punta di lancia della politica “riformista” del nuovo secolo. La compressione dei salari e la libertà dei licenziamenti è l’approdo della lunga marcia della precarizzazione del lavoro.
E non può non apparire stupefacente l’impegno col quale le autorità dell’eurozona – dalla Commissione europea alla BCE – intervengano nel dettaglio dei cambiamenti della legislazione del lavoro e dell’ordinamento contrattuale con l’esaltazione della centralità della contrattazione a livello aziendale; come dire, il livello al quale, sotto l’urto della crisi, più fragili e più ricattabili sono i sindacati e i lavoratori confrontati con la compressione dei salari e il peggioramento delle condizioni di lavoro, da un lato, e la minaccia della perdita del lavoro, dall’altra.
Il binomio austerità-riforme strutturali si rivela come lo strumento di una “moderna” lotta di classe non dichiarata, ideologicamente mascherata dall’apparente neutralità di tecnocrazie non elette, barricate nelle istituzioni europee.
3.Complicità e logoramento della democrazia
L’attacco al modello sociale europeo si accompagna a un profondo logoramento dei regimi democratici. Non è un caso che la caratteristica storica dei regimi politici europei, l’alternanza tra governi di sinistra e di destra, abbia perduto ogni effettivo significato. Non solo il bilancio ma l’intera politica economica sono soggetti alla previa approvazione della tecnocrazia di Bruxelles. Siamo di fronte all’umiliazione di quel che restava della sovranità nazionale e di un normale funzionamento della democrazia. I programmi di governo sono predefiniti, sorvegliati e sanzionati dalla Commissione europea.
Il Fiscal compact (formalmente, Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione economica e monetaria) che regola la politica di bilancio degli stati membri è la chiave di volta della politica neoconservatrice del’eurozona. Varato nel 2012, Il tratto che lo caratterizza è che si tratta di un accordo intergovernativo che, sulla base della sua sperimentazione, dovrebbe essere integrato nei Trattati europei nel 2018. All’apparenza,doveva servire ad avviare il superamento della crisi. Dopo tre anni di applicazione, il bilancio non potrebbe essere più disastroso.
Di che si tratta? Il Fiscal compact, da un lato, rende vincolante il pareggio di bilancio e impone – innovando rispetto ai trattati comunitari – un meccanismo di correzione automatica per il superamento dei gradi di avanzamento imposti. Dall’altro, andando al di là delle regole previste dal Trattato di Maastricht, stabilisce l’obbligo di ridurre di un ventesimo all’anno la quantità di debito che eccede il 60 per cento del PIL. Obiettivi chiaramente irraggiungibili e insensati In un contesto di stagnazione economica e di disoccupazione di massa.
Si consideri il caso italiano. Nel corso dei prossimi due anni, un ammontare cumulativo di almeno cinquanta miliardi di euro dovrà essere sottratto all’economia per raggiungere la parità di bilancio. Ma non basta. Nei prossimi anni tra quaranta e miliardi di euro all’anno dovranno essere riservati alla riduzione del debito.
La follia di questo disegno si estende a tutti i paesi dell’eurozona con disavanzi di bilancio. La Francia, per esempio con un debito più basso, ma con un disavanzo fiscale quasi doppio di quello italiano, per pareggiare il bilancio entro il 2018 dovrà sottoporsi a un salasso ancora più devastante.
Tutto questo mentre alla fine del 2015 i governi dell’eurozona tentano faticosamente di guadagnare una “flessibilità” di zero virgola due o tre punti rispetto al livello di disavanzo imposto dagli ineffabili gnomi di Bruxelles.
L’accordo di bilancio non solo si è dimostrato insensato dal punto di vista economico, ma ha anche definitivamente sancito la requisizione della sovranità democratica dei parlamenti nazionali in favore di organismi tecnocratici non eletti come la Commissione europea e la Banca centrale europea.
Il Fiscal compact ha un vizio di origine. Infatti, è stato immaginato e approvato sotto il ricatto della crisi finanziaria e senza un effettivo dibattito democratico, mentre veniva respinta la richiesta di un referendum popolare avanzato in alcuni paesi. Nessun governo dell’Unione europea, (solo il Regno Unito si è tenuto fuori dall’accordo), voleva correre il rischio di essere sconfessato da un voto popolare. Brucia ancora il ricordo del referendum del 2005, quando francesi e olandesi respinsero a larga maggioranza il progetto costituzionale europeo.
4. C’è una via d’uscita?
Esiste un’alternativa all’attuale politica dell’eurozona? Per rispondere è necessario partire dalla politica monetaria.
Il “quantitative easing” varato dalla BCE di Mario Draghi di si è rivelato uno strumento efficace per arrestare l’attacco dei mercati finanziari all’euro. Incontra, tuttavia, un limite che ne vanifica le potenzialità e l’efficacia. Il limite è nell’orientamento deflazionistico della politica fiscale dell’eurozona. E’inutile gettare denaro dall’elicottero, come raccomandava Milton Friedman, se può cadere solo nelle mani di banche e fondi speculativi, che non hanno né interesse, né convenienza a investire in beni e servizi in un quadro di stagnazione economica.
In un contesto di caduta della domanda e della crescita che paralizza gli investimenti privati, la chiave della crescita è in una politica di investimenti pubblici. Con un costo del denaro pari o inferiore a zero, un alto tasso di disoccupazione, crollo dei prezzi delle materie prime, gli investimenti pubblici non potrebbero aspirare a una situazione più favorevole. Rinunciarvi è economicamente sbagliato e politicamente irragionevole.
Sia chiaro, non investimenti speculativi e a lunga scadenza. Vi sono aree che reclamano un intervento pubblico immediato, di rapida attuazione e di elevato impatto sulla crescita e l’occupazione. L’elenco si presenta con un’indiscutibile evidenza: infrastrutture essenziali, manutenzione del territorio e risanamento del tessuto urbano, trasporti, energie alternative, ricerca e istruzione, per fare solo alcuni esempi.
Vi è di più. Una massa di investimenti pubblici in quadro macroeconomico favorevole genera l’effetto che gli economisti definiscono “moltiplicatore fiscale” che ne potenzia l’impatto sulla crescita. Larry Summers e una numerosa schiera di economisti ritengono coerente col quadro attuale la stima di un moltiplicatore fiscale pari a due. Come dire che l’aumento della crescita derivante da un amento mirato della spesa pubblica è in grado di generare un gettito fiscale in grado di compensare in un prevedibile lasso di tempo il deficit aggiuntivo. mentre, allo stesso tempo, contribuisce alla riduzione del rapporto debito-PIL, procurando la crescita del denominatore.*
E’ una soluzione economicamente attuabile? Lo è per il fatto stesso che rovescia il “moltiplicatore fiscale negativo” della politica di austerità, perversamente destinato a ridurre la crescita e le entrate fiscali, producendo insieme stagnazione, disoccupazione e aumento del debito. Che è esattamente la patologia auto-disruttiva dell’eurozona.
Il problema, come abbiamo visto, non è nella politica monetaria, ma nel blocco della politica di bilancio e nei vincoli irrazionali imposti dalla gestione del Fiscal compact. In altri termini, nel divieto di finanziamento della spesa pubblica aggiuntiva destinata ad investimenti in grado di generare crescita e all’occupazione.
La soluzione evidente quanto ragionevole è nel rovesciamento della politica di austerità. In termini concreti significa la sospensione dell’applicazione del Fiscal compact almeno fino a quando la crescita non abbia raggiunto un livello confrontabile con quello che si registra nelle aree esterne all’euro, intorno al tre per cento in terni reali, o al cinque per cento nominali sulla base di un aumento fisiologico del tasso d’inflazione.
Che si tratti di una soluzione economicamente fattibile e politicamente razionale sarebbe difficile negarlo. Il problema è nella trappola della complicità che lega gli attuali governi nazionali di centro destra come di centrosinistra alla linea fondamentalista delle autorità europee, sostenute dal governo tedesco.
E’ difficile azzardare previsioni. Ma non siamo lontani dalla realtà, affermando che la maggioranza dei cittadini dei paesi dell’eurozona sono contrari alla politica imposta da Bruxelles e Berlino con l’acquiescenza e la complicità delle classi dirigenti nazionali.
5.L’alternativa possibile
Il quadro politico è tuttavia in movimento.
In Francia, François Hollande ha il sostegno popolare più basso nella storia della Quinta Repubblica. In Spagna, il governo conservatore di Mariano Rajoy appare destinato alla sconfitta nelle elezioni di fine anno. In Italia, Matteo Renzi deve avvalersi del supporto dei fuorusciti da Forza Italia per attuare la sua politica di riforme: dalla Costituzione al modello elettorale e al Jobs Act –riforme che suscitano invidia negli esponenti dei vecchi governi di Berlusconi.
Le recenti elezioni in Portogallo sono un segnale significativo. Non solo il governo di centro-destra di Passos Coelho ha perduto la maggioranza assoluta dopo quattro anni di governo subalterno all’asse Bruxelles-Berlino. La novità è che, per la prima volta, l’intero arco delle forze di sinistra, dal Partito socialista al Blocco di sinistra e al Partito Comunista, è schierato su una piattaforma di opposizione alla politica di austerità.
E’ interessante che questo nuovo tipo di alleanza, che raccoglie l’intero schieramento della sinistra dopo decenni di divisione, si presenti con una piattaforma che supera l’alternativa fra “stare dentro “ o abbandonare l’euro.
Una scelta radicale di uscita dall’euro è attualmente un motivo di divisione all’interno delle forze di opposizione, nei sindacati, nell’opinione pubblica. Al contrario, una chiara e decisa politica anti-austerità può essere facilmente condivisa da un vasto schieramento di forze politiche di opposizione , anche in presenza di differenze di tradizioni e di orientamento politici.
Un referendum popolare fondato su questa base avrebbe grandi probabilità di successo anche in paesi decisivi come la Spagna, la Francia e l’Italia (dove, per inciso, secondo i sondaggi dell’Eurobarometro della Commissione europea, una larga maggioranza si dichiara contraria alla politica corrente dell’eurozona).
In un nuovo scenario nel quale riprendano la parola i cittadini attraverso le elezioni (per esempio, in Spagna nella prospettiva di un accordo PSOE-Podemos dopo le elezioni di fine anno) o mediante l’arma di un referendum, la politica di austerità nel suo mix con le riforme strutturali è destinata a rivelarsi per quello che è: una lenta quanto inesorabile agonia dell’eurozona e una minaccia per la stessa esistenza dell’Unione europea.
Al tempo stesso, la dottrina Schäuble agitata contro la Grecia – rigorosa applicazione del Fiscal compact o uscita dall’euro – si mostrerebbe inconsistente oltre che arrogante. Questo ricatto difficilmente potrebbe essere ripetuto nei confronti dei maggiori paesi della zona euro, come la Spagna, l’Italia o la Francia, senza innescare la disintegrazione dell’ euro,e mettendo in crisi la politica della Germania, che è la maggiore beneficiaria della moneta unica.
Per concludere, un’ alternativa alla attuale politica europea appare possibile e realizzabile. La politica di austerità del Fiscal compact è fallita. Quando un patto finalizzato a risolvere una crisi mostra la sua impotenza, anzi ha effetti contrari a quelli supposti, bisogna prenderne atto, prima che sia troppo tardi. Sospenderne l’attuazione è ragionevolmente il minimo indispensabile.
Gli antichi Romani, maestri del diritto decretarono che “Ad impossibilia nemo tenetur”: vale a dire che nessuno può essere obbligato a rispettare un impegno diventato impraticabile. E alla lunga autodistruttivo.
————————–
* Brad DeLong e Larry Summers “Fiscal Policy in a Depressed Economy”( 2012).
https://files.acrobat.com/a/preview/1486d8dc-633a-48f3-a338-96084e180193
Category: Economia, Lavoro e Sindacato, Osservatorio internazionale