Università Fertile: il punto di vista della differenza
Devo tornare indietro nel tempo, perché leggere il testo a cura di Anna Maria Piussi e Remei Arnaus, 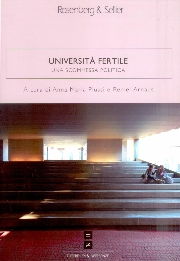 (Rosenberg & Sellier, 2011) è stato come ripercorrere un sentiero a ritroso, nel quale gradualmente emergono il vissuto, i ricordi e il dibattito che circonda l’istruzione, l’educazione, e l’università pubblica.
(Rosenberg & Sellier, 2011) è stato come ripercorrere un sentiero a ritroso, nel quale gradualmente emergono il vissuto, i ricordi e il dibattito che circonda l’istruzione, l’educazione, e l’università pubblica.
Allora vorrei tornare ad alcuni anni fa, quando insegnavo in una piccola scuola elementare per bambini rurali a due ore dalla città di Coimbatore, nel Tamil Nadu, India. La scuola, gestita completamente da volontari, era ispirata liberamente a Maria Montessori, fascinosamente interpretata secondo la tradizione induista. All’entrata della scuola c’era un cartello con la scritta “What are you standing for?”, che stai fermo a fare?, e le insegnanti, quasi tutte donne, vi arrivavano in buona parte appositamente dagli Stati Uniti. In quegli anni ritornavo in India ogni qualvolta potevo, nel resto del tempo insegnavo corsi introduttivi di Sociologia in un’università pubblica del Sud-Est americano. Insieme alle insegnanti, docenti e studenti che come me attraversavano l’oceano per tornare in quelle splendide terre rosse, capivo chiaramente di essere all’intersezione di due modi fortemente diversi di intendere l’istruzione e la didattica. A differenza delle piccole casette indiane, il campus statunitense era un fabbricato geometrico chiuso alla società, ove la produzione di sapere seguiva le rigide regole della produzione fordista. Dall’amministrazione centrale ai dipartimenti, ai laboratori, ai centri, sino ad ogni unità di ricerca e agli studenti, l’erogazione di lavoro cognitivo era scandita da ritmi e tempi rapidi, volti ad aumentare il numero di articoli scritti, il numero di citazioni fatte e ricevute, la quantità di fondi richiesti, in un continua somma di dare e avere, debiti e crediti formativi e economici, che sembrava sfociare continuamente in una sorta di autoreferenzialità. All’epoca non avevo gli strumenti teorici per capire, mi rendevo semplicemente conto che quell’accademia, quella sorta di management cognitivo, non amava la conoscenza in sé, era un processo di produzione di saperi molto spesso fine a se stesso, fondato sulla continua, insaziabile, inerziale proliferazione di parole, un mondo in cui la sola regola era up or out, come scrive Deleuze, competi o sei fuori. Sarà stato il Sud o il contesto lacerato dall’antagonismo razziale, ma per me l’eccellenza statunitense era quella: uffici nervosi aperti il sabato e la domenica, pc accesi tutti i giorni e tutte le notti, luci al neon che nutrivano il sapere di elettricità ansiogena, stress, iperlavoro, obesità, depressione, esaurimento, alcolismo, debito e solitudine, in un funzionalismo produttivo efficientissimo cui facevano da contrappunto vite dysfunctional. Ancor oggi mi rendo conto che queste immagini cozzano con la fotografia sorridente dell’erba verde dei campus d’oltreoceano. Eppure basta leggere i testi diRichard Arum e Josipa Roksa, di Andrew Hacker e Claudia Dreifus, i racconti allarmati di John Taylor Gatto in Dumbing us Down, o ricordare Bowling for Columbine, per percepire la violenza costitutiva di quel mondo. In verità, l’eccellenza è una cosa complessa. L’eccellenza è lusso intellettuale, per così dire. È elite bianche e ghetti neri, le scuole private delle gated communities e quelle definanziate delle inner cities. È la scuola per l’1%, potremmo dire, la cui prima legittimazione è la minaccia d’esclusione. Ecco che studiare significava pagare altissime rette e competere, cercare la mobilità sociale per evitare gli inferi, indebitarsi prima per non indebitarsi poi, vivere precari prima nella speranza di non vivere precari poi. Ironicamente, nell’assenza di tutele sociali, la soluzione era dunque il problema, e l’università diventava, per parafrasare Ivan Illich, “un’agenzia pubblicitaria che ti fa credere di avere bisogno della società così com’è” (1972, p. 167).
Fatto sta che non appena potevo scappavo. Nella piccola scuola indiana c’erano quaranta bimbi dai cinque ai quattordici anni. Non v’erano processi valutativi, promozioni o bocciature, voti alti o bassi. Il voto, secondo Maria Montessori, preclude lo scambio di esperienze e il confronto non competitivo, oltre a essere, come diceva Paulo Freire, un deterrente rispetto alla trasformazione di sé. Ricordo che la scuola era aperta la mattina, il pomeriggio e la sera sette giorni su sette, in un piccolo paesino ai piedi delle montagne di Velliangiri. Non era aperta per competere, però, ma per scoprire. A che serve riposare quando puoi conoscere? Ad ogni modo, non tutti vi potevano insegnare. Ci volevano i titoli, certo, ma i titoli non erano sufficienti. Gli insegnanti non devono avere violenza negli occhi, ci veniva detto, perchè lo scopo dell’insegnamento non è inibire, o giudicare, ma consentire a ogni bimbo di dispiegare il proprio potenziale. Ecco che ogni studente doveva costruire da sé il proprio programma di studi, cercare i materiali che più rispondevano alla sua curiosità, e il nostro compito era stimolare alla condivisione, piuttosto che alla competizione; alla responsabilità, piuttosto che alla punizione. I risultati in generale erano sorprendenti. Qualunque l’età di arrivo di questi bimbi nella scuola, già dopo pochi mesi i più grandi cominciavano ad aiutare i piccoli, i più timidi imparavano ad esprimere corpo e parole con la danza e le arti visive, e in generale chiunque entrasse in quelle piccole mura vedeva l’intelligenza in germoglio dispiegarsi in un cicaleccio di vitalità.
Sarà forse per questo, o per altre ragioni che non so spiegare, l’istruzione per me è rimasta un nodo. Da allora il ricordo dell’intelligenza viva, calda e corporea di queste comunità rurali, ha trovato una sua lontana sedimentazione nella mia mente, quasi il mondo in cui viviamo fosse troppo distante per convivervi. Però, dopo aver visto gli effetti comprimenti della normalizzazione e della standardizzazione, le conseguenze destoricizzanti dello studio ossessivo dei test, la palese divergenza degli effetti educativi di queste due forme di insegnamento, il problema del perchè di una tale influenza di precetti liberal-tayloristi nella conoscenza, così improbabile dal punto di vista pedagogico, è diventato centrale. Cosa e come insegni oggi è il mondo in cui vivrai domani, e in questo contesto mi sembrava importante capire dove come quando e perchè l’organizzazione dell’istruzione è passata dalla dimensione generativa del sapere alla pedagogia del mercato. Ecco che il testo a cura di Anna Maria Piussi e Remei Arnaus offre finalmente l’occasione per abbozzare una risposta, mettere in dialogo codici discorsivi differenti, spostando il discorso dalle falle del discorso dominante, al concetto di conoscenza come esperienza trasformativa, corporea, relazionale, viva. Sarà perchè Anna Maria Piussi e Remei Arnaus sono due docenti ordinarie che da anni si occupano di pedagogia e di educazione, oppure perchè sono due donne, le autrici sono riuscite in un lavoro complesso. A partire da “l’amore per l’intelligenza e per ciò che la nutre”, per usare le parole introduttive di Federica Giardini, “che traspare in ogni singolo testo”, il libro penetra lo “scontro tra due diverse e grandi misure, la ‘pedagogia del capitale’ e la ‘creazione sociale’, come felicemente la nomina Antonia De Vita” (p. 8). Ecco che da un lato il testo penetra il Bologna Process, la valutazione, l’eccellenza, la competizione, e in generale le categorie dell’ortodossia mainstream nel tentativo di metterne in luce la miopia sociale, o le finalità politiche. Dall’altro, esso ripone al centro di questa narrazione la singolarità, il concetto di conoscenza come esperienza relazionale, e il ruolo della donna al suo interno. Vorrei soffermarmi un istante qui, sul ruolo della donna, perchè giustamente, come spiega Antonia de Vita, nonostante la femminizzazione dell’università sia un processo assestato e continuo, l’Università è rimasta “un mondo senza donne”, ove l’indurimento dei rapporti umani, così compressi nella gerarchia e la competizione, adombra il nuovo che la differenza porta con sé, quasi chiudendo in una ragnatela il potenziale affettivo ed espressivo delle relazioni, in una contraddizione che “mette a rischio la possibilità di craere contesti civilizzatori in uno spazio pubblico come l’università” (p. 127). Situata nel corpo femminile, pertanto, questa riflessione pone il problema della conoscenza come espressione e trasformazione, pur ben conscia di farlo in un contesto sociale antagonista, duro e inasprito dal declino italiano, ripensando la costruzione delle conoscenze, lo scambio e la circolazione dei saperi, sino a tessere un sentiero ove ad ogni passo emergono immagini, citazioni e ricordi.
Nello scorrere le pagine mi tornavano così a mente le parole di Ellwood Cubberley, un sovraintendente della pubblica amministrazione nella scuola pubblica di San Francisco, che già nel 1916 scriveva testualmente: “le nostre scuole sono fabbriche in cui il prodotto grezzo, il bambino, viene modellato e confezionato in prodotti capaci di affrontare le necessità della vita”. Mi tornava in mente The Role of Government in Education” di Milton Friedman (1962), testo chiave per aprire all’invasione dell’ortodossia mainsteram nelle scuole. Così comelo sposalizio tra il capitalismo cognitivo e le istituzioni della conoscenza, le modalità con cui Sylicon Valley, Apple, Dell, IBM, HP, Compaq, Palm, and Texas, per citarne alcune, hanno cominciato a investire nell’istruzione vendendo tecnologie standardizzate, didattica standardizzata, test standardizzati quali lo Stanford Achievement Test (SAT), Iowa Test of Basic Skills (ITBS), California Test of Basic Skills (CTBS). E allora tornano alla mente l’Invalsi, Google Scholar e l’Impact Factor, l’uso di strumenti di indicizzazione e catalogazione algoritmica dei saperi per valutare “l’impatto” della produzione accademica, dove poi non si sa, se non nell’anima degli studenti. E ancora il recente Decreto 437, appena approvato e subito modificato, esempio perfetto di come oramai la stessa cultura universitaria sia funzione di indici e algoritmi, e da quelli dipenda la politica culturale del nostro futuro. Insomma, mi tornano alla mente molte cose, ma soprattutto la teoria finemente tratteggiata da Freire, Illich, Dewey, Decroly, Freinet o bell hooks, e le parole di Szymborska (1998) “non delirano i sogni, delira la realtà”.
Possiamo realmente lasciare in mano il cosa e il come dell’istruzione a una serie di calcoli autistici banalmente tarati sul dare e l’avere, così grezzi rispetto a una materia sensibile come la vita emotiva delle generazioni di oggi e di quelle a venire? Forse anche no, mi vien da dire. Non solo perchè, ci ricordano le autrici, lo stanno dicendo in tutte le lingue gli studenti che quest’educazione la frequentano, dal Cile all’Inghilterra, dall’Onda al movimento Occupy. Ma perchè lo stesso scopo della conoscenza è “la ricerca di un’altra strada […] la strada di far esistere ciò di cui si ha bisogno e desiderio […] delineando un altro e più grande orizzonte, […] una realtà più vera e umana” (Piussi, 21).
Pubblicato su Micromega il 13 aprile 2012
Category: Donne, lavoro, femminismi, Libri e librerie, Scuola e Università

