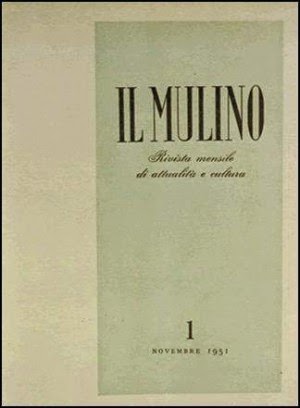E’ morto l’amico Luigi Pedrazzi: un cattolico di sinistra di travolgente simpatia
Martedì sera, il 27 giugno 2017, è morto a Bologna a 89 anni Luigi Pedrazzi tra i fondatori della rivista “Il Mulino” e protagonista attivo della vita politica bolognese. I suoi funerali si svolgeranno sabato 1 luglio alle 11 presso la chiesa di Sant’Antonio da Padova, il cui parroco è don Giovanni Nicolini, in via della Dozza 5/2 a Bologna.
Ho messo in alto la foto di Luigi Pedrazzi insieme a quella di Giovanni Evangelisti (direttore della Casa editrice Il Mulino) perché è stato il mio carissimo amico Giovanni (conosciuto nei primi anni ’60 a Milano attraverso Angelo Pagani) a portarmi a Bologna aprendomi le porte della casa editrice Il Mulino e organizzandomi l’incarico di sociologia a Magistero (che ho iniziato nel 1968). Ho potuto così conoscere Luigi Pedrazzi (Gigi) da più di cinquanta anni e il ricordo che ne ho è quello che ho cercato di sintetizzare nel titolo. Gigi è stato da sempre cattolico di sinistra [si definisce “cattolico ma non democristiano, laico ma non laicista, aspramente critico dell’Unione Sovietica ma non anticomunista.”) e le sue tappe di attività politica e culturale sono contrassegnate da una sua particolare caratteristica: ha sempre pagato di persona le sue (nostre) iniziative .
Laureato in filosofia con Felice Battaglia ha poi studiato con Benedetto Croce all’Istituto per gli studi storici di Napoli. A Bologna insegna filosofia nei licei. Nel novembre 1951 esce il primo numero della rivista “Il Mulino” e Luigi Pedrazzi fa parte (vedi foto sotto) del suo gruppo promotore (sarà direttore de “Il Mulino” dal 1961 al 1965). Nel giugno del 1954 fonda, insieme ai promotori del gruppo Il Mulino, la Casa editrice a cui cede l’eredità ricevuta dalla nonna Stella Pedrazzi fondatrice dei famosi “Tortellini marca Stella” che venivano venduti anche alla stazione perché erano fabbricati in modo tale da poter restare integri e utilizzabili per molti giorni (Gigi mi ha raccontato che la sua famiglia li portava nelle vacanze al mare e duravano almeno un mese). Nel 1956 si candida al consiglio comunale di Bologna con la DC nella lista di Giuseppe Dossetti ed inizia la sua carriera di consigliere comunale nel Comune di Bologna dal 1956 al 1964. Nel 1974 è alla guida dei «Cattolici per il no», i cattolici che votarono per il mantenimento del divorzio al referendum. Nel 1975 insieme a Ermanno Gorrieri fonda e dirige il quotidiano “Il foglio” di Bologna per diffondere un giornale che si opponesse al “Resto del Carlino”, quotidiano di destra da sempre oppositore del gruppo de Il Mulino. E’ un esperimento straordinario con una redazione di giovani e uno stile molto vivace ma non viene premiato dalla vendita delle copie e Gigi deve vendere gli ultimi appartamenti della sua eredità personale derivata dai Tortellini Stella per pagare tutti i debiti del giornale e i collaboratori. Le interviste a Luigi Pedrazzi riportate mostrano la coerenza della sua linea politica: l’impegno nel cercare di salvare Moro prigioniero dei brigatisti, il suo coinvolgimento diretto con i giuslavoristi bolognesi estensori dello Statuto dei lavoratori e il suo impegno per realizzare il progetto dell’Ulivo (ci sono molti suoi libri e saggi pubblicati su questo tema). Nel 1995 ricopre la carica di vicesindaco con Valter Vitali sindaco, primo cattolico ad avere quella carica a Bologna. Nel 2014 riceve l’Archiginnasio d’oro per aver “sempre dimostrato una passione civile che ne fanno uno dei bolognesi più autorevoli e uno dei cittadini italiani che più hanno chiaro il senso delle istituzioni e l’impegno della cultura nel vivere civile” e nelle motivazioni del conferimento, viene sottolineato anche e soprattutto che “la sua statura intellettuale e morale, unita a una singolare modestia nello stile di vita, ad un grande disinteresse personale, ad una rara capacità di ascolto e di servizio, è stata e sarà un punto di riferimento per tutti i cittadini e le cittadine di Bologna. Per il suo importante contributo all’evoluzione civile della nostra comunità e del paese, per quanto ha saputo arricchire e valorizzare l’immagine culturale di Bologna, la città gli è grata”. Quella è stata l’ultima occasione pubblica in cui l’ho potuto salutare.
Leggendo le interviste e la sequenza delle attività politiche di Luigi Pedrazzi non si coglie però il tratto predominante del modo di fare di Gigi: una trascinante simpatia. Gigi era ironico, pacato, sorridente, felice di vivere ed era sempre disponibile ad aiutare chi si trovava in difficoltà. “Chiedi come fare a Gigi” mi diceva Giovanni Evangelisti quando mi trovavo in qualche impasse accademica e Gigi risolveva il problema in modo sorridente e abile. Quando ci siamo trovati il 4 ottobre 2008 ai funerali del comune amico Giovanni io ero turbato. Gigi mi ha detto: bisogna vivere questi momenti serenamente; fra non molto, d’altra parte, lo raggiungerò. Non mi resta quindi che immaginarli, come li ho visti tante volte, insieme, questa volta su una nuvola, a parlare di libri e di politica.
1. Luigi Pedrazzi: A scuola di disastro. Perché non convince il bonus voluto dalla Moratti a favore della scuola privata
Intervista di Nello Ajello pubblicata su La Repubblica.it dell’8 settembre 2003
D. Luigi Pedrazzi, uno dei fondatori della rivista Il Mulino, autorevole esperto di scuola. Lo conosco da molti anni, e di rado l’avevo visto così infervorato. Cattolico liberale, molto vicino a suo tempo a Giuseppe Dossetti, egli non riesce a condividere alcun aspetto del recente provvedimento. Cosa pensa dei bonus dati dal ministro Moratti alle scuole private?
Sono fermamente contrario al “bonus” accordato dal ministro della Pubblica Istruzione alle famiglie che vogliono iscrivere i loro ragazzi agli istituti privati. Lo considero inutile, raffazzonato, improvvido. E’ inconciliabile con la nostra Costituzione ed è negativa la sua efficacia anche per i suoi supposti beneficiari. Quali sono i nuclei domestici che il ministro intenderebbe premiare? Coloro che se lo possono permettere già provvedono ad assicurare ai propri figli varie forme suppletive di istruzione, dal computer di casa ai viaggi all’estero, ai corsi in collegi stranieri per imparare le lingue. Trovo mostruoso che a simili famiglie abbienti venga versato un obolo del quale non hanno bisogno, e che lo stesso obolo, di eguale entità, si conceda a quelle che lamentano vere necessità di bilancio. La nostra Costituzione, semmai, contempla l’esigenza di sostenere i “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi”, consentendogli di accedere agli studi superiori. Nessun criterio di merito, nessuna indagine personalizzata sul singolo studente mi pare sia alla base del decreto Moratti.
D. Secondo il ministro uno dei princìpi ispiratori del provvedimento è la competitività fra pubblico e privato.
Parlando in generale, la scuola avrebbe bisogno di incentivi in direzione della qualità. Ma non attraverso interventi così scopertamente mercantili. E’ irreale, inoltre, supporre nelle famiglie la volontà di migliorare le istituzioni educative. L’insegnamento migliora se coloro che lo impartiscono hanno l’intenzione e la capacità collaudata di migliorarlo. Agli sforzi dei presidi e degli insegnanti lo Stato deve contribuire finanziando nella misura maggiore possibile le scuole. Non deve farlo offrendo bonus.
Tanto varrebbe, aderendo per un istante all’ottica che prevale nell’attuale governo, finanziare direttamente le scuole private… A questo, lo sai, si oppone la nostra Carta costituzionale. Gli si oppone in maniera drastica, ineludibile. La clausola “senza oneri per lo Stato” vieta di elargire contributi alle scuole non pubbliche. Un modo altrettanto perentorio per risolvere la questione ci sarebbe, dunque: cambiare la Costituzione, a patto di averne il coraggio e la forza. Ma, appunto, si preferisce inventare il bonus per aggirare la questione. Almeno qui in Italia.
D. E altrove? I difensori del decreto adducono esempi stranieri.
In alcuni Stati americani, California ed altri, il bonus è stato infatti adottato, in base all’ideologia liberista e mercantile che vi predomina. Con quali risultati? Assai deludenti. Ne è derivata una crescita dei costi complessivi dell’istruzione senza un generale miglioramento del livello educativo.
D. Per un cattolico, non è positivo il fatto che lo Stato collabori al suo sforzo di dare ai figli un’istruzione di sicura garanzia religiosa?
In primo luogo, c’è da tener presente la modestia del contributo. Due o trecentomila delle vecchie lire, in confronto con vari milioni – a tanto ammonta la retta annua di una scuola privata – è quasi nulla. Ma siamo poi sicuri che ad orientare una famiglia verso la scuola privata prevalgano motivi di carattere religioso o confessionale?.
D. E quali altri, se no?
Io penso che le spinte principali siano due. In primo luogo, la fiducia che i ragazzi vengano curati con maggior attenzione, possano vivere la loro esperienza di apprendimento in maniera più gradevole, senza quelle disfunzioni (ritardi, lentezze, supplenze protratte, agitazioni e così via) che sono pressoché fisiologiche negli organismi pubblici. C’è poi un altro movente, spesso decisivo: la convinzione che il ragazzo potrà concludere gli studi con maggiore facilità, anche se gli manca un’adeguata preparazione. Ci terrei comunque a chiarire che fra le scuole “facili” di rado figurano quelle religiose, le quali presentano in molti casi un’eccellente tradizione di qualità.
D. Le chiedo allora da quali pulsioni misteriose nasca questo disastro chiamato “bonus”?
Per me il 2desiderio di bonus” è un conglomerato di varie volontà e velleità. L’intenzione di mostrarsi moderni vi si intreccia con il proposito di esibire attenzione al mondo cattolico. Dando per scontato che esso non sia in grado di fare i conti. La Chiesa, invece, sa benissimo che per esempio nei paesi dell’Europa del Nord – in Svezia come in Danimarca – i contributi agli istituti non statali sono ben altrimenti cospicui: arrivano a volte a coprire il 70 o l’80 di ciò che allo Stato costa ciascun alunno. Ma sono sovvenzioni, ripeto, erogate alle scuole, non alle famiglie. E possono venire cancellate se gli istituti beneficiari, che sono in genere pochi, vengono meno ad un patto di qualità ed efficienza convenuto con lo Stato. La sovvenzione, insomma, è subordinata a un attento esame di chi ne gode. Spesso si tratta di istituti creati dalle minoranze etnico-culturali, nell’ambito di un’accoglienza responsabile degli stranieri immigrati. Ecco cosa significa saper spendere bene i soldi pubblici. Altrimenti è tutta una finzione.
D. Ma qual è, da noi, l’incidenza degli istituti privati sul totale della scuola?
Esigua. Le “private” accolgono il cinque o sei per cento della popolazione delle scuole secondarie. Nell’immediato dopoguerra la percentuale oscillava fra il 15 e il 22. Gli istituti non statali sono diminuiti perché l’apertura di scuole pubbliche dovunque, in provincia, ha prosciugato il flusso di studenti fra i piccoli centri e i capoluoghi nei quali l’organizzazione ecclesiastica disponeva di efficaci strutture di accoglienza (convitti, e simili). Lo Stato, intendiamoci, ha fatto benissimo ad aprire tante scuole.
D. Mi nasce un pensiero. Non è paradossale che la diffusione capillare della scuola pubblica e la riduzione di quella privata siano avvenute proprio durante i decenni di egemonia della Democrazia Cristiana?
Il paradosso è solo apparente. E’ vero che l’inserimento nella nostra Costituzione della clausola “senza onere per lo Stato” – che passò su proposta del liberale Epicarmo Corbino – segnò per la Chiesa la chiusura di una strada ad essa favorevole. Ma, a fronte di questo, la Democrazia Cristiana preferì gestire la scuola statale, trovando così una sorta di compenso: noi diamo soddisfazione al vostro principio laico di non finanziare l’istruzione confessionale, ma a nostra volta ci riserviamo – legittimamente, in quanto maggioranza – la facoltà di governare tutta la scuola. Non a caso, per quarant’anni, i ministri della Pubblica Istruzione sono stati tutti democristiani.
D. Scuola e religione. L’equiparazione degli insegnanti di questa materia ai loro colleghi delle diverse discipline, cioè il loro ingresso nei ranghi ordinari della scuola, è un provvedimento che fa discutere. Cosa ne pensa ?
Lo considero un vero pasticcio. Vi vedo un cedimento gravissimo da parte dello Stato. Anche qui occorre chiarezza. Se si stabilisce che gli insegnanti di religione devono essere graditi all’autorità ecclesiastica, ciò li rende diversi dagli altri: gli riconosce uno status giuridico del tutto particolare. Farne dei dipendenti statali è un accomodamento demagogico, dannoso sia allo Stato che alla Chiesa. Segna una vittoria degli insegnanti di religione non nella loro funzione, ma in quanto personale sindacalizzato. Il che priva l’autorità ecclesiastica di quel legame di garanzia cui essa aspira in virtù del Concordato.
D. Quale danno – materiale, ideale – può derivare alla Chiesa nell’avere dei “suoi” rappresentanti all’interno del corpo docente?
Ti faccio un esempio. Fino a qualche tempo fa, un ufficio diocesiano non dava il via alla nomina di un insegnante di religione che fosse un divorziato. Adesso, se questo insegnante divorzia dopo la nomina, trovandosi regolarmente in servizio è tutelato al pari di qualunque altro cittadino. Nessuno può rimuoverlo dal suo posto: neppure quella autorità che ha dato il “nulla osta” alla sua nomina. Con questa “equiparazione” sono giunte al culmine quelle incongruenze religiose-civili di cui è la massima espressione l’istituzione dell’ora di religione.
D. Cosa pensa dell’ora di religione il cattolico Pedrazzi?
Sono contrario. La considero un pasticcio consensuale. Mi consta che un grande costituzionalista e grande cristiano come Giuseppe Dossetti era contrario all’ora di religione. La giudicava inutile alla formazione culturale e religiosa dei giovani.
Intervista di Paola Furlan, Bologna, Sala del Consiglio comunale di Bologna, 15 giugno 2006
D. Andiamo alle origini della sua decisione di entrare nel 1956 nella competizione elettorale e di entrate in Consiglio comunale. Quali sono state le motivazioni con cui ha cominciato a partecipare ai lavori?
All’inizio di tutta la storia c’è la visita che Giuseppe Dossetti fece alla redazione de “il Mulino”, qualche mese prima delle elezioni del 1956. Abbiamo sentito suonare alla porta mentre c’era in corso una delle solite riunioni; lui si presenta e dice: “Sono Dossetti e credo che riceverò l’incarico di capeggiare la lista della Democrazia cristiana. Cerco qualcuno nell’ambiente del Mulino che voglia venire a discutere con me di tante cose!”. Ne abbiamo parlato tra noi in due o tre riunioni per sette, otto ore. Eravamo molto sgarbati e lo prendevamo in giro come persona troppo vicina alla Democrazia cristiana e al mondo clericale, mentre noi ci atteggiavamo a laici un po’ aggressivi. Anche quelli di noi che erano cattolici non erano mai stati democristiani e ci piaceva molto che venisse a cercare tra noi degli indipendenti di sinistra per la lista dei democratici cristiani. Comunque ne abbiamo discusso a lungo. Rimasi fin da subito molto ammirato nei suoi riguardi ed anche abbastanza colpito.
Alla fine la redazione, perché allora anche noi avevamo una specie di linea-partito della rivista, decise che uno di noi entrasse in lista con Dossetti. In quell’occasione gli abbiamo chiesto: “Ma chi prenderesti?”. Dossetti rispose: “Sceglierei Pedrazzi!”.
Allora avevo solo 29 anni e durante queste riunioni ero stato piuttosto zitto ed un po’ in soggezione, perché Dossetti mi aveva colpito molto. Tutto è cominciato così.
Devo dire che in seguito Dossetti mi chiarì molte cose in un colloquio riservato a tu per tu. Mi disse che avremmo perso, che era impossibile che la sua lista vincesse le elezioni e che proprio la notevole campagna elettorale che si sarebbe svolta avrebbe sicuramente mobilitato di più i comunisti perché avevano molti iscritti al partito, mentre la Democrazia cristiana ne aveva pochi. Aggiunse anche che i comunisti erano in grado di svolgere un forte lavoro in città e che il suo partito l’avrebbe lasciato abbastanza solo. Mi disse però che anche se si profilava una sconfitta, lui avrebbe fatto comunque una bella campagna, perché gli avevano chiesto di presentarsi e di dire ciò che voleva. Così era libero di dire tutto quello che gli sembrava giusto per la città, pur sapendo che queste idee sarebbero state portate avanti solo da una minoranza. Devo ammettere che questa confidenza un po’ segreta mi affascinò, anche se durante i comizi non potevamo certo dire che avremmo perso. Intanto facevamo le nostre proposte, sperando di ottenere molto consenso, ma un vero e proprio consenso sulle proposte non ci fu. Quelle proposte riscossero molto rispetto ed attenzione da parte della maggioranza comunista che si accorse infatti che Dossetti, leader di quella campagna elettorale, era uno sfidante di qualità. In questo eravamo molto lontani dal clima di adesso, che vede maggioranza e minoranza delegittimarsi a vicenda – non dico a Bologna, ma in tutta Italia- e quindi allora le motivazioni di carattere politico-ideale furono molto forti.
Devo aggiungere poi che noi del Mulino eravamo famosi per non occuparci molto delle cose amministrative della città. Si sapeva che a Bologna l’amministrazione era comunista e che lo sarebbe stata a lungo, quindi ci occupavamo molto di più di tradurre libri americani ed europei, in una visione ed in un’ottica abbastanza internazionalista. A dire il vero, fino ad allora mi ero occupato più dell’Onu che non del Comune di Bologna. Proprio per questo mi piaceva la dimensione della campagna di Dossetti, così ideale e non ideologica, che non cadeva assolutamente nella trappola di prendere troppo sul serio i comunisti o i democristiani e, pur considerandoli delle forze storiche importanti, li riteneva però incapaci di far fruttare fino in fondo tutto il peso della loro storia. Un’altra cosa che mi piaceva era questa visione abbastanza relativizzante del conflitto politico, entrai quindi perfettamente soddisfatto nelle mie esigenze anche se questa linea era sicuramente piuttosto anomala rispetto a quella di chi deve fare il consigliere comunale.
D. Lei è stato in Consiglio comunale dal 1956 al 1964. Può parlarci della Bologna degli anni Cinquanta e di cosa succedeva allora in città.
Partiamo dal secondo punto. Angelo Salizzoni ed anche il cardinale Giacomo Lercaro, appoggiarono la proposta che Dossetti, tra l’altro già legato al cardinale da una vocazione di tipo monastico anche se laica, capeggiasse la lista democristiana. Dossetti obbedì a questa indicazione e dopo aver chiarito a tutti e due che non avrebbero vinto, gli fu risposto: “Basta che ti presenti, dì solo quello che vedi!”. Fu proprio questa libertà che convinse Dossetti a fare questa singolare esperienza di minoranza programmatica, ma proprio nello spirito della sua interpretazione del quadro internazionale. La guerra fredda era la cosa che Dossetti detestava di più, perché avrebbe voluto che nel dopoguerra, sia in Italia che nel mondo, continuasse in qualche misura la collaborazione antifascista e antinazista. C’erano tante cose da fare: la decolonizzazione in Africa e in Asia per la quale sarebbe stata opportuna una grande alleanza democratica per un’evoluzione ed un vero cambiamento. La cosa fallì completamente e non si poté farla! Nel 1947 cominciò la guerra fredda e proprio per questo Dossetti ritenne che a quel punto non ci fossero più le condizioni per continuare quell’impegno riformatore nel paese e nel mondo. Preferì lasciar perdere e seguire la via monastica. Comunque, mentre era attesa di poterla percorrere, mi venne richiesto di svolgere questo compito a Bologna.
Dossetti s’impegnò a fondo perché era fortemente convinto che l’assurda richiesta di vincere il confronto amministrativo creava in realtà le condizioni di un forte e libero confronto ideale. Non c’era bisogno di litigare e quindi, anche di fronte all’invenzione dei quartieri, per cui quella campagna elettorale è passata alla storia, bisognava dire: “Qui ci sono dei comunisti e dei cattolici!”. Certamente c’erano anche i liberali, i socialdemocratici, insomma tutte le forze laiche della tradizione italiana e bolognese in particolare, nel consiglio comunale il confronto era quindi ideologico. La nostra idea era quella di creare un’altra istituzione, più vicina alla gente e più legata ai bisogni della vita quotidiana, con una partecipazione non necessariamente dei partiti o degli iscritti, sia pur presenti, ma che coinvolgesse anche i professionisti, le maestre, ecc. C’era quindi l’invito a discutere nei quartieri, anticipando quel bisogno di decentramento e di partecipazione che è stato molto più forte negli anni successivi.
Sia Dossetti che Achille Ardigò, suo principale collaboratore, condividevano questa visione dei quartieri insieme all’idea di migliorare il livello dell’amministrazione e dell’informazione dei cittadini. C’era soprattutto la speranza che si potesse fare un po’ dappertutto quello che era giusto fare; si sperava che chi era espressione di una forza popolare come i comunisti e di una tradizione solidaristica attenta ai poveri e agli umili come quella cristiana, avrebbero trovato un terreno d’incontro e di conoscenza dei problemi comuni per operare insieme. Per fare questo era necessario sfuggire agli ideologismi ed alle logiche che muovevano invece le forze politiche nazionali e dei rispettivi organismi molto politicizzati, come il consiglio comunale. Bisognava invece costruire una dimensione in cui le persone potessero parlarsi con più sincerità. Non so se nei quartieri si sia mai parlato apertamente e sinceramente, ma certo un po’ di più che altrove. La sfida era comunque indirizzata ad una posizione di pace, dove anche le forze che si credevano opposte potevano collaborare e magari fare insieme delle scoperte. Diceva infatti Dossetti: “State attenti che i rumori di catene si sentono in casa di tutti, in Russia ci sono catene, in Occidente ci sono catene; se abbiamo la consapevolezza di questo, saremo più umili e più disposti ad interessarci ai problemi comuni!”. Devo dire che questo piacque ad alcuni cristiani e anche ad alcuni comunisti, non a tutti, ma ad alcuni piacque molto e questo li fece camminare insieme.
In tal senso, la campagna del 1956 determinò un’evoluzione maggiore all’interno dei comunisti bolognesi verso il riformismo e verso l’eurocomunismo, che non una maturazione della Democrazia cristiana. Il gruppo dossettiano si formò tra il 1956 e il 1960, ma poi non l’ho più seguito. Sono stato un dossettiano e quando lui si è fatto monaco ed è entrato a far parte del Concilio l’ho seguito nel suo percorso. Non mi sono fatto monaco, ma ho partecipato con attenzione ai lavori del consiglio. In quel periodo i consiglieri comunali, Angela Sbaiz, Fernando Felicori, Achille Ardigò e Giovan Battista Cavallaro hanno arrecato un contributo amministrativo notevolissimo. A mio parere, quelli sono stati gli anni migliori dell’amministrazione della città, diciamolo pure socialdemocratica in senso comunista-riformista.
D. Lei ha parlato di qualità dell’amministrazione. Come lo spiega questo fenomeno del buon governo?
Il fenomeno del buon governo ha origini lontane. Grazie a questa comune volontà di intenti per il bene della città durante quel periodo si sono fatte cose importantissime: la Fiera, la Finanziaria, i piani collinari, il piano del centro storico. Molte delle grandi scelte di allora sono state scelte bipartisan, comunque sempre partendo da un gruppo rimasto minoritario, perché il quadro nazionale escludeva che la Democrazia cristiana bolognese andasse in giunta. In realtà la collaborazione è stata molto forte. Il Partito comunista ha assorbito molte delle idee, delle istanze e delle competenze. Ad esempio, anche nel caso della Fiera, le collaborazioni sono state fatte tra le persone, quindi sotto questo aspetto Bologna è stata fortemente aiutata.
Credo davvero che quelli siano stati gli anni più gloriosi dell’amministrazione, anche grazie al fatto che c’erano molti soldi a disposizione, perché eravamo in piena fase di sviluppo espansivo di tutta l’economia italiana. Erano gli anni del boom: le tasse fruttavano parte delle entrate per lo sviluppo urbano, la città aveva delle fonti fiscali; i trasferimenti erano molto generosi perché c’erano i soldi e lo stato li dava a chi faceva delle proposte a livello locale. Il Comune di Bologna proponeva molto ed otteneva molti finanziamenti. Allora, con tante risorse, è stato quindi facile e bello amministrare.
D. Secondo lei, fino a quando è durata questa particolare fortuna di Bologna?
L’anno che segna, a mio parere, la fine di questo clima un po’ mitico e magico della città, è il 1977. Il 1977 è un vero e proprio anno di svolta: la città modello, vetrina d’Italia, dove il gruppo democristiano, più cattolico-dossettiano che democristiano-doroteo, e i comunisti riformisti avevano saputo collaborare, ora mostrava delle crepe. Il 1977 svela che anche la lunga stagione di riforme, di sviluppo sociale ed economico ad un certo punto si esaurisce: diminuiscono le risorse finanziarie, si passa quindi attraverso una serie di crisi economiche più o meno gravi ed il comune comincia a fare più fatica. L’università è comunque la molla che fa esplodere il dissenso. Non sono solo i problemi sociali della città, ma tutti i problemi non risolti del 1968 a produrre con sette o otto anni di ritardo, il fenomeno del ’77 bolognese.
D. Quale fu l’influenza di Giuseppe Dossetti nel contesto politico bolognese e quali furono le reazioni al Concilio Vaticano Secondo?
Questo vale naturalmente per i bolognesi attenti a queste cose, quindi in particolare per Giuseppe Dozza, Guido Fanti, ed anche un po’ per Renato Zangheri. Devo dire che nell’ambito del Partito comunista, i due grandi protagonisti sono stati Dozza e Fanti.
Dossetti li aveva impressionati fortemente come consigliere comunale, ma in seguito si dimise dall’incarico; chiese inopinatamente di fare il sacerdote e lo diventò dopo nove mesi di esami furibondi in seminario. A chi lo conosceva, sembrò un voler scomparire all’interno del clero normale e secolare della città, ma il suo diventare sacerdote coincise con la morte di Papa Pacelli e l’elezione di Papa Roncalli. Pochi giorni dopo aver celebrato la sua prima messa, Roncalli a Roma lanciò quest’idea “Ci sarà il Concilio, io convoco un Concilio ecumenico”. Va detto che Dossetti era una delle poche persone che da dieci anni auspicava un Concilio e che aveva studiato e fatto studiare cosa dire a Roma, quindi era preparatissimo, come a suo tempo era stato un ottimo membro dell’assemblea costituente, così anche al Concilio la sua esperienza fu molto influente e significativa. Era molto bravo, ma Papa Giovanni XXIII mise il Cardinale Lercaro come moderatore del Concilio insieme ad altri tre eminenti cardinali europei. Dossetti era il segretario di Lercaro e questo influì moltissimo sulle scelte, per così dire, procedurali del Concilio stesso. In modo particolare ebbe grande influenza la sua capacità organizzativa durante la prima e contrastata sessione dei lavori.
Questa è una cosa che la storia del Concilio ha messo bene in chiaro e cioè che il ruolo di Dossetti fu determinante, così come lo era stato durante i lavori dell’assemblea costituente. I suoi interlocutori di allora erano soprattutto Palmiro Togliatti, Lelio Basso, Piero Calamandrei, mentre in Concilio erano i cardinali a tenere un ruolo di primo piano. Agli occhi dei comunisti, questo fece ingigantire di conseguenza anche la figura del Cardinal Lercaro, infatti il vescovo di Bologna, che aveva parlato della Chiesa dei poveri, della pace, temi cari al cuore di tutti i bolognesi ed anche della sinistra, venne accolto dal Gonfalone, come vescovo della città, non solo della Chiesa di Bologna.
Lercaro ne fu molto colpito e da quel momento si sentì quasi più di casa tra la popolazione di Bologna, che non all’interno di quella parte della Chiesa, anche bolognese, in agitazione per il timore che il Concilio avesse messo in movimento troppe cose. In chiesa si percepiva quindi un entusiasmo frenato nei riguardi del Concilio. Questo è un problema, non solo locale, che ha portato Lercaro a fare il suo famoso discorso in consiglio comunale e che insieme ad altri fattori ha contribuito alla sua rimozione dalla sede di Bologna e quindi a bloccare questo processo. E’ stata comunque un’altra occasione in cui il dialogo tra cattolici e comunisti ha avuto grande importanza, anche se non tutta la Chiesa italiana e non tutto il comunismo italiano si è riconosciuto in quest’esperienza. Questo ha quindi rappresentato per Bologna una gloria ed insieme una sconfitta.
D. Come ha reagito Bologna alla guerra del Vietnam?
Permettimi di dire che questa guerra ebbe una ricaduta internazionale. Quando scoppiò, ci rendemmo conto che non c’erano soltanto i problemi come li vivevamo noi italiani, c’era la consapevolezza che gli americani stavano bombardando noi e il Vietnam! La preoccupazione per la pace era grande, sia nella sinistra comunista, sia tra tutti i giovani americani che chiedevano in massa la fine dei bombardamenti ed il ritiro dal Vietnam. Tutta la gioventù italiana di sinistra non voleva quella guerra e quello che fermentava qui a Bologna ebbe un significato ed un’eco molto vasta. Questa fu una delle cose che contribuì a dare alla nostra città un profilo ed un carattere di eccezionalità. Allora Bologna venne vista, all’Italia e all’estero, come una città in grado di anticipare – magari rimanendo in seguito travolta dalla sua stessa originalità – dei movimenti che sarebbero poi venuti avanti. Invece questo non è accaduto ed ha provocato in seguito dei “ritorni”, che hanno bloccato e appesantito la vita della città. Gli ultimi vent’anni del Novecento portano il segno di queste sconfitte, per cui anche se il Concilio Vaticano Secondo è stato un grande evento del Ventesimo secolo, a livello mondiale non ha dato i risultati che si potevano sperare. Certamente all’interno del movimento cattolico di tutto il mondo ha comunque rappresentato uno vero spartiacque.
D. Cosa ricorda della nascita dei quartieri a Bologna e dell’esperienza di aggiunto del sindaco nel quartiere Mazzini?
Dopo una lunga fase giuridica d’impostazione, finalmente i quartieri furono in grado di funzionare non con l’elezione dei consiglieri e dei presidenti, ma secondo una riproduzione degli equilibri esistenti all’interno del consiglio comunale, quindi si trattava di una forma di elezione di secondo grado. I presidenti dei quartieri venivano infatti designati dal sindaco come suoi aggiunti. Durante una certa fase di questa esperienza, non la primissima, la Democrazia cristiana accettò di proporre i nominativi di alcuni bolognesi che potessero presiedere i quartieri pur essendo in minoranza.
Quando mi chiesero di occuparmi del quartiere Mazzini non potei rifiutare in qualità di vecchio partecipante dell’esperienza amministrativa del 1956 e 1960. Allora il quartiere Mazzini era in fortissima espansione: non c’erano tutte le case che ci sono adesso, il Fossolo non c’era ancora e neanche tutti gli stradoni che ora lo collegano a San Lazzaro, ma era un bellissimo quartiere in crescita! Mi ricordo molte riunioni di progettazione con l’assessore di allora, Giuseppe Campos Venuti, che veniva a spiegarci i piani regolatori. È stata un’esperienza molto interessante. Non avevo una maggioranza, perché ero sindaco di minoranza, ma questo non voleva dire niente, perché lì veramente la collaborazione tra di noi era fortissima. In particolare andavo d’accordissimo con il capogruppo comunista, un funzionario dell’azienda del gas che incontravo quando andavo a pagare le bollette. Allora c’erano grandi dibattiti, anche fino alle due di notte! L’esperienza per me più significativa fu quando non avevamo soldi, non avevamo risorse da amministrare e quindi non potevamo fare delle proposte. In quel momento non sapevamo come rispondere alla pressione delle mamme che, come in altri quartieri, ci chiedevano di risolvere il problema dei trasporti per i loro bambini. Infatti non c’erano autobus che arrivassero nelle poche scuole che si stavano aprendo allora, un po’ disagiate. L’azienda del tram aveva però l’abitudine di affittare autobus alle persone che volevano andare a ballare nei dintorni e allora, appellandomi a questa possibilità, ne affittai uno per i giorni della settimana per raccogliere i bambini e portarli fino a scuola. Il problema però era come pagare l’autobus, quindi bisognava che le mamme accettassero di pagare il biglietto. Anche se non avevamo nessun diritto di fare questo, le mamme lo vennero a pagare in quartiere e se c’era qualcuna che non lo pagava, me lo venivano a dire.
Mi dicevano: “Il bambino è salito, ma la mamma non aveva il bigliettino, il tagliando, il tesserino!”, senza però dirmi il nome. Insomma, ce n’era qualcuno che non pagava, ma non tanti. Alla fine dovetti andare io a fare il controllore sull’autobus. Chiedevo al bambino: “Ma dove hai la tesserina? Come mai? Oggi passa, ma domani dì alla mamma…!”. Insomma questa cosa mi rese popolarissimo. Venne addirittura un comitato di madri per dirmi: “Non so se lei si vorrà mai candidare, ma se lo farà, avrà il nostro voto anche se fosse nella lista che non voteremo, perché non credevamo davvero che sarebbe venuto alle 7 del mattino a farsi il giro!”. E invece devo proprio dire che per me fu un’esperienza molto bella e mi convinse del fatto che amministrare non è solo un compito gravoso! Avevo sempre sostenuto la diffusione, per così dire, delle “alte idealità”, però devo ammettere che nello sforzo amministrativo c’è un elemento di grande concretezza, sia pur riduttiva. Questa fu una cosa memorabile e ancora adesso qualche volta rivedo quelle mamme, molto invecchiate e ormai nonne, che si ricordano di aver visto il sindaco fare l’ispettore dell’autobus per i loro bambini!
D. Nel 1946 per la prima volta in Italia votano e vengono elette le donne. Quale fu la loro attività ed il loro contributo all’interno dell’amministrazione?
L’ingresso delle donne fu una cosa molto bella, anche se noi non ce ne accorgemmo, precedette il movimento femminista, che poi abbiamo conosciuto 20 anni dopo, ma la consapevolezza ideologica di questo non era stata molto larga e diffusa, nemmeno tra le donne stesse. La qualità della presenza femminile si avvertiva, in modo particolare nella maestra Anna Serra del gruppo democristiano, veramente straordinaria e molto materna, come lo sono le maestre donne: seria, severa, ma un vero tesoro, capace di grande concretezza e di lavoro continuativo! In questo mi ricordava un’altra donna un po’ dura, Adriana Lodi, che invece era dell’altro gruppo, una donna di straordinarie capacità nell’affrontare i problemi. Certo, anche tra gli uomini ce n’erano di serissimi, ma la continuità e la qualità dell’impegno della maestra Anna Serra e di Adriana Lodi mi colpì.
Sarà che avevo avuto il bellissimo esempio di una nonna operaia, che aveva fatto la fortuna della nostra casa lavorando venti ore al giorno nel forno di famiglia, la ditta Stella Pedrazzi, diventata poi famosa nella fabbricazione del pane e dei tortellini. Mia nonna li spediva in tutta Europa per posta aerea. Negli anni Trenta noi Pedrazzi eravamo fornitori quando gli aerei erano dei veri baracconi volanti, ma non so come la nonna riusciva a mandare per posta aerea in Svezia e in Danimarca, i tortellini freschi non quelli secchi di adesso. Capivo già allora che c’è qualcosa nella donna che lavora e s’impegna nella società, che ci vorrebbero quattro o cinque uomini per fare quello che fa una donna di quello stampo.
E mi pareva che la maestra Serra ed Adriana Lodi, pur su sponde opposte, attingessero allo stesso patrimonio di femminilità operosa, che avevo conosciuto anche nelle campagne durante lo sfollamento nel nostro Appennino. Insomma, penso che molti abbiamo trascurato o sottovalutato l’apporto delle donne alla vita politica e trovo quindi vergognoso che si debba ricorrere oggi alle quote rosa, solo perché il filtro maschile che le tiene fuori da certi ambiti continua ad essere operante! Mi fa veramente piacere sottolineare questi dati e che per la prima volta nel secondo dopoguerra le donne abbiano votato.
D. Sempre parlando del contributo delle donne, cosa ci può raccontare di Angela Sbaiz?
Giuseppe Dossetti, oltre che venire al Mulino, andò anche nello studio Redenti e Carnacini perché voleva avere con sé dei maestri del diritto bolognese, ma sia per l’età che per impegni professionali, questi due luminari del diritto proposero una loro assistente molto in gamba, una collaboratrice donna dello studio. Angela Sbaiz era allora molto più giovane di quello che poi è stata nei venti e passa anni di vita in consiglio comunale. È stata eletta in quattro o cinque mandati ed ha contribuito moltissimo alla strutturazione dei quartieri, alla stesura di molte delibere anche di carattere amministrativo. Direi che è stata una specie di assessore esterno in alcune giunte. Era di casa, aveva una grande autorevolezza ed i suoi pareri erano d’oro!
Friulana di origine, era anche lei una donna asciutta e dura, innamorata delle idee di Dossetti e quindi anche più ingenua di me. Ha continuato a lavorare in consiglio comunale anche quando ormai le indicazioni del lavoro ideale di Dossetti si erano modellate sul concilio. Pur ammirandolo, era rimasta tuttavia collegata a questa scoperta della città, a questa dimensione, che direi fosse condivisa da Guido Fanti, il sindaco, poi presidente della Regione. Anche a lui piacque moltissimo lo spirito di quella stagione e credo che il decennio dell’esperienza di collaborazione con i cattolici sia stata complessivamente la cosa più bella della sua vita. In seguito l’ha portato anche ad una sconfitta, perché in realtà si trattava di un Ulivo anticipato di quindici, vent’anni.
Negli anni successivi lo stesso Partito comunista ha seguito unalinea che non ha consentito l’esplosione del riformismo emiliano a livello nazionale. È stato controllato, anche perché i tempi erano duri, sull’uno e sull’altro fronte.
D. Lei è stato vicesindaco dal 1990 al 1995 con il sindaco Walter Vitali, cosa l’ha spinta a questa nuova esperienza e con quali risultati, quali tracce?
Walter Vitali mi conosceva bene, avevamo una certa simpatia, ma l’elemento fondamentale era che ormai tutti i dossettiani erano morti, non c’erano più. Gli unici sopravvissuti eravamo io e Achille Ardigò, che lavorava già all’Ospedale Rizzoli e ricopriva un incarico importante. Senza togliere nulla all’affetto per la scelta fatta da Vitali, devo però dire che in pratica le parole furono: “Non più uno sconto”. Ma insistette, e mi sembrò che, come ero andato al quartiere Mazzini a pagare il mio obolo di fedeltà ispirato ad un progetto, ecco che anche in quel momento mi pareva opportuno accettare. A questo punto, avevo più di 60 anni. Rispetto alla prima esperienza erano passati 40 anni, dal 1956 al 1995, mi parve quindi opportuno accettare questo mandato come conclusione, ma chiesi di non avere nessuna delega.
Ancora una volta non volli fare l’assessore, né avere responsabilità. Mi toccò di sorbirmi molte riunioni del consiglio comunale, perché a questo punto Vitali per farmi star lì mi fece fare le mansioni di vicesindaco. L’aver sentito il 90 per cento delle cose che si sono dette in consiglio comunale tra il 1995 e il 2000 è stata un’esperienza importantissima perché ho capito fino in fondo il grande declino delle istituzioni politiche nel nostro paese rispetto ai quarant’anni precedenti. Ora, personaggi come Umbro Lorenzini, Athos Bellettini, Armando Sarti, indipendenti come Oliviero Mauro Olivo e Giovanni Favilli, non li ho più sentiti, neanche tra i popolari. Non c’erano più i democristiani, non era più la stessa cosa di allora: il tipo di dibattito, i nostri consigli comunali affollati, la poca gente che allora usciva per andare alla buvette. Dal 1995 al 1999 non c’erano mai più di cinque o sei persone in consiglio, erano tutti a chiacchierare alla buvette ed ognuno parlava per sé, non c’era l’ascolto collettivo in sala. Ai nostri tempi invece, si cambiavano le opinioni a seconda di quello che dicevano i consiglieri e si spostavano i voti. Dopo mi sembra che non sia stato più così, c’è stato un calo di partecipazione che non si vedeva solo all’esterno, ma quasi più dentro che fuori. È stata un’esperienza formativa interessante, anche se deludente, ma credo che anche le delusioni facciano parte della formazione seria che bisogna vivere!
3. Luigi Pedrazzi: Il Mulino da sessanta anni fabbrica della cultura
Intervista di Simonetta Fiori del 1 aprile 2014 pubblicata su “La repubblica”
D. Le grandi crisi sono state risolte sempre a tavola.
Category: Editoriali, Politica