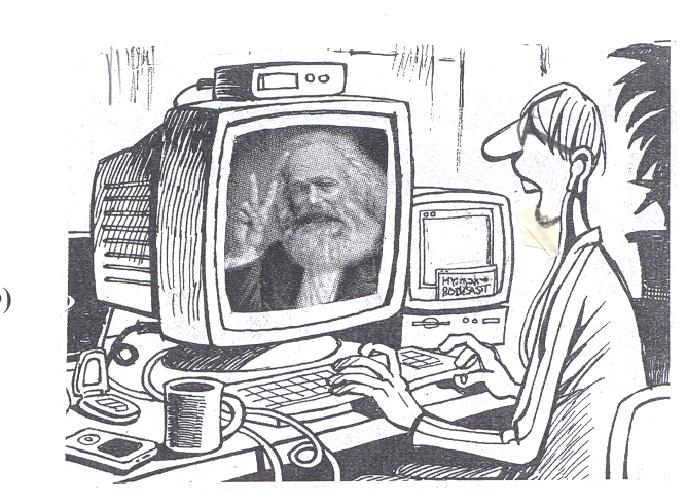Fabrizio Battistelli, Enzo Campelli, Angelina Lopez: Sociologia e marxismo in Italia
Sul libro di Angelina Lopez, Sociologia e marxismo. Un dibattito degli anni Cinquanta, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2013 è stato organizzato un dibattito con Fabrizio Battistelli e Enzo Campelli. La trascrizione è stata rivista dagli autori
Angelina Lopez : Introduzione al dibattito
Molto brevemente e con vero piacere presento i due relatori: Fabrizio Battistelli – cito in ordine alfabetico – professore ordinario di Sociologia presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, ed Enzo Campelli professore ordinario di Metodologia presso la medesima Università “La Sapienza” di Roma.
Ad entrambi rivolgo i miei più sinceri ringraziamenti per avere accettato di condividere questo momento, per me, di grande soddisfazione, in quanto è anch’esso parte del completamento di un intenso lavoro di ricerca al quale mi sono dedicata a lungo con accuratezza e passione, anche quando si è trattato di dovere affrontare i non pochi ostacoli che il riuscire a portarlo a termine ha comportato. Entrambi sono stati miei docenti all’epoca in cui frequentavo assiduamente – partecipando anche alla realizzazione di alcune ricerche – molti dei Corsi e dei relativi Seminari che, tanti anni fa, si svolgevano nell’ambito dell’allora Facoltà di Sociologia della citata Università. Corsi dei quali, salvo qualche eccezione, ho ancora oggi un indelebile buon ricordo, e ciò vale in particolare anche per quelli di cui erano all’epoca autorevoli titolari il prof. Battistelli (Corso di Sociologia dell’organizzazione) e il prof. Campelli (Corso di Metodologia delle scienze sociali) ai quali non a caso ho chiesto di presentare questo mio libro: Sociologia e marxismo. Un dibattito degli anni Cinquanta.
Fabrizio Battistelli
Il bel volume di Angelina Lopez è un po’ un viaggio nel tempo e in direzione di tematiche che non potrei definire, in questo momento, al centro del dibattito del nostro Paese. Anche il carattere un po’ da adepti di questo nostro incontro lo testimonia, il che non esclude l’occasione di una riflessione condivisa, dotata di una sua utilità.
Intanto i nodi teorici sciolti e riannodati da Sociologia e marxismo non sono affatto datati. Essi hanno, indubbiamente, una collocazione storica ben precisa ma, a mio parere, richiamano strutture di situazioni e di pensiero destinate a riproporsi nell’esperienza e nella cultura del nostro Paese. In esse si riflette l’ennesima occasione di confronto fra due prospettive presenti nella cultura italiana – non soltanto al livello delle élite intellettuali bensì, in maniera latente, presenti anche nell’opinione pubblica in generale, quasi due anime in competizione tra loro. Una più pragmatica, portata ad affrontare le questioni sia quotidiane sia politiche e civili con un realismo che talvolta può anche sfiorare lo scetticismo. L’altra, invece, è quella che Norberto Bobbio ha chiamato l’«ideologia italiana», cioè le propaggini onnipresenti dell’idealismo in tutte le sue variazioni. Nel nostro caso non si tratta dell’originario idealismo di Hegel – o non soltanto – bensì dell’idealismo reinterpretato da quella tradizione nazionale alla quale lo stesso Partito Comunista, gli stessi marxisti ortodossi nell’Italia degli anni Cinquanta, rivendicavano orgogliosamente l’appartenenza. Cioè, quel continuum che si dipana lungo la sequenza Spaventa-De Sanctis-Labriola fino a Gramsci ma – e qui c’è un problema che meriterebbe di essere approfondito – attraverso Benedetto Croce.
Non intendo mettere in discussione la valenza di testimonianza civile e di indipendenza politica che coraggiosamente Croce fornì in epoche assai impervie, nelle quali era necessaria, appunto, una buona dose di coraggio, ma certamente la specifica influenza del pensiero di Croce non si è manifestata solo nel suo essere un liberale antifascista ma, anche e soprattutto, nell’essere il rappresentante più autorevole dell’idealismo da sempre maggioritario nel nostro Paese. Un Paese con determinate caratteristiche, non potendo noi dimenticare l’assenza della riforma protestante, non potendo sottovalutare il decorso intrapreso dalla Chiesa cattolica nel XVI-XVII secolo di fronte a quell’evento, quindi tutto ciò che ha rappresentato la Controriforma: un contesto nel quale le “idee” hanno sempre fatto aggio sui fatti. Si tratta di una spinta che arriva agli anni Cinquanta e che interessa anche l’area culturale marxista, essa stessa in bilico sulla dicotomia tra essere e dover essere o anche, talvolta, tra conoscenza galileiana e filosofia scolastica.
Di quale dicotomia (ma anche di quale sintesi) parla il libro della Lopez? Di quella, più aggiornata (negli anni Cinquanta del secolo scorso) e scandalosa, che caratterizza il rapporto marxismo e sociologia. Da quest’ultimo lato una prospettiva grosso modo induttiva, anche se orientata da concetti e non ignara di cornici teoriche; dall’altro l’idealismo “italiano” dominante nella sinistra, costituito da un’interpretazione cristallizzata e scolastica del marxismo, non a causa ma nonostante la lezione di Antonio Gramsci.
Gramsci è un unicum nel pensiero italiano proprio perché, fortemente incardinato nella tradizione storicistica e a dispetto della forte influenza del Crocianesimo, se ne distacca tuttavia per un elemento direi quasi psicologico, oltre che ovviamente politico, che non consiste soltanto nell’alternativa di classe della tradizione rivoluzionaria, ma anche di un’incomprimibile necessità analitica. Curioso di tutto, Gramsci era affascinato dai fenomeni storicamente e concretamente determinati; non soltanto di quelli di portata macro ma anche di quelli di portata meso e micro, tradizionalmente trascurati tanto dal Diamat quanto dalle sintesi supreme dello Spirito. In particolare, recepiva e percepiva con grandissima sensibilità, spesso anticipatrice, le complessità della società italiana. Ed è proprio riflettendo su questa variante della società europea che egli matura la sua visione della “rivoluzione in Occidente”, cioè una visione politica radicale e tuttavia alternativa, che tale è stata non soltanto nei confronti dello stalinismo ma anche, per molti versi, dello stesso leninismo, della pur ammirata e rispettata di quella che nella Torino del 1917 ebbe il coraggio di definire la “rivoluzione contro Il Capitale”. Un Occidente differente da quell’ “Oriente” (la Russia), nel quale il corpo della società civile era esile, lo Stato ne rappresentava la testa ipertrofica, l’atto rivoluzionario dei bolscevichi lo recise di un colpo, consegnando nelle loro mani l’intera società.
Nell’Europa occidentale non è affatto così, la società ha caratteristiche più complesse e articolate, sottolinea Gramsci. Acuto interprete di una realtà che, come quella italiana, nel bene e nel male ha la sua specificità rispetto ad altre esperienze europee, Gramsci ritiene che con queste ultime – Gran Bretagna, Francia, Germania – essa condivida un vigoroso sviluppo della società civile caratterizzato da una sostanziale autonomia nei confronti dello Stato, almeno in una serie di ambiti. Da quello storico, con quella fioritura civile che le città italiane hanno ereditato dall’esperienza politica dei Comuni fino all’ambito culturale in senso lato, compreso dal Sette/Ottocento quello religioso.
Venendo al rapporto di Gramsci con la sociologia, sul piano della consapevolezza Gramsci è un critico di questa disciplina ma ciò non gli impedisce di fare spessissimo della eccellente sociologia. Influenzato dal magistero crociano, nei Quaderni non può non rinnovare le critiche a una scienza (“inferma” la definirà don Benedetto trent’anni dopo) che nel nostro Paese, ancora nel secondo decennio del Ventunesimo secolo si attardava in interpretazioni paleo-positiviste, rudimentali e grossolane. A suo tempo non era stata del tutto sterile la stagione dei Ferri e dei Lombroso. Anche generosi in certe prospettive di riforma sociale, essi esprimevano una confusa vicinanza al socialismo fondata più sul sentimentalismo romantico che sul contributo di solide analisi logiche e sperimentali. A maggior ragione, negli anni Dieci, Venti e Trenta del Ventesimo secolo una simile visione è divenuta francamente insostenibile, completamente superata. In realtà essa lo era dal 1904, quando Croce e Gentile si scambiano lettere rivelatrici, nelle quali orchestrano la rivincita basata su quella che, a detta loro, è la “chiarificazione” neo-idealista, ovvero la liquidazione dell’esausto e acritico positivismo italiano. In effetti nei primi due-tre decenni del Ventesimo secolo il positivismo italiano è rappresentato da personaggi come Achille Loria, vero idolo polemico di Gramsci, calamita dei suoi strali a causa degli irresponsabili teoremi capaci di tutto, ad esempio di mettere in correlazione l’altitudine terrestre con fenomeni sociali quali la lingua e la morale (così che il mancato uso delle doppie da parte dei veneti viene imputato alla loro vicinanza con il mare e, per distogliere i libertini dai loro vizi, sarebbe stato consigliabile elevarli di quota facendoli viaggiare in aeroplano). Paradossi, per carità (Loria non era poi così stupido da volerli presentare altrimenti) ma tuttavia significativi della confusione e della irresponsabilità su aspetti altrimenti seri o nessi causali, in ordine cioè alla pietra angolare del ragionamento scientifico.
È una circostanza sfortunata e resta un motivo di rimpianto che Gramsci non abbia potuto conoscere le fonti vive della sociologia del suo tempo, a cominciare dalla più ovvia delle ragioni consistente nel fatto che, negli anni Trenta, egli era ristretto in prigione, poteva leggere soltanto alcuni libri e poche riviste tra cui «La Civiltà Cattolica» dei padri gesuiti, fonte di buona qualità e numerosi stimoli intellettuali ma indubbiamente un po’ unilaterale, non tale da dare conto del panorama europeo di interpretazioni che andavano fiorendo nella filosofia e nelle scienze sociali. Lasciamo stare il Circolo di Vienna e tutto il resto di ciò che in quegli anni si muoveva in Europa, che Gramsci non ha potuto conoscere per esperienza diretta ma soltanto intuire, Weber però aveva già prodotto la sua interpretazione storica, risalgono ai primi del Novecento i suoi scritti sul metodo, alcuni suoi allievi e seguaci frequentavano l’Italia, Roberto Michels vi viveva in pianta stabile. Successo degli aguzzini il cui compito era quello di “impedire a questo cervello di funzionare”, Gramsci deve limitarsi a intuire, dalle reazioni del buon padre Brucculeri, quello che non gli è dato leggere e ascoltare direttamente. È così che, purtroppo, agli occhi di Gramsci passano per produzioni sociologiche le miscellanee degli ultimi positivisti, per non parlare del manuale di “sociologia” di Bucharin, tutte produzioni di livello men che modesto, generalmente improntate a un naturalismo disarmante.
La cosa paradossale è che alcuni punti di contatto con tale situazione si ripropongono, fatte le proporzioni, negli anni Cinquanta. Analogamente a Gramsci e con i vincoli in cui operava, ma senza le sue giustificazioni, vent’anni dopo di lui i dirigenti del Partito Comunista che ne guidano la politica culturale, come Alicata, scendono in campo contro una sociologia che non è la disciplina che in quel momento in vari paesi del mondo, innanzitutto ma non solo negli Stati Uniti, sta facendo passi da gigante. C’è un riduzionismo nelle polemiche contro le scienze sociali, da parte del PCI, per cui tutto si concentra sulla parte concettualmente più debole (e tuttavia da non disprezzare se non altro per un suo sforzo di verifica empirica) rappresentata dalla Sociologia del lavoro, nella variante della scuola delle Relazioni Umane, i cui limiti erano macroscopici e peraltro chiari a molti scienziati sociali anche negli Stati Uniti. Già Lynd nel 1949 aveva parlato di «scienza delle relazioni disumane» in riferimento agli studi di Elton Mayo utilizzati dall’Esercito americano.
La cosiddetta “scienza” delle Relazioni Umane (come del resto la cosiddetta “organizzazione scientifica del lavoro” di Taylor, di cui le Relazioni Umane volevano rappresentare l’alternativa), sono delle proposte di natura essenzialmente gestionale basate su esperimenti a tutt’oggi non privi di un certo interesse, ma che naturalmente nel corso degli anni sono stati riletti criticamente, separando la dimensione meramente aziendalistica da quella conoscitiva (essa stessa densa di imperfezioni). Osservare (nel 1927) come si comporta un gruppo di operaie al banco di lavoro mentre assembla i relay è, anche metodologicamente, pur sempre un passo avanti rispetto all’idealismo spinto di una intellettualità italiana che negli anni Cinquanta sulla fabbrica costruisce un’intera ideologia politica, ma non ci ha mai messo piede. Oggi una simile polemica può far sorridere, però dobbiamo riscontrare che – come con ponderatezza e concretezza fa Lopez in questo libro – tranne alcuni quadri bassi e intermedi del PCI di origine operaia, molti tra i grandi intellettuali “organici” al Partito, non avevano chiari i termini della questione sulla quale imperniavano il loro ragionamento politico, cioè non conoscevano la fabbrica.
Per esempio, la conoscevano meglio alcuni intellettuali critici, marxisti e non, che, non solo avevano fatto la loro esperienza alla Olivetti di Ivrea. Una realtà molto particolare, molto strana quest’ultima. Vogliamo dirla tutta? Persino ambigua, per alcuni versi. Questo riformismo comunitario di Adriano Olivetti che non si limita, appunto, a gestire la forza lavoro in fabbrica in modo liberale, aperto, evoluto, ma addirittura si preoccupa del benessere materiale e morale del dipendente curandone tutti gli aspetti (un bel passo avanti rispetto al fordismo, che pure praticava una politica di alti salari con cui fidelizzare una forza lavoro impegnata in mansioni ripetitive e alienanti). Olivetti fa scalpore perché opera in Italia, nelle condizioni di arretratezza da cui il Paese usciva dopo vent’anni di fascismo, mentre anche le sue innovazioni vanno contestualizzate all’interno delle tecniche gestionali di un’azionista e di un management illuminati che agiscono nella modernità. Fatto sta che tutte le applicazioni delle scienze comportamentali al lavoro non vengono studiate e capite per ciò che sono, né per la quota di ambiguità o addirittura di insidia che contengono, né per quanto di novità presentano: il bando è pregiudiziale e assoluto: la loro è l’«ideologia dei monopoli». Questa è la definizione che dà Alicata nel documento del CC del Partito Comunista italiano del 1955. A meno di un anno dal XX Congresso del PCUS, che innescherà una rilettura critica dell’intera esperienza stalinista e aprirà le porte a un po’ di aria nuova, ancora il vertice del PCI era da questo punto di vista molto conservatore.
Non si andava a vedere da vicino, applicando l’occhio al telescopio, distinguendo e separando ideologia, tecnica gestionale e innovazione scientifica e sociale. Questa, invece, era la posizione di un pugno di intellettuali illuminati, ma isolati, talvolta anche un po’ radicali, come Roberto Guiducci. Personalmente confesso di dovere la riscoperta di questo autore ad Angelina Lopez. Forse è un fatto generazionale, ma l’interesse che ci ispiravano sia la politica sia la sociologia difficilmente si incontrava con i libri di Guiducci. A partire dagli anni Settanta la sua attenzione politica si focalizza su questioni che allora noi trovavamo irrilevanti, mentre nei due decenni successivi i suoi scritti sociologici ci apparivano eterogenei e non approfonditi. Probabilmente accadeva a Guiducci ciò che era accaduto ad altri pionieri come lui, una volta conclusa l’epica fase della Ricostruzione sulle macerie fisiche e intellettuali consegnate dal fascismo: lasciato solo, senza il confronto collettivo che nasce in una scuola, senza una sede di studi superiori di scienze sociali (che tanto avrebbe auspicato e voluto), Guiducci era diventato un poligrafo che, forte di una mente brillante, anticonformista e curiosa di tante cose, praticamente scriveva di molti temi (un rischio comune ad altri noti esponenti della sociologia), con una disinvoltura che non contribuiva all’accreditamento pubblico di una disciplina nuova e avversata da molti. Tuttavia, in un angolo della mia coscienza c’era il dato che questo autore negli anni Cinquanta-Sessanta aveva fatto delle cose importanti per la sociologia, un autore che, invece, conoscevo era Danilo Montaldi, un indiscusso antesignano. Anch’egli non privo di limiti, ma capace di pubblicare nei primissimi anni Sessanta ricerche come, Milano, Corea o Autobiografie della leggera, testi che hanno lasciato una traccia e che ci hanno indotto a riflettere. Sia Guiducci che Montaldi erano ricercatori isolati, coscienze intellettuali e civili che trovavano sponda non tanto nel Partito Comunista (a parte qualche sua frangia più aperta) quanto nel Partito Socialista, sulle colonne dell’«Avanti!», sulle pagine di «Mondo Operaio»; cui si aggiungeva la serie di riviste da loro fondate, sicuramente interessanti come conferma l’ampio lavoro di scavo compiuto da Lopez, e però effimere, destinate per motivi finanziari a durare un periodo di tempo sempre molto ridotto.
Concludo sottolineando come in questi autori fosse presente quella che era insieme una proposta e una lezione. La proposta interpretativa dell’oggetto, quella scelta che, ci ricorda Weber, è essa stessa, nella libertà del ricercatore: individuare come degno di studio un oggetto piuttosto che un altro, circoscrivendolo, nell’«infinità priva di senso». Ecco, Guiducci e Montaldi fanno una scelta coraggiosa: studiano gli ultimi, studiano quei settori o frammenti di classe che sono ai margini, ma studiano anche la classe operaia vera e propria, perché vanno in fabbrica, distribuiscono i questionari (sulla cui solidità tuttavia non dico nulla, perché lascio al prof. Campelli l’interpretazione definitiva di questi tentativi). Già solo il tentativo è rilevante. A differenza dei molti che saranno loro seguaci, Marx e Engels per primi avevano dentro di sé un’esigenza di validazione empirica. Marx aveva immaginato un questionario (negli anni Sessanta sì, ma dell’Ottocento!) con il quale chiedeva agli operai di fabbrica “fatti e misfatti” delle loro condizioni di lavoro. Engels va nelle fabbriche di Manchester e negli slums di Londra e fa una ricognizione di sociologia urbana e del lavoro che ancora oggi si legge rimanendo a bocca aperta per l’intelligenza, la sensibilità, l’empatia con cui questo industriale tedesco, mosso soltanto da una motivazione di tipo etico e civile, si crea una prospettiva interpretativa che non c’era, perché non c’era la sociologia come indagine sul campo.
È molto interessante questo aspetto perché mostra come, anche partendo da un livello macro quale è sempre quello politico si può, sulla base di una propria sensibilità personale, sfociare in quell’ambito, empiricamente così fecondo, che è quello micro. Del resto, anche dal punto di vista politico, parlare di fabbrica, parlare di proletari senza mai avergli rivolto la parola, come è possibile? Forse questo è l’apporto più autentico che la sociologia può fornire al marxismo così come di ogni altra visione del mondo politica o filosofica o religiosa ecc., cioè quello di dire: «andate sul posto e parlate con le persone». Un metodo che i filosofi greci, tanti anni fa, avevano introdotto. Ecco, sono cose che ricercatori come Montaldi, i suoi collaboratori come Alasia, lo stesso Guiducci, fanno: andare sul campo. Andare sul campo è la grande ed elementare scoperta, che certamente in Italia è stata tardiva, talché abbiamo dovuto aspettare a lungo perché ciò avvenisse e avvenisse con un approccio diverso da quello, pur pregevole, della letteratura. Perché qui c’è l’altro rischio, c’è quello populistico di acquisire per scientifiche le pagine suggestive di Rocco Scotellaro, le pagine acutissime di Carlo Levi, che si leggono con grande godibilità. Certamente le due dimensioni devono e possono convivere, però – lo dico da dilettante di letteratura a mia volta – distinte, cioè queste miscele, questi cocktails di prospettive, a mio parere, non fanno bene né all’una né all’altra prospettiva.
Ai nostri giorni, è ovvio, sarebbe troppo facile sottoporre a test metodologici rigorosi autori che operano negli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso, cioè in condizioni particolari, diciamo embrionali ed esplorative. È la base di partenza quella che conta. Al primo Congresso nazionale di scienze sociali che si svolge a Milano nel 1958 l’intervento di Montaldi contiene i segni distintivi di una forte consapevolezza, seppure autogestita, per così dire, auto-inventata: «il metodo sociologico di interpretazione è estraneo sia al riformismo [nel senso polemico che lui dava a questo termine di compromesso col padronato] ma anche allo stalinismo perché lo stalinismo riposa su una concezione fatalistica del progresso e sulla promessa di una rivoluzione dall’alto». Queste parole contengono i presupposti per leggere da sinistra la sociologia, un tentativo un poco acrobatico, ma generoso e non totalmente fuori bersaglio. In fondo la sociologia, proprio per il fatto di rivolgersi agli attori, dà la parola ai protagonisti e quindi non si sostituisce (o almeno auto-limita significativamente la propria sostituzione) ad essi, come rischia di fare invece l’ideologia politica, in particolare nella concezione leniniana (rispetto a cui la tragedia staliniana non può considerarsi una mera e casuale degenerazione, sebbene nel gruppo dirigente bolscevico altre tendenze avessero maggiore intelligenza dei rischi del potere e qualche scrupolo morale in più).
Fatto sta che il dialogo marxismo-sociologia, preconizzato da Montaldi e da Guiducci, nei decenni successivi avrebbe dato qualche frutto. Il libro di Angelina non ne parla (un compito per lei, eventualmente, in futuro), ma in Italia è esistita tutta una fase successiva nella quale indubbiamente si sono creati momenti di confronto e di dialogo. Il Partito Comunista, i marxisti mainstream della scuola italiana hanno progressivamente accettato di misurarsi con quelle che, ancora dieci anni prima (lo ricordano Balbo, Chiaretti e Massironi nel libro del 1975 L’inferma scienza) erano considerate «americanate», tutto quello che di sociale, economico, culturale non era nel verbo del Partito erano «americanate». Un epiteto non incongruo applicato a tanti vademecum delle Relazioni Umane oggi illeggibili; cosa ben diversa era – per usare la banalissima metafora cara a quella cultura – gettare il bambino con l’acqua sporca. Ringraziamo quegli intellettuali eterodossi che sessant’anni fa hanno avuto il coraggio di dire: non gettiamo tutto, perché c’è molto da salvare in queste elucubrazioni dei sociologi.
Enzo Campelli
C’è un elemento biografico nella vicenda del libro che oggi si presenta che mi fa piacere presentare prima di ogni altra considerazione. È stato un privilegio per me seguire, in anni molto lontani, la stesura di un primo testo di Angela Lopez nella forma della sua tesi di laurea, dal quale poi – in piena autonomia e con molto lavoro successivo – è poi maturato questo.
E questa è la prima cosa che vorrei mettere in evidenza. Angela in questi anni ha tenuto duro, ha avuto un’ostinazione straordinaria, ha fatto crescere il suo lavoro, ha continuato a migliorarlo, sfidando disattenzioni del “sistema” ed anche una certa inattualità del tema. Io credo che questo vada ricordato, perché questa generosità traspare dalle pagine del lavoro: la generosità di un impegno non solo di lavoro, ma anche personale, di vita, un impegno di vita. Questo libro è innanzitutto un documento che manifesta e traduce un progetto di vita.
Del resto, il tema stesso del libro comporta una vocazione biografica, autobiografica. È impossibile sfuggire a questa sensazione. In filigrana c’è la storia del Paese, c’è la storia della cultura di sinistra, della sinistra che avrebbe potuto essere, della sinistra che è stata, della sinistra che non è stata, in anni complicatissimi – il XX Congresso del Partito Comunista sovietico, la destalinizzazione, i fatti di Ungheria, l’«indimenticabile» anno ’56 – e dai quali poi è derivato un clima che ha pesato moltissimo sulle generazioni successive, sulla mia generazione. C’è un insopprimibile elemento biografico ed autobiografico nel riandare ad anni che sono stati molto vicini a quelli della formazione di ciascuno di noi, dell’uscita, per così dire, sul piano pubblico di alcuni di noi. Io avevo molto meno della metà degli anni che ho adesso quando ho scoperto Montaldi, che Angela Lopez tratta con molta competenza, e che per me è stata una scoperta straordinariamente intensa in quegli anni e che mi ha accompagnato a lungo; non ho mai dimenticato, e forse ho subito troppo il fascino di certe pagine di Montaldi. In ogni caso – chiusa questa piccola parentesi biografica che peraltro non è solo personale, ripeto, ma che ha a che fare forse con la resa dei conti culturale, politica, civile di tutta una generazione – direi che il libro ha molte dimensioni, è un libro che si può percorrere a diversi strati.
Innanzitutto c’è la prima parte, che tratta della cultura di sinistra e del grande dibattito che su questo tema viene aperto dal saggio di Guiducci su «Nuovi Argomenti» (novembre-febbraio 1955-56): un testo che costituisce uno schiaffo fortissimo alla cultura dell’establishment, alla cultura del Partito e di un Partito particolarmente vigile e chiuso. Si apre allora un dibattito feroce – feroce mi sembra la parola giusta – nel senso che implica, comporta una partecipazione fortemente sentita, in termini anche di affettività, da grandi importanti intellettuali, tutt’altro che privo di attacchi personali, di censure violente, dei segni di crisi di una “disciplina” che stenta a mantenere se stessa, e che poi viene chiuso da un intervento di Alicata ne «Il Contemporaneo» del ’56. Viene chiuso d’autorità, cioè senza che abbia una fine, intendendo come fine uno svolgimento che arrivi a sintesi: viene semplicemente chiuso d’autorità, eppure aveva investito delle riviste molto importanti, cito solo «Ragionamenti», «Opinione», «Passato e Presente», lo stesso «Il Contemporaneo» in qualche misura, «Nuovi Argomenti» e l’«Avanti!». Ecco, questo è, direi, il primo punto che Angela ricostruisce con grande precisione non soltanto citando, ma commentando con attenzione i testi che cita, mostrandone non solo lo spessore ideologico e le relative implicazioni politiche e culturali, ma anche la valenza importante dal punto di vista della passione umana che il dibattito mostra. Non fu infatti solo un dibattito tra idee, ma ne conseguirono fatti e destini personali.
Il secondo punto è il rapporto tra sociologia e cultura di sinistra. Un rapporto segnato da un doppio equivoco, perché da una parte, in nome dell’idealismo, si rifiutava la tradizione positivista – il prof. Battistelli giustamente poneva l’accento sulla tradizione del positivismo italiano del Novecento – che pure è anche quella in realtà assai ricca perché certe indagini sul Meridione, certe indagini sulla condizione dei lavoratori, anche fatte in quelle epoche e con quella chiusura mentale, sono comunque preziose; io credo tutt’ora che il positivismo italiano dei primi decenni del secolo abbia delle perle nascoste fra tanta confusione. Ma l’equivoco veniva dal considerare nemico della cultura di sinistra il positivismo: equivoco grave, io credo, se si tiene presente quella che era l’aspirazione originale del positivismo in rapporto alla sua creatura prediletta che è la sociologia. La sociologia nasce con intenti molto concreti, progressivi e socialmente responsabili: nasce per essere strumento di miglioramento della condizione dell’uomo in società, tutt’altro che come esigenza di riflessione astratta e contemplativa. Nasce per essere strumento operativo in intervento sulle “cose”, aspetti e problemi reali della società. È vero, nasce come strumento operativo pensato innanzitutto dalla Terza Repubblica tecnocratica francese, ma le prime ricerche sociologiche, non solo il questionario dell’inchiesta operaia di Marx, ma le prime ricerche sociologiche – parlo della metà dell’Ottocento – sono ricerche estremamente importanti sulla condizione degli operai, per esempio, nelle filande e nelle manifatture di seta e di cotone nella regione parigina: dalle ricerche come quelle di Buret impariamo cose di uno straordinario interesse: la speranza di vita di un operaio delle filande a Parigi nel 1848 era di 29 anni: quella che uno statistico chiamerebbe oggi la speranza di vita alla nascita era 29 anni. Quello che sto cercando di dire è che, in realtà, la sociologia nasce precisamente innanzitutto come esigenza di raccolta di dati “oggettivi” sulla società per migliorare la società. E oggi abbiamo facile gioco a pensare ai positivisti come sempliciotti pieni di illusioni che pensavano a un metodo rigido, autosufficiente, ecc., ma a volte dimentichiamo invece questa fortissima carica utopica che c’era nel positivismo, soprattutto il primo. Utopica nel senso che l’idea era quella che le decisioni non potessero più essere prese dal principe e basta: l’esigenza utopica era quella di mettere a disposizione dati reali su come è davvero la società, su come davvero si lavora: l’inchiesta operaia di Marx – purtroppo poi non eseguita – raccoglieva, pretendeva di raccogliere o sperava di raccogliere delle informazioni estremamente dettagliate sull’organizzazione del lavoro, sulla durata della giornata lavorativa, su i tipi di contratto che legavano gli operai al proprietario e così via. Questo è una parte dell’equivoco, l’altro è quello delle «americanate», cioè l’idea che la sociologia fosse uno strumento di composizione dei conflitti. È un vero peccato che la sociologia di quegli anni – nonostante poi ci sia stata una ripresa – sia stata presa tra questa morsa terribile che ne ha ritardato moltissimo le capacità di sviluppo.
Nel 1958 c’è a Milano il primo Congresso nazionale di scienze sociali, Montaldi partecipa. Partecipa con una nota sui rapporti citta-campagna e subito dopo scrive una nota, che a me sembra molto interessante, in cui rivendica l’idea di Goldman non semplicemente della compatibilità del marxismo con la sociologia, ma, in termini assai più radicali, rivendica l’identità di sociologia e marxismo, cioè rivendica una lettura del marxismo stesso come sociologia e questo credo sia molto importante, nonostante l’ingenuità, nonostante le buone e interessanti critiche che possiamo fare cent’anni dopo, sessant’anni dopo, settant’anni dopo. Qui si apre proprio la seconda parte del libro, cioè la marcia, per così dire – che non è certamente una marcia trionfale, tutt’altro, è una marcia faticosa, è un cammino fra mille difficoltà – «verso una cultura politica della partecipazione»: con Montaldi, ancora una volta, ignorato tanto dalla sociologia “ufficiale” allora, sostanzialmente ignorato tanto dalla sociologia, quanto dalla cultura di sinistra, poi. Montaldi fa parte di uno strato di intellettuali che lavora in maniera sotterranea in quegli anni. Certo che sono isolati dai Partiti, ma sono, in realtà, in stretto contatto con le cellule di base, con i comitati di fabbrica, con piccoli gruppuscoli: c’è una rete nell’Italia soprattutto settentrionale e centro-settentrionale di cellule di lavoratori, con venature anarchiche, con una vitalità estremamente importante e intensa dal punto di vista ideologico. Montaldi avrà dei rapporti con il gruppo di «Socialisme ou Barbarie» in Francia, che era un gruppo, pensate, anarco-trotskista, quindi con grandissima variabilità ideologica all’interno, ma con grande importanza, con grande capacità di proposta.
Io credo che la grande idea di Montaldi sia quella di dar corpo alla proposta della «conricerca», che era stata lanciata da Guiducci in realtà – però mi pare di poter dire che Montaldi si allontani da Guiducci per avvicinarsi piuttosto a Panzieri nel corso del tempo – ma certamente l’idea fondamentale è che la sociologia sia marxismo nella misura in cui è «conricerca». Conricerca cosa vuol dire? Anche qui possiamo sorridere adesso perché ci può sembrare un modo molto volontaristico e velleitario l’idea di superare cristallizzazioni che non sono solo di ruolo ma anche di potere – c’è un rapporto di potere tra il ricercatore e l’oggetto della ricerca. Conricerca vuol dire fare ricerca insieme, quindi cercare di superare la divisione tradizionale tra il sapiente che governa la ricerca e ne usa i risultati, in modo che il ricercatore possa, come Montaldi scrive da qualche parte, farsi «strumento collettivo di conoscenza». Era un’idea, secondo me, straordinariamente importante questa della conricerca e Montaldi cerca di praticarla. Lo fa innanzitutto con uno scritto del 1954 che si chiama Operai parlano della condizione operaia, qui ancora una volta era il risultato, la versione italiana di una ricerca che era stata promossa in Francia nell’ambito del gruppo di «Socialisme ou Barbarie»: questa rivista francese aveva sollecitato operai a scrivere le loro memorie, quindi al di là di ogni controllo gerarchico, al di là perfino anche – questo è certamente un punto su cui ritorneremo se avrò tempo – al di là anche di ogni rigore metodologico. L’essenziale era che questa conricerca permettesse la riappropriazione della voce, del senso, della denuncia da parte di strati subalterni della società, e questo è ciò che Montaldi cerca di fare con almeno tre grandi indagini: Milano, Corea, Autobiografia della leggera che sono del ’60 e del ’61 e Militanti politici di base.
Prima – ed è una cosa di cui non si parla mai, se mi permettete un piccolissimo inciso – in realtà questa esperienza della produzione di materiale biografico da parte di operai e contadini aveva avuto un precedente in Polonia, stranissimo e assai poco citato, di grandissima ricchezza. Qualche dato velocissimo. Già nel 1921 in Polonia erano state organizzate delle raccolte, su base volontaria, di autobiografie di operai e contadini. La Polonia in quel momento è un territorio in grandissimo e velocissimo mutamento, in cui la popolazione rurale nell’arco di trent’anni si dimezza: possiamo solo immaginare che cosa significhi dal punto di vista della destrutturazione e di ricostruzione di un tessuto sociale già questo solo dato statistico. Ma il fatto importante è che questa abitudine delle memorie viene poi ripresa dopo la guerra e produce una enorme quantità di materiale: ci sono quasi cinquecento di queste raccolte in un testo che di chiama Memorie di contadini, quasi ottocento in Memorie di disoccupati, seicento in Disoccupazione fra contadini. Queste raccolte erano fatte sulla base di una scaletta, cioè il ricercatore diceva: «parlatemi della vostra vita quotidiana, del lavoro, dei figli, dell’educazione, del cibo, delle feste, delle abitudini» e così via, componendo un quadro di una ricchezza straordinaria. Questa pratica – dicevo – riprende dopo la guerra e abbiamo sei iniziative nel ’56, sette nel ’57 e poi negli anni successivi otto, dieci, undici, trentaquattro, cinquantacinque, ci sono addirittura nel ’66 duecentosessantanove raccolte di questo tipo. Si calcola, lo calcola la Commissione Scientifica delle Memorie polacca, che abbiano partecipato a queste iniziative circa 200.000 persone ed erano state, nel ’66, raccolte la cifra veramente incredibile di due milioni di cartelle dattiloscritte di personaggi, operai, contadini: classi subalterne – si diceva, si può forse ancora dire – che documentano biograficamente questi enormi cambiamenti culturali, sociali, economici della Polonia. Niente di simile è stato mai tentato, ed è un gran peccato, per esempio in riferimento al nostro Meridione.
Ma comunque, questo citavo solo per dire che questa idea di Montaldi è un’idea di grande ricchezza, che lui porta avanti in queste indagini non come momento staccato rispetto alla sua attività politica. Questa attività di ricerca sociale da parte di Montaldi, il suo essere sociologo – ma Sergio Bologna ha scritto in una pagina molto bella: «non c’è vigliaccata peggiore che dargli del sociologo» – coincide in lui con la dimensione stessa del suo essere socialista, e incontrerà ovviamente opposizioni. Ci saranno anche errori: non c’è dubbio che dal punto di vista strettamente metodologico il lavoro di Montaldi, per quanto generosissimo, non risolva tutto quello che promette di risolvere, non risolve il problema dell’alterità. Però ha una sua maturità metodologica che a me piace sottolineare in questo momento, nonostante, appunto ribadisca, tante critiche si possono fare. Montaldi riesce a mettere a punto un progetto, la conricerca, la ripartecipazione collettiva, e riesce ad individuare uno strumento coerente con questo progetto che è la conricerca, che è la biografia: dal punto di vista metodologico chiude perfettamente il cerchio. Nella discussione metodologica non c’è mai un assoluto metodologico, ma solo considerazione di validità strumentale al proprio progetto conoscitivo, e che Montaldi abbia lucidamente capito ciò che serviva al suo progetto e l’abbia perseguito con generosità e lucida intelligenza della situazione.
Due parole prima di concludere. Che cosa è successo all’approccio biografico dopo?
Io ho una teoria, mi sembra che dopo gli anni Sessanta o gli anni Settanta-Ottanta l’approccio biografico nella ricerca, non solo italiana, abbia seguito un andamento carsico, come dire, appare e scompare. Ho una teoria su questo apparire e scomparire che ha a che fare con la misura in cui il ricercatore – penso al ricercatore collettivo – si senta sicuro del suo controllo sul processo di ricerca. Quando si sente culturalmente, ideologicamente sicuro del suo controllo sul processo della ricerca, in quei momenti l’indagine biografica scompare; nei momenti di grande intensità, di grande cambiamento culturale, di grande mescolamento di carte, quando il ricercatore tende a non essere più certo di questa sua posizione di controllo, di controllo politico, di controllo ideologico, quando sente di non essere più titolare di un potere forte sulle indagini allora il biografico torna. Probabilmente il biografico ha una funzione importante di antidoto contro questa pretesa di separatezza che il ricercatore nella sociologia spesso ha rispetto agli “oggetti” dell’indagine. Basta pensare a una espressione orribile come quella di “somministrazione” del questionario: le parole non sono mai del tutto gratuite, ma in tutti i testi di metodologia si dice che un questionario viene “somministrato”, senza badare all’asimmetria e forse addirittura all’autoritarismo che è implicito in questa espressione, come se fosse una medicina che il ricercatore sapiente somministra all’oggetto inconsapevole.
Cos’è successo dopo? Poco, secondo me, ed è anche questa un’occasione perduta. C’è stato un grande revival alla fine degli anni Settanta, ma peggiorativo, io credo, rispetto alla stagione di Montaldi, e non solo di Montaldi peraltro, di Vallini, di Cagnetta, di tanti altri, nel senso che almeno quelli avevano una forte tensione politica, non avevano rigore metodologico, ma avevano forte tensione politica, qui intendo anche etica non soltanto ideologica. Negli anni Settanta, alla fine degli anni Settanta quella stagione triste di ricorso al biografico non ha né il rigore metodologico, secondo me, e né questo afflato. E qui forse si ritorna un po’ alla sociologia. Personalmente detesto tutte queste lacrimevoli e ricorrenti lamentazioni sulla “crisi” della sociologia, però poco fa col prof. Battistelli si diceva che forse si è un po’ chiuso un ciclo culturalmente. È certo che i sociologi, almeno in Italia, non hanno fatto tutto quello che avrebbero dovuto fare, non hanno fatto tutto quello che era forse possibile e necessario, e che sarebbe stato reso praticabile dal loro sapere sociologico. Soprattutto oggi, a me pare e su questo concludo, oggi che molti sociologi pensano che il loro compito sia semplicemente quello di scrivere “narrazioni” su ciò che accade. Questa parola narrazione che viene ripetuta spesso con una leggerezza, con un margine che a me sembra gravissimo di irresponsabilità. Il compito del sociologo non è quello di fare narrazioni o racconti sulla società, ma quello di fare analisi teoricamente fondate e metodologicamente provvedute. A me piace ricordare Montaldi ancora in questo perché – sebbene non ci sia dubbio che qualunque studente di metodologia possa rinfacciargli il fatto che il campione non è rigoroso, che l’intervista è sbilanciata e così via, cioè un sacco degli errori che sono descritti nei manuali – nonostante questo rimane questa tensione straordinariamente importante, la consapevolezza decisiva che il compito che si era assunto non era semplicemente quello di narrare o di far narrare, ma quello di ricavare da questo lavoro un significato che fosse impegno per cambiare le cose nella società.
Fabrizio Battistelli
Vogliamo sentire le controdeduzioni dell’imputata? Oppure, se qualcuno del pubblico ha qualcosa da dire … Da parte mia aggiungerei qualcosa, stimolato da quanto detto dal collega Campelli, rispetto al fatto che non possiamo neanche accentuare troppo questa convergenza fra sociologia e politica, in particolare politica progressista, politica addirittura di classe. Dato che a Montaldi non sfuggiva (anche se non era da ostentare), esisteva una dimensione competitiva nel rapporto tra la sociologia e la dottrina politica in genere e il marxismo in particolare, nel senso cioè che i marxisti ortodossi provavano forme di diffidenza e vedevano un competitor, non del tutto infondatamente, nella sociologia. Questa appariva un’interpretazione della realtà che in certi casi poteva anche convergere nel miglioramento di alcuni aspetti relativi alla condizione dell’attore sociale, a cominciare dal più sfruttato di tutti che era l’operaio, ma con un approccio molto diverso da quello politico. Bisogna aver conosciuto qualcosa del Partito Comunista per sapere di un Partito molto evoluto sul piano organizzativo, strategico e della competenza politica, ma anche intrinsecamente, autoritario e intransigente in tema di ortodossia. Uno dei principi base era quello, mutuato dal Che fare? secondo cui il primo avversario da combattere è quello più vicino. Io non ricordo rare polemiche, a parte ovviamente la ferma presa di posizione antifascista, con il pensiero borghese moderato e conservatore. Ricordo le polemiche, peraltro abbastanza rituali e improntate a un rispetto di fondo, con la Democrazia Cristiana, e infine le polemiche, esse sì veramente spietate, verso qualunque interpretazione che rappresentasse una pur potenziale alternativa, in seno alla sinistra, che non appartenesse alla sinistra “certificata”, cioè al PCI stesso.
Enzo Campelli
Quello stesso articolo di Alicata ha un titolo significativo, quello con cui lui chiude il dibattito si intitola non troppo gramsciani, ma Troppo poco gramsciani.
Fabrizio Battistelli
Spiace dirlo, ma si tratta spesso di personalità che, pur organici al Partito, poco avevano capito di Gramsci. Nei Quaderni Gramsci avanza una critica costante nei confronti della Chiesa cattolica o del fascismo, è ovvio, ma lo fa anche con lo stalinismo sebbene debba essere prudente quando parla di “Giuseppe Bessarione” (Stalin), non soltanto per timore del censore fascista. Solo il grande carisma politico e morale di Antonio Gramsci gli ha evitato, allora e in seguito, indagini sul suo quoziente di leninismo. Realmente, l’esperienza dei Partiti Comunisti della Terza Internazionale è stata improntata ad un forte settarismo. Ma lo diciamo pacatamente.
Enzo Campelli
Ora lo diciamo pacatamente …
Angelina Lopez
Concludiamo qua?
Enzo Campelli
Penso che possiamo concludere qua.
Grandi ringraziamenti rinnovati all’autrice che ci ha fatto fare, come si diceva prima, un piccolo viaggio dentro di noi e nella nostra storia, mancata e no.
Fabrizio Battistelli
Bene, grazie.
Category: Dibattiti, Storia della scienza e filosofia